Inidoneità parziale sopravvenuta e mantenimento dell’occupazione
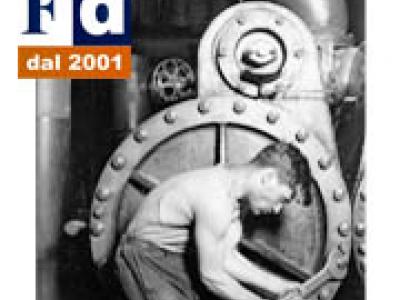
Abstract: Si dà conto del progressivo maturare ed affermarsi - prima nella giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite poi nel legislatore nazionale con la legge n. 68/1999 - del più solidaristico, quanto più giuridicamente corretto, orientamento assertore - in caso di sopravvenuta inidoneità parziale di durata indeterminata per flessione dello stato di salute psico-fisica del lavoratore - della necessità di sostituire al licenziamento automatico per asserita carenza di interesse datoriale all’adempimento parziale ex articolo 1464 del codice civile, la ricollocazione, cd. rêpechage, del soggetto minorato, in mansioni diverse (sempreché sussistenti in azienda), anche inferiori rispetto alle originarie con il consenso dell’interessato, stante il superiore valore del mantenimento dell’occupazione sul divieto di demansionamento ex articolo 2103 del codice civile.
1. Dalla licenza a disfarsi del lavoratore divenuto parzialmente inabile alla più civile affermazione di un obbligo aziendale di rêpechage in mansioni confacenti con il ridotto stato di salute, sempreché sussistenti in azienda
Prima della fine del secolo scorso - per la precisione, antecedentemente alla sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998, resa dalle sezioni unite della Cassazione - il lavoratore che, nel corso dello svolgimento del rapporto, fosse divenuto inidoneo alle mansioni precedentemente disimpegnate, a seguito di flessione dello stato di salute determinativo di una parziale inabilità psico-fisica (di durata indeterminata e non temporanea e comunque non ascrivibile a colpa datoriale), non aveva alcun diritto a che l’azienda si attivasse per mantenerlo in organico, eventualmente ricercando - tra le molteplici mansioni sussistenti e disimpegnabili in azienda - una di quelle che risultasse confacente con il suo menomato stato di resa lavorativa.
L’orientamento della Cassazione era assestato, in prevalenza, sulle seguenti, oscurantiste, affermazioni di principio: “La sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per definitiva perdita parziale della capacità lavorativa, di svolgere le mansioni affidate, legittima il recesso del datore di lavoro, trovando applicazione la norma di cui all’articolo 1464 del codice civile sull’impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici; in tale ipotesi il datore di lavoro non è tenuto a provare l’inesistenza nell’azienda di mansioni compatibili con tali ridotte capacità, in assenza di un principio che consenta di ritenere il datore medesimo gravato dall’onere di reperire posti di lavoro confacenti anche mediante lo spostamento di altri dipendenti” (così, Cass. 21 maggio 1992 n. 6106); ed ancora: “La sopravvenuta impossibilità fisica, o psichica, del lavoratore di svolgere le mansioni, per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell’impresa, non comporta il diritto del medesimo di ottenere l’assegnazione a nuove o diverse mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale, ma, anzi, può giustificare il recesso dell’imprenditore, senza che egli abbia l’onere di provare che nell’azienda non vi siano altri posti di lavoro con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore”(così, Cass. 18 marzo 1995 n. 3174), con la variante, secondo cui: “La sopravvenuta impossibilità fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell’impresa costituisce - ove non sia collegabile a casi di sospensione legale del rapporto e si prospetti di durata indeterminata o indeterminabile - giustificato motivo obiettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/1966, di recesso del datore di lavoro, il quale non è tenuto a provare l’inesistenza nell’azienda di mansioni compatibili con le ridotte capacità del dipendente” (così Cass. 13 marzo 1996 n. 2067), ovvero, in senso del tutto conforme: “La sopravvenuta impossibilità fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni, per le quali è stato assunto o alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell’impresa, non comporta il diritto di ottenere l’assegnazione a nuove o diverse mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale, e può, anzi, giustificare il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo, senza che questi abbia l’onere di provare che nell’azienda vi siano altri posti con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore, tenuto presente che la valutazione circa la sussistenza di un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, prevista dall’articolo 1464 del codice civile in relazione all’ipotesi di prestazione diventata parzialmente impossibile, attiene all’ambito della discrezionalità del destinatario della prestazione” (così Cass. 6 novembre 1996 n. 9684).
In buona sostanza la prevalente giurisprudenza di legittimità dell’epoca era giunta a far discendere la legittimità della risoluzione del rapporto del lavoratore (incorso in situazione di sopravvenuta inabilità parziale al lavoro) sulla base dell’articolo 1464 del codice civile in luogo che ricondurre l’ipotesi risolutiva del rapporto sotto l’articolo 3 della legge n. 604/66, cioè entro l’ambito del “giustificato motivo oggettivo”, notoriamente implicante il tentativo datoriale di rêpechage del lavoratore, cioè di reperimento di eventuali diverse mansioni o posizioni di lavoro ove lo stesso potesse essere reimpiegato utilmente, sempreché organizzativamente sussistenti e senza doverle creare ad hoc, in funzione assistenziale.
Accanto alla posizione prevalente sopra riferita non mancavano, tuttavia, sporadiche e minoritarie decisioni di Cassazione (cfr. Cass. 23 agosto 1997, n. 7908, in Mass. giur. lav. 1997, 871, con nota di A. Riccardi e Cass. 3 luglio 1997 n. 5961, in Lav. prev. oggi, 1997, 2375 con commento adesivo di M. Meucci a pag. 2398) che riconducevano l’eventuale risoluzione del rapporto, per inidoneità sopravvenuta alle originarie mansioni, al giustificato motivo oggettivo condizionato al cd. rêpechage, così come opinioni dottrinarie che ritenevano preferibile all’automatico licenziamento (per carenza d’interesse datoriale ad un adempimento parziale) quello condizionato ad una previa verifica di riutilizzo in mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con la minorazione, secondo un’ottica di mantenimento dell’occupazione per il malcapitato, onerando il datore di lavoro della prova della loro ricerca in azienda, senza tuttavia imporgliene la creazione qualora non presenti e non utilmente assegnabili.
Il delineato contrasto di opinioni determinò l’intervento delle sezioni unite della Cassazione che, con la decisione n. 7755 del 7 agosto 1998 (pubblicata, tra l’altro, in Lav. prev. Oggi, 1998, n. 11, 2012 con nota adesiva di M. Meucci, Obbligo di ricollocazione in altre mansioni del lavoratore colpito da sopravvenuta inidoneità, ivi 1998, 2059), ribaltando un orientamento ultradecennale legittimante il licenziamento del lavoratore, ex articolo 1464 del codice civile, divenuto inidoneo al disimpegno delle mansioni assegnategli, affermò che, anche per tale fattispecie, vige l’obbligo di repêchage asserito come condizione propedeutica per il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (ex articolo 3, l. n. 604/1966).
Il datore di lavoro, per essere più chiari, prima di poter licenziare per sopravvenuta inidoneità alle mansioni assegnate originariamente al lavoratore deve, quindi, necessariamente sperimentare la possibilità di un reimpiego del medesimo in altre mansioni più consone al suo stato di salute, sempreché sussistenti in azienda, ed al limite anche in mansioni inferiori – con il consenso dell’interessato – in vista di salvare il bene dell’occupazione, superiore a quello della dequalificazione professionale, condizione oramai ritenuta valida per non incorrere nel divieto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2103 del codice civile, contemplante la nullità di “patti contrari” finalizzati al declassamento.
Le sezioni unite così motivarono la svolta rispetto all’impostazione precedente: «Nel rapporto di lavoro subordinato la tutela dell’interesse del lavoratore all’adempimento trova il suo fondamento nei richiamati articoli 4 e 36 della Costituzione e serve quale criterio di interpretazione e di determinazione secondo buona fede degli effetti del contratto, il quale dà luogo non solo ad un rapporto di scambio ma inserisce il prestatore nella comunità d’impresa e destina la sua prestazione all’organizzazione produttiva. Ne discende che l’evento impeditivo, quale la sopravvenuta inidoneità ad una certa attività, dev’essere valutato, quanto alle sue conseguenze, in relazione agli obblighi di cooperazione dell’imprenditore-creditore, così tenuto non soltanto a predisporre gli strumenti necessari all’esecuzione del lavoro ma anche ad utilizzare appieno le capacità lavorative del dipendente nei limiti dell’oggetto del contratto, ossia nei già detti limiti posti dall’articolo 2103 del codice civile.
«Ciò induce a non accogliere la tesi secondo cui, divenuta parzialmente impossibile la prestazione lavorativa, il residuo interesse all’adempimento debba essere apprezzato soggettivamente – senza alcuna possibilità di controllo da parte del giudice, interprete del contratto – dall’imprenditore/creditore, a cui spetterebbe perciò un diritto potestativo di recesso, con la corrispondente situazione di mera soggezione del lavoratore. Ammesso che l’infermità dia sempre luogo ad un’impossibilità parziale e non anche, talora, ad un semplice mutamento qualitativo della prestazione, è da osservare che la tesi dell’apprezzamento soggettivo di tale interesse è stata seguita in giurisprudenza con riferimento a contratti di scambio, quale la vendita…, ma non è sostenibile per il contratto di lavoro, ove l’oggetto della prestazione coinvolge la stessa persona umana ed ove i già richiamati valori costituzionali impongono una ricostruzione dei rapporti d’obbligazione nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa e secondo la clausola generale di buona fede, tale da attribuire con diversi criteri gli obblighi di cooperazione all’imprenditore.
«Sarà perciò il giudice di merito che, avuto riguardo alle residue capacità di lavoro del prestatore ed all’organizzazione dell’azienda come definita insindacabilmente dall’imprenditore, valuterà la persistenza dell’interesse alla prestazione lavorativa, secondo buona fede oggettiva».
Sono le medesime conclusioni cui era giunta in precedenza una parte della dottrina – sebbene con differenti argomentazioni - quando, criticando il vecchio orientamento, asseriva che: «Le conclusioni raggiunte dall’orientamento rigorista, su di un piano di stretto diritto privato, vanno pertanto armonizzate con i principi pubblicistici in tema di promozione e difesa dell’occupazione (articolo 4 Cost.), di non emarginazione e di integrazione sociale, di non colpevolizzazione delle minorazioni e delle flessioni dello stato di salute, principi tutti implicanti l’adattamento della prestazione – nei limiti di un riscontro organizzativo – alle mutate condizioni di salute del lavoratore. Il che significa che l’azienda non dovrà certo creare – per mero assistenzialismo – posizioni superflue ma che, al verificarsi dell’evento della “inabilità parziale”, essa dovrà verificare al suo interno se sussistono effettive incombenze o posizioni di lavoro compatibili con la menomazione ove egualmente impiegare, con apprezzabile proficuità, il lavoratore medesimo e, correlativamente dimostrare, nel caso di ricorso al licenziamento per g.m.o., che esso si è imposto, quale extrema ratio, per l’assenza di alternative. In tal modo – e secondo noi correttamente – viene inserita una così delicata fattispecie nell’orientamento postulante il repêchage, prima dell’estromissione dall’azienda, orientamento consolidatosi …per legittimare, in caso di ristrutturazioni aziendali, il licenziamento per l’identica causale del giustificato motivo oggettivo» (così M. Meucci, nell’articolo Il diritto alla flessibilità delle mansioni accordato dall’articolo 2103 codice civile all’impresa e negato ai lavoratori colpiti da sopravvenuta inidoneità psico/fisica, in Riv. crit. dir. lav. 1996, 35).
In buona sostanza sarà l’azienda a dover dimostrare, come in tutti i casi di licenziamento per g.m.o., l’impossibilità di riutilizzo del lavoratore in altre mansioni - primariamente equivalenti ex articolo 2103 del codice civile e, secondariamente - attesa l’oramai intervenuta legittimazione di pattuizioni di “declassamento concordato o consensuale” (al solo scopo di evitare il licenziamento) - in mansioni anche non equivalenti ed inferiori ma suscettibili di salvaguardare il bene dell’occupazione (più che lo stato di salute), potendo l’imprenditore – secondo le sezioni unite – rifiutare l’assegnazione a mansioni equivalenti (o anche inferiori) quando ciò «comporti aggravi organizzativi ed in particolare il trasferimento di singoli colleghi dell’invalido», precisazione quest’ultima che non inficia assolutamente la posizione della sezione lavoro che aveva suggerito il reimpiego dell’invalido, da attuarsi anche secondo turn-over nelle di lui mansioni stressanti da parte di colleghi meno usurati (così Cass. n. 5961/1997, citata in nota 1).
I principi di diritto, fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7755/1998, in tema di “inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni per sopravvenuta infermità permanente”, sono stati richiamati e tradotti in norma, nella legge 12 marzo 1999 n. 68, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, seguita dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333.
Espressamente i commi 7 dell’articolo 1 e 4 dell’articolo 4, della precitata legge n. 68/1999, sono dedicati ai lavoratori divenuti fisicamente inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di un’infermità che li abbia colpiti successivamente all’assunzione. Mentre, infatti, il comma 7 dell’articolo 1 afferma che: “I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità”; il comma 4 dell’articolo 4 recita, invece, innanzitutto, che: “I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”; statuendo, poi, ancora che: “Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”. “Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. “Qualora per predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8”.
2. L’orientamento in ordine al dovere datoriale di sottrarre il lavoratore da mansioni pregiudizievoli per lo stato di salute
Ora se è stato correttamente affermato che il lavoratore menomato nello stato di salute e divenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni contrattuali non può essere licenziato per il venir meno dell’interesse del datore di lavoro alla residua prestazione ma deve essere ricercata in azienda – senza comportare aggravi organizzativi – la possibilità di un reimpiego in mansioni (più consone al ridotto stato di salute) che il lavoratore può proficuamente disimpegnare, senza pregiudizio per le sue minorate condizioni, non può non sussistere (peraltro, a monte) un dovere datoriale di “prevenire” il deterioramento psico/fisico del lavoratore medesimo a causa delle mansioni svolte.
Quello che si vuol dire è che – dato oramai per scontato che sussiste un dovere dell’azienda di sottrarre i lavoratori “collettivamente intesi” da mansioni o lavorazioni oggettivamente morbigene – a nostro avviso sussiste anche un diritto del “singolo lavoratore”, caratterizzato da una particolare conformazione organica e da una eventuale fragilità, ad esempio, dell’apparato cardio/vascolare (soggetti ad ipertensione arteriosa, ecc.), dell’apparato osteo/articolare (scoliotici e simili), dell’apparato respiratorio (asmatici ed allergici, ecc.), dell’apparato neurologico (soggetti labili, ansiosi, depressi, ecc.) ad essere sottratto dallo svolgimento di mansioni “soggettivamente” pregiudizievoli per la salute, da parte del datore di lavoro cui sia stata notificata e documentata (tramite probante certificazione sanitaria) la potenziale o effettiva dannosità delle mansioni assegnate.
Il problema del “dovere” o “obbligo” datoriale di sottrarre da mansioni pregiudizievoli si sposta dai lavoratori intesi quale “collettività” al “singolo” prestatore di lavoro, giacché determinate mansioni o lavorazioni indifferenti per la collettività – e quindi non oggettivamente morbigene – possono risultarlo per quel “singolo lavoratore”, in ragione ed a causa della sua particolare conformazione o struttura organica.
L’esistenza di tale dovere è desumibile – inequivocamente – dalla sussistenza in capo al datore di lavoro di un obbligo a contenuto amplissimo ed a connotazione “prevenzionale”, costituito dalla prescrizione dell’articolo 2087 codice civile secondo cui «l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che , secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Questo obbligo “prevenzionale” di salvaguardia della integrità psico-fisica si salda e si rafforza con la necessaria lettura dell’articolo 32 Cost. che afferma quale obbligo dello Stato quello della «tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».
Non può, pertanto, che essere considerata oscurantista e superata quella datata giurisprudenza che ha affermato che: «nel caso in cui determinate mansioni o condizioni di lavoro, pur non essendo oggettivamente morbigene – ed essendo quindi esclusa una violazione degli obblighi gravanti ex articolo 2087 codice civile sul datore di lavoro – siano pregiudizievoli per la salute di un determinato lavoratore, determinandone un ricorrente stato di malattia, il datore di lavoro, salva espressa previsione di legge o di contratto, non è tenuto ad adibire il dipendente ad altre mansioni. Conseguentemente è legittimo il licenziamento di quest’ultimo attuato dopo il superamento del periodo di conservazione del posto» (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. 10 novembre 1995, n. 11700, in Mass. giur. lav. 1996, 247; Cass. sez. lav. 13 dicembre 1996, n. 11127, ivi 1997, 269; secondo cui, mentre la tutela ex articolo 2087 codice civile riguarderebbe la collettività dei lavoratori, nessuna norma di legge prescrive, invece, a carico del datore di lavoro l’obbligo di apprestare «per ciascun singolo lavoratore, un ambiente di lavoro idoneo ed acconcio alle sue particolari ed individuali patologie»).
Queste oramai datate decisioni – che oltre tutto appartengono, nella quasi totalità, al pregresso orientamento assertore dell’irrilevanza per il (ed indifferenza del) datore di lavoro nei confronti delle malattie determinanti impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, materia nella quale ha operato una svolta la già citata Cass. sez. un. n. 7755/1998, nel senso di asserire l’obbligo datoriale del reperimento di mansioni compatibili con lo stato di salute e di residua idoneità lavorativa del prestatore d’opera - lungi dall’essere condivisibili, sono senza dubbio rifiutabili perché forniscono una lettura restrittiva dell’obbligo prevenzionale contenuto nell’articolo 2087 codice civile, escludendo che lo stesso possa riguardare il singolo (con le sue individuali fragilità e la sua particolare conformazione organica) e, per contro, riservando le misure di salvaguardia datoriali solo per la “collettività” dei lavoratori.
Quanto sopra asserito non costituisce affatto una nostra opinione soggettiva, poiché le più recenti e migliori decisioni della Cassazione – che relegano le opposte opinioni sopra riferite nell’alveo di un orientamento oramai superato – affermano che: «E’ soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell’articolo 2087 del codice civile il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore, continui ad adibirlo a mansioni che sebbene corrispondenti alla sua qualifica siano suscettibili – per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) - di metterne in pericolo la salute. L’esigenza di tutelare in via privilegiata la salute del lavoratore alla stregua dell’articolo 2087 del codice civile e la doverosità di una interpretazione del contratto di lavoro alla luce del principio di correttezza e buona fede, di cui all’articolo 1375 del codice civile – che funge da parametro di valutazione comparativa degli interessi sostanziali delle parti contrattuali – inducono a ritenere che il datore di lavoro debba adibire il lavoratore, affetto da infermità suscettibili di aggravamento a seguito dell’attività svolta, ad altre mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa, sempre che ciò sia reso possibile dall’assetto organizzativo dell’impresa, che consenta un’agevole sostituzione con altro dipendente nei compiti più usuranti. Quando ciò non sia possibile, il datore di lavoro può far valere l’infermità del dipendente quale titolo legittimante il recesso ed addurre l’impossibilità della prestazione per inidoneità fisica – in applicazione del generale principio codicistico dettato dall’articolo 1464 del codice civile – configurandosi un giustificato motivo oggettivo di recesso per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, e restando in ogni caso vietata la permanenza del lavoratore in mansioni pregiudizievoli al suo stato di salute» (Così Cass., sez. lav., 3 luglio 1997, n. 5961, cit.).
E la Suprema corte giunge, nella sopra riferita decisione ed in altre successive, a queste conclusioni adducendo che: «i principi di correttezza e di buona fede che devono presiedere all’esecuzione del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 1375 codice civile, richiedono – in ossequio a quanto imposto dall’articolo 2087 del codice civile – che il datore di lavoro, a conoscenza di un’infermità del lavoratore incompatibile con le mansioni affidategli, deve mettere in atto tutte e misure a tutela dell’integrità psico/fisica del suo dipendente, incorrendo conseguentemente in responsabilità per danni alla salute che il dipendente stesso abbia subito per essere stato indotto a continuare un’attività lavorativa che, per la sua natura e le concrete modalità di svolgimento, sia suscettibile di determinare un aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute».
Nello stesso senso – cioè a dire per un obbligo prevenzionale mirato al “singolo lavoratore” – si è espressa, poi, una successiva decisione della Cassazione del 1 settembre 1997, n. 8267 (in Lav. prev. oggi, 1998, 367, confermata da Cass. n. 1307 del 5.2.2000, ivi 2000, 818) secondo la quale: «In ottemperanza all’articolo 41, comma 2°, Costituzione, secondo cui la libertà di iniziativa economica incontra l’imprescindibile limite di non arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana, il datore di lavoro non può esimersi dall’adottare tutte le misure necessarie – compreso l’adeguamento dell’organico – volte ad assicurare livelli competitivi di produttività senza compromissione, tuttavia, dell’integrità psico fisica dei lavoratori soggetti al suo potere organizzativo e di dimensionamento della struttura aziendale.
La regola consolidata nell’ambito del’articolo 2087 codice civile prescrive che l’attività di collaborazione cui l’imprenditore è tenuto in favore dei lavoratori, non si esaurisca nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge ma si estenda alle altre iniziative o misure che appaiono utili per impedire il sorgere o il deterioramento di una situazione tale per cui lo svolgimento dell’attività lavorativa determini, con nesso di causalità, effetti patologici o traumatici nei lavoratori». Analogo principio è stato riaffermato dalla Cassazione nella più recente decisione del 26 maggio 2005 n. 11092 (est. Toffoli) la cui massima dispone: «Il datore di lavoro, una volta che sia emerso che il lavoratore presenta infermità che mettono in dubbio la compatibilità delle mansioni cui è addetto con il suo stato di salute, ha il dovere di verificare tale compatibilità e di assumere i provvedimenti conseguenti, a norma dell’articolo 2087 codice civile e dell’articolo 4, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 626/1994 (cfr. Cass. 22 aprile 1997 n. 3455, 2 agosto 2001 n 10574). L’eventuale impossibilità, sul piano organizzativo, di assegnare il lavoratore a mansioni compatibili con le specifiche infermità e limitazioni fisiche da cui il medesimo sia affetto non giustifica l’assegnazione a mansioni non compatibili. Salva rimanendo la possibilità del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, in caso di comprovata impossibilità di assegnazione dello stesso a mansioni compatibili (anche con deroga al divieto ad assegnazione a mansioni di livello inferiore: cfr. Cass. sez. un., 7 agosto 1998 n, 7755). Con la precisazione che le assenze per malattia, che siano valutabili come conseguenza dell’illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato di salute, non possano rilevare ai fini del superamento del periodo di comporto».
Identica irrilevanza delle assenze per malattia imputabile a responsabilità datoriale è stata asserita, successivamente, da Cass. 22 gennaio 2007 n. 1333(In Not giurisp. lav. 2007, 189. Conf. Cass. 30.8.2006 n. 18711, ivi 2007, 54; Cass. 25.11.2004 n. 20458, ivi 2005,215; Cass. 7.4.2003 n. 5413, ivi 2003, 580), secondo cui: «Ai fini del superamento del cd. periodo di comporto non sono computabili le assenze del lavoratore per malattia nelle ipotesi in cui l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità del datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 del codice civile o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore, l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate».
Nello stesso orientamento si era posta, già alla fine del secolo scorso, anche parte della giurisprudenza di merito, tra cui Pret. Roma 14 giugno 1988 (in Dir. lav. 1989, II, 473, con nota di M. Ziliotti), secondo la quale: «le misure che l’imprenditore deve adottare ai sensi dell’articolo 2087 codice civile devono essere individuate anche con riferimento a posizioni di singoli lavoratori dotate di tratti di peculiarità. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore versi in una condizione patologica che ne determini una particolarissima vulnerabilità alla fatica, il datore di lavoro, in osservanza ai doveri di prudenza e diligenza di cui all’articolo 2087 del codice civile, è tenuto ad attivarsi allo scopo di rintracciare un’adeguata collocazione al dipendente. La violazione di tale dovere determina per l’imprenditore un obbligo di risarcimento di danno, con riferimento non solo alla capacità produttiva di reddito del lavoratore, ma anche al c.d. danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul ‘valore uomo in tutta la sua dimensione’».
3. L’illegittimità del licenziamento per superamento del comporto di malattia, correlata alle mansioni e/o condizioni di lavoro (morbigene anche solo soggettivamente), nel caso in cui il datore di lavoro abbia trascurato l’obbligo di ricerca di sollecitate mansioni confacenti con il menomato stato di salute. L’addizionale reato di lesioni colpose
Conformi alla impostazione secondo la quale sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di sottrazione del lavoratore da condizioni e/o mansioni di lavoro pregiudizievoli – anche soggettivamente, in ragione di predisposizione del lavoratore a certe sindromi o patologie insorgenti in capo allo stesso o suscettibili di aggravarsi per mantenimento in mansioni e condizioni ambientali di lavoro, oggettivamente non morbigene, in quanto indifferenti per altri ma pregiudizievoli per quel soggetto a motivo della sua particolare conformazione congenita – si rivelano le affermazioni di Cass. sez. lav. 21 gennaio 2002, n. 572, la quale esplicitamente confermò l’orientamento da noi sopra esposto, con le seguenti significative affermazioni: «L’articolo 2087 del codice civile impone, all’imprenditore, quale disposizione di chiusura di tutta la disciplina antinfortunistica ed anche indipendentemente dalle specifiche misure previste dalla legge per le varie lavorazioni, di adottare nell’esercizio della impresa tutte le cautele e gli accorgimenti che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei dipendenti, si appalesino necessari ed idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale degli stessi, adoperandosi, nei limiti delle varie esigenze e del bilanciamento degli opposti interessi, a creare le situazioni più favorevoli per ottenere dai propri lavoratori il miglior rendimento secondo le proprie capacità in ragione di salute, di idoneità e di adattamento di ognuno alle esigenze lavorative proprie dello specifico settore della impresa.
«È giurisprudenza consolidata, in tema di legittimità del licenziamento del lavoratore disattendendo la sua richiesta di accertamento della possibilità di altro impiego in azienda, determinata dalle condizioni di salute, che una corretta interpretazione degli articoli 1463, 1464 del Codice Civile e 3 legge n. 604 del 1966 comporta che la sopravvenuta infermità permanente del dipendente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso datoriale dal contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore soprattutto se determinata da patologia strettamente ancorata al tipo di lavorazione, come nella specie, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, alle mansioni attualmente assegnate od a quelle equivalenti (ex articolo 2103 Cod. Civile) o, in ipotesi di impossibilità, anche a mansioni inferiori purché accettate dal dipendente, a condizione che detta diversa attività sia utilizzabile nell’impresa secondo i finì programmati dalla stessa e nel quadro dell’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cfr. S. U. n. 7755/1998; Cass.n. 7908/97).
«Con il corollario che il datore di lavoro soddisferà l’onere, impostogli dall’articolo 5 legge n. 604/1966, di provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che, nell’ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate, un conveniente impiego dell’infermo non è possibile o, comunque, compatibile con il buon andamento dell’impresa, e fermo restando il contrapposto onere del lavoratore di contrastare la detta prova, indicando a sua volta specificamente le mansioni esercitabili e non nocive per la sua salute, nonché dimostrando la sua idoneità alle stesse»( Cass. sez. lav. 21 gennaio 2002, n. 572, trovasi in Not.giurisp. lav. 2002, 259; Riv. crit. dir. lav. 2002, 426; Riv. it. dir. lav. 2002, II, 865 con nota di P. Albi).
Il principio è stato espresso in una fattispecie in cui un impiegato esattoriale (con compiti di riscossione coattiva dei tributi, accessi nelle abitazioni dei contribuenti, pignoramenti, ecc.) colpito da sindrome depressiva acuta di tipo nevrotico, in ragione della tipologia del lavoro, riscontrato da specialisti abnormemente stressante per le di lui capacità di reazione psicologica. Sindrome sanitariamente documentata, in conseguenza della quale il lavoratore aveva rivolto reiterate sollecitazioni scritte all’azienda per un mutamento di mansioni - atte ad evitare la cronicizzazione della patologia - nei cui confronti l’azienda aveva assunto un atteggiamento di indifferenza o trascuratezza con l’effetto che la permanenza nelle mansioni aveva indotto il lavoratore ad assenze superanti il periodo di comporto contrattuale per sommatoria, talché era così incorso nel licenziamento ex articolo 2110 c. c.. Licenziamento che, proprio in ragione dell’inadempienza datoriale al dovere prevenzionale ex articolo 2087 codice civile, la S. corte dichiarò illegittimo.
Come già anticipato - riferendo in intesi le motivazioni di Cass. 26 maggio 2005 n. 11092 e di Cass. 22 gennaio 2007 n. 1333 - ne è, poi sortita l’affermazione - oramai del tutto pacifica nella giurisprudenza della S. Corte - di non computabilità, ai fini dell’esaurimento del comporto contrattuale per malattia, delle assenze del lavoratore riconducibili a responsabilità datoriale, così legittimando l’affermazione giurisprudenziale secondo cui : “le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate” (ex plurimis, Cass. 7/11/2013 n. 25072). Principio che Cass. 2 ottobre 2013 n. 22538 ha riconosciuto applicabile, altresì, alle assenze per malattia indotte da comportamenti di mobbing subiti dal lavoratore in azienda, per la prevenzione e rimozione dei quali sussiste, in capo al datore di lavoro, un preciso obbligo giuridico di attivazione, codificato nell’articolo 2087 del codice civile.
Va addizionalmente evidenziato che - qualora dall’omissione delle cautele e misure prevenzionali discendenti dall’articolo 2087 del codice civile (a tutela dell’integrità psico/fisica e della personalità morale) discenda a carico del lavoratore un infortunio od una malattia professionale (o comunque un tangibile pregiudizio all’integrità della salute) - la giurisprudenza è pacificamente consolidata per l’automatica ricorrenza del reato di “lesioni colpose”. Asserendo che: «l’accertamento che l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono stati determinati da negligenza o inosservanza delle disposizioni di legge e quindi dei doveri posti dallo stesso articolo 2087 del codice civile, implica l’affermazione dell’esistenza nel fatto degli estremi costitutivi del reato di lesioni colpose» ex artt. 590 e 583 c.p. (così Corte cost. 18 luglio 1991, n. 356, in Riv. giur. lav. 1991, II, 143 con nota di A. Andreoni; conf. Pret. Milano 11 ottobre 1995, in Riv. crit. dir. lav. 1996,192).
Il principio era stato in precedenza affermato dalla Cassazione (Cass. 23 gennaio 1986 n. 378), secondo la quale: «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (e delle malattie professionali, n.d.r.) il disposto dell’articolo 2087 del codice civile ha carattere generale e non contrattuale come si desume dallo stesso titolo (tutela delle condizioni di lavoro) nonché dal suo particolare contenuto normativo, per cui, quantunque la predetta norma sia inserita nel codice civile, essa pone specifici doveri di comportamento antinfortunistico a carico del titolare dell’impresa, la cui effettiva inosservanza integra il delitto di cui al 2° comma, articolo 590 c.p.», riscontrabile e procedibile d’ufficio, come ha riconosciuto, a suo tempo e senza successive modifiche, Cass. 20 aprile 1998, n. 4012 (in Riv. it. dir. lav. 1999, II, 326 annotata da P. Mautone, con amputazione della parte afferente l’essenziale rilevanza penalistica). Ed ancora la Cassazione in una antecedente, datata, sentenza (Cass. 8 marzo 1988, n. 316; conf. Pret. Torino 10 novembre 1995, in Riv. crit. dir. lav. 1996, 727) ha sostenuto: «in tema di misure antinfortunistiche (e a tutela delle malattie professionali, n.d.r.) l’articolo 2087 del codice civile, laddove impone all’imprenditore l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, determina un obbligo di comportamento che trova la sua fonte nella Costituzione (…).Ne consegue che la violazione del prefato obbligo da parte dei destinatari della normativa a tutela dei lavoratori integra il precetto penale ogniqualvolta ne derivi un danno agli addetti», con diritto per quest’ultimi – dal lato civilistico - al risarcimento del danno biologico e del danno morale (riconducibile ex articolo 2059 codice civile, a reato). Tale orientamento è stato asserito dalla già citata Cass. n. 4012 del 20 aprile 1998 e più di recente riconfermato da Cass. 22 marzo 2002 n. 4129 (in Lav. prev. oggi 2002, 450; Lav. giur. 2002, 746 con nota di S. Bertocco), la quale si è così inequivocamente espressa: «Nel danno sopportato dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro (o del soggetto comunque tenuto a garantirne la tutela)) degli obblighi di sicurezza impostigli dall’articolo 2087 codice civile, rientra anche il danno morale quante volte da quell’inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore di lavoro anche un rilievo penale che giustifica l’attribuzione del risarcimento ex articolo 2059 codice civile» (danno morale, dopo Corte cost. n. 233/2003, spettante indipendentemente dal riscontro penalistico, sufficiente risultando la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali quello alla salute, ex articolo 32 Cost.).
Va dato altresì conto di un più recente orientamento della Cassazione, manifestato nella decisione del 5 agosto 2000, n. 10339 [In Lav. prev. oggi 2000, 2083; in Mass. giur. lav. 2000, 1208 con nota S. Figurati] secondo cui: «Il lavoratore certificato parzialmente inidoneo alla mansione - nella fattispecie di operatore unico aeroportuale, caratterizzata intrinsecamente e principalmente dal carico e scarico bagagli e zavorra - non può pretendere di permanere nella stessa mansione venendo esonerato dal compito principale e gravoso del carico e scarico, eventualmente eliminabile dall’azienda con l’adozione, non già di mezzi in dotazione, ma di strumenti ad hoc offerti dalle nuove tecnologie, non essendo configurabile un obbligo dell’imprenditore di acquistarli ed adottarli per porsi in condizione di cooperare all’accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di garantire la sicurezza imposta dalla legge (d.lgs. n. 626/’94). In caso di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, sussiste invece - come affermato da Cass. sez. un. n. 7755/’98, di cui si condivide l’orientamento - il diverso diritto di assegnazione a mansioni diverse ed equivalenti (sempreché sussistenti in azienda) ed anche inferiori, dietro manifestazione di consenso del lavoratore alla dequalificazione finalizzata alla salvaguardia del superiore interesse dell’occupazione, per la cui richiesta al datore di lavoro anche il lavoratore deve attivarsi precisando le residue attitudini professionali tali da rendere possibile all’azienda una diversa collocazione all’interno».
Le riflessioni che abbiamo sviluppato e l’orientamento che, dopo le prime resistenze, si è oramai imposto – nel senso dell’obbligo datoriale di spostamento del lavoratore da mansioni e lavorazioni “soggettivamente” pregiudizievoli per la salute ad altre più consone, in conseguenza sia del dovere “prevenzionale” ex articolo 2087 codice civile sia del più generale dovere di cooperazione, scaturente da correttezza e buona fede del creditore-datore di lavoro, finalizzate a consentire al debitore dell’obbligazione lavorativa che questa venga resa in aderenza al suo carattere contrattuale – vanno indiscutibilmente considerate le più corrette, moderne e rispondenti a rispetto dell’individuo nonché a doverosa e umana solidarietà verso le posizioni dei più deboli e meno fortunati (gli ammalati, i disabili, le figure sociali reclamanti protezione, quali la lavoratrice, nel particolare periodo della gravidanza e del puerperio, e simili).



