I rimedi rescissori del giudicato

Introduzione tratta da "I rimedi recissori del giudicato" a cura di Paola Balducci e Armando Macrillò.
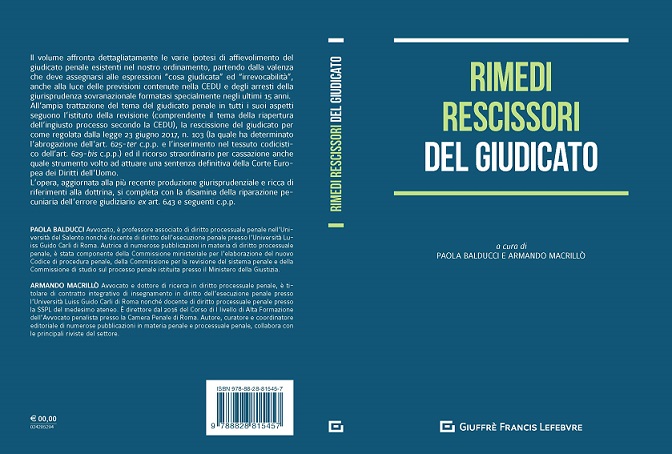
L’erosione del principio di intangibilità del giudicato è, ormai, un topos della letteratura scientifica[1].
Come per tutti i luoghi comuni -anche giudici-, però, il rischio di banalizzazioni si cela sempre dietro la facciata della verità. È il rischio, cioè, di deproblematizzare o assolutizzare un fenomeno indubbiamente esistente -ed anzi dirompente- ma che al tempo stesso si connota per un alto tasso di complessità. Diverse, infatti, sono le ragioni e le manifestazioni della crisi del giudicato o, come è stato scritto, della fine del mito, della caduta del tabù[2] o dell’abbattimento del totem del giudicato. Espressioni evocative, queste, a tratti immaginifiche, non meno intense di quella res iudicata facit de albo nigro, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat che, per secoli, ha rappresentato, all’opposto, il mito, il tabù e il totem della fissità del giudicato, tanto civile quanto penale. Ebbene, queste descrizioni a tinte forti colpiscono il lettore come un quadro espressionista, ma aiutano poco a cogliere l’ontologia del problema. A questo scopo, invece, è dedicato il presente volume, che si prefigge l’obiettivo, forse ambizioso, di esaminare dettagliatamente le varie ipotesi di affievolimento del giudicato esistenti nel nostro ordinamento.
L’ottica vuol essere ad un tempo sia analitica che sistematica.
Analitica in quanto si propone di vagliare funditus ciascuna fattispecie, individuandone la ratio -o, più spesso, le rationes-, descrivendone la disciplina e studiandone l’impatto sull’ordinamento. Sistematica poiché si mira a cogliere il file rouge che collega, pur nelle loro differenze, tutte le ipotesi di giudicato flessibile.
Questo filo rosso, lo si anticipa, è il favor libertatis.
Salvo rarissime eccezioni (si pensi alle assolutamente marginali ipotesi di c.d. revisione in peius, cui si fa cenno nel capitolo dedicato alla revisione, oppure all’applicazione della confisca in executivis contemplato dall’art. 676 c.p.p.), il giudicato può essere infranto -o anche solo “ammorbidito” - unicamente a vantaggio del condannato e mai a suo detrimento. Ciò è vero sia per le ipotesi positive, quali la revisione, la rescissione del giudicato o l’incidente di esecuzione nelle ipotesi classiche di cui agli artt. 670 e ss. c.p.p., sia per le figure di parziale o totale creazione giurisprudenziale, quali la c.d. revisione europea, l’incidente di esecuzione o il ricorso straordinario volti al superamento del giudicato interno contrario alla Convenzione EDU oppure l’incidente di esecuzione teso a far cessare l’espiazione di una pena illegale.
Non vale a smentire il principio la pur corretta constatazione per cui in alcuni di questi casi -su tutti la revisione europea-[3] il nuovo giudizio potrebbe chiudersi con la pronuncia di una nuova condanna. Come si osserverà nel relativo capitolo, infatti, l’istituto de quo rimedia a un’ingiustizia procedurale, ossia l’unfairness convenzionale della sentenza, differentemente dai tradizionali casi di revisione che, vice versa, contrastano l’ingiustizia sostanziale della condanna. La sola circostanza di poter essere (ri)giudicati correttamente è, allora, un vantaggio per il condannato, a prescindere dalla decisione finale, ché, d’altronde, la giustizia procedurale non garantisce indefettibilmente la giustizia sostanziale ma sicuramente la favorisce.
Se la flessibilità del giudicato è un istituto di favore (rectius è l’effetto di istituti diversi intrisi dal favor libertatis), ben si comprende come l’attributo di “malleabilità” possa riferirsi al solo giudicato di condanna e non a quello di assoluzione; il che porta a concludere nel senso dell’ontologica rigidità di quest’ultimo.
La resistenza passiva del giudicato penale è, dunque, mutevole a seconda del suo tenore onde appare corretto discorrersi, seppur in termini del tutto peculiari, di giudicato secundum eventum litis, prendendo a prestito un’espressione processualcivilistica. Si vuol con tale locuzione significare che mentre il giudicato condannatorio è sempre un giudicato allo stato degli atti, perché sempre teoricamente cedevole -sebbene nei soli casi tassativamente previsti dalla legge-, quello assolutorio è per definitionm irremovibile.
Questa discrasia lungi dall’arrecare disarmonia al sistema ne disvela al contrario l’intrinseca coerenza, perché risulta in linea con la già più volte indicata ratio di favor che lo anima.
La prospettiva ermeneutica è confermata dall’istituto del ne bis idem, oggi per altro al centro di notevole fermento dottrinario e giurisprudenziale, specie per il massiccio intervento della giurisprudenza eurounitaria e convenzionale[4]. In questa sede tuttavia non interessa soffermarsi sulle torsioni ermeneutiche che in sede europea stanno interessando la figura, tanto da assottigliare la tradizionale distinzione tra versione sostanziale e processuale del principio, quanto piuttosto concentrarsi sull’annosa questione della ratio del divieto di secondo giudizio.
Non v’è dubbio che il ne bis in idem rappresenti un epifenomeno del principio di immutabilità del giudicato, poiché la presenza di un idem factum in eadem persona costituisce una condizione negativa di procedibilità che impedisce l’instaurazione di un secondo giudizio. Il divieto -ed è questo il punto- colpisce indifferentemente tanto il giudicato di condanna quanto quello di assoluzione, ciò che ne rivela il fondamento logico nel principio di certezza del diritto più che in quello di garanzia.[5] Se è vero, infatti, che l’assolto non può essere sine die sottoposto a persecuzione penale, e quindi trova nel giudicato di assoluzione il baluardo della propria libertà, non è men vero viceversa che il condannato avrebbe tutto l’interesse alla celebrazione di un nuovo giudizio per il medesimo fatto. Eppur tuttavia se una tale possibilità gli fosse concessa senza limiti ne verrebbe turbato l’ordine sociopsichico collettivo, per dirla con Franco Cordero,[6] ossia, più prosaicamente, la stessa deterrenza del sistema penale ne verrebbe irrimediabilmente compromessa, giacché qualunque consociato potrebbe violare la legge penale speranzoso che una reiterata celebrazione di giudizi porti prima o poi -quasi che si giochi alla roulette- ad una fortuita assoluzione. Senza considerare, ovviamente, la continua spendita di moneta processuale vieppiù intollerabile in un periodo di endemica scarsità di risorse economiche e umane e di perenne ingolfamento della macchina della giustizia.
Ecco allora che l’istituto del ne bis in idem diventa la cartina di tornasole di un sistema in cui il giudicato assolutorio resta sempre intangibile, al contrario di ciò che accade con riguardo al giudicato di condanna il quale resta intangibile finché una sopravvenienza ne mostri l’ingiustizia sostanziale o, in certe ipotesi, procedurale oppure frapponga un ostacolo di legalità all’esecuzione della pena.
Ricondotto ad unità il sistema, giova allora sin da subito esaminare sinteticamente proprio queste ultime ipotesi, alla cui analisi dettagliata, come anticipato, è dedicato il presente volume.
I criteri tassonomici impiegabili per classificare i rimedi rescissori del giudicato potrebbero essere diversi, a seconda ad esempio del tipo di vizi deducibili con lo strumento oppure della genesi pretoria o legale. Poiché, però, la materia presenta ancora un certo tasso di fluidità in cui non è sempre facile sceverare quando un istituto sia di vera e propria creazione giurisprudenziale o non si tratti piuttosto di un interpretazione estensiva ma non nomopoietica, la scelta che ci sembra più opportuna è quella di seguire l’ordine codicistico e quindi trattare dapprima della revisione, della rescissione del giudicato e dell’incidente di esecuzione, per ciascuno di essi dando atto di eventuali esegesi giurisprudenziali creatrici riferibili al modello di volta in volta esaminato.
Come anticipato, la revisione è il principale (e più tradizionale, essendo presente nel nostro ordinamento fin dal Codice di rito penale del 1865) strumento di superamento del giudicato ingiusto. Più correttamente si tratta di un mezzo straordinario di impugnazione, non soggetto a termini di decadenza, previsto ad esclusivo beneficio del condannato, esperibile nei soli casi tassativi contemplati dall’articolo 630 c.p.p., avverso sentenze di condanna o provvedimenti ad essa equiparati.[7]
La revisione mira a scongiurare «il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale»[8] giacché «non è lecito sotto alcun aspetto e per nessun motivo porre schermi contro la luce della giustizia, che non deve mai fermare il suo cammino quando è indirizzato a tutelare l’uomo nei suoi diritti essenziali contro il pericolo della loro manomissione proprio a mezzo della giustizia».[9]
Esistono cioè dei casi, nominatim previsti all’art. 630 c.p.p., in cui appare evidente l’ingiustizia sostanziale della sentenza di condanna, quid est che essa sia il frutto di un errore giudiziario. In tal caso la firmitas iudicati cede il passo al favor rei e il condannato -o gli altri soggetti attivamente legittimati ma sempre a vantaggio e mai a detrimento del condannato medesimo- può ottenere, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 629 e ss., l’eliminazione della sentenza pregiudizievole, oltre che, ricorrendone i presupposti, una congrua riparazione pecuniaria.
Rinviando alle sedi opportune l’esame dettagliato dell’istituto, in questa sede è, invece, opportuno segnalare che la tendenziale omogeneità dell’istituto è stata “sconvolta” dalla sentenza della Corte costituzionale 113/2011, introduttiva della c.d. revisione europea[10].
Fino al 2011, infatti, i casi di revisione erano tutti accomunati, come osservato, dal caratterizzarsi a guisa di manifestazioni dell’ingiustizia sostanziale della condanna, irrilevante essendo che essa fosse giunta o meno all’esito di un processo giusto; ché, d’altronde, secondo quanto anticipato, un processo giusto riduce ma non elimina affatto il rischio di una decisione ingiusta, per tale ultima intendendosi, stricto sensu, la sola condanna dell’innocente. L’adesione dell’Italia alla Convenzione EDU e quindi all’auctoritas della relativa Corte ha, però, condotto ad una rivisitazione, dapprima timida e poi sempre più decisa, del suddetto principio, giacché la violazione delle regole di fairness processuale sancite nella Convenzione EDU per la Corte di Strasburgo non può rimanere senza conseguenze, o, almeno, non può produrre solo le blande conseguenze di diritto internazionale a carico dello Stato cui sia imputabile la violazione, pena la sostanziale ineffettività della tutela dei diritti umani (sempre più assicurata -del resto- nel sistema di protezione multilivello: nazionale, europeo, convenzionale). In un primo tempo tali effetti sono stati circoscritti alla corresponsione di un equo indennizzo monetario a favore dell’istante ma, in progresso di tempo, si è giunti al ben più dirompente principio per cui, nei casi più gravi, il processo unfair va riaperto, onde consentire la restitutio in integrum del condannato nelle chances difensive ingiustamente sottrattegli. Lo strumento con cui in concreto ciò possa avvenire va individuato da ciascuna Alta Parte contraente sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri e l’Italia, dopo infruttuosi tentavi del legislatore e ardite operazioni ermeneutiche dei giudici comuni, ha finalmente provveduto con la citata sentenza costituzionale.
La peculiare genesi -ora accennata- e le altrettanto peculiari finalità della revisione europea rispetto agli altri casi di revisione ben spiegano i tratti marcatamente eterodossi di questa figura rispetto alla tradizionale fisionomia dell’istituto. Ciò si riverbera sia sotto il profilo disciplinatorio, l’applicabilità della disciplina tradizionale della revisione dovendo essere vagliata caso per caso, sia soprattutto nell’esito, perché se nella revisione classica, ravvisata la sussistenza dell’errore giudiziario, l’esito è obbligatoriamente prosclioglitivo, nell’istituto de quo il nuovo giudizio, depurato dall’unfairness ben può concludersi con la conferma della condanna.
L’adeguamento ai dicta della Corte EDU è anche alla base del diverso istituto della rescissione del giudicato, disciplinato – a far data dal 2017 - all’art. 629-bis c.p.p. (con competenza attribuita alla Corte d’Appello), dopo che nel 2014 esso era stato introdotto nell’art. 625-ter c.p.p. (e attribuito alla cognizione della Corte di Cassazione) [11].
La rescissione del giudicato risponde ad una specifica violazione dell’equità processuale spesso riscontrata nel nostro ordinamento, ossia la condanna di imputati non consapevoli della pendenza di un processo a proprio carico.
Come è noto, la Corte di Strasburgo aveva più volte stigmatizzato la disciplina interna della contumacia,[12] tanto da indurre il legislatore nel 2014 ad abrogare questo controverso istituto e a sostituirlo con quello del processo in absentia. Contestualmente si procedeva ad introdurre un rimedio straordinario che consentisse al condannato (e al prosciolto cui fossero applicate misure di sicurezza) di ottenere la rescissione del giudicato provando di aver incolpevolmente ignorato la celebrazione del giudizio.
Anche l’attuale disciplina mantiene il medesimo assetto normativo, addossando quindi all’(ex) imputato inconsapevole l’onere di dimostrare la non colposità dell’ignoranza, il che potrebbe porre ulteriori dubbi di compatibilità convenzionale dell’istituto, stante la gravosità di tale onus probandi, integrante quasi una probatio diabolica. Ciò anche a tacere di ulteriori profili problematici, su tutti l’inconferenza della collocazione del rimedio tra i mezzi di impugnazione e non invece tra le ipotesi di incidente d’esecuzione, inconferenza non risolta neppure dalla prefata riforma del 2017, sebbene la Corte d’Appello sia indubbiamente organo meglio in grado di effettuare quegli apprezzamenti fattuali imprescindibili onde ravvisare il carattere colpevole o meno dell’absentia (non qualificata) rispetto a quanto (non) lo fosse la Corte di Cassazione.
La maggiore congruità di un inserimento della rescissione del giudicato tra i casi di incidente d’esecuzione ben si spiega tenendo presente la ratio che accomuna le ipotesi di cui all’art. 670: si tratta di circostanze appalesanti l’originaria inesistenza materiale o giuridica del titolo esecutivo, un vizio dello stesso o la sua non esecutività.[13] Rebus sic stantibus, è chiaro che l’impossibilità di partecipare ad un procedimento, di cui si ignori incolpevolmente l’esistenza, infici ab origine il titolo esecutivo, inutiliter datum, e tale da dover essere posto in non cale tramite pronuncia del giudice dell’esecuzione.
Ciò è ulteriormente testimoniato dalla circostanza per cui prima dell’introduzione della revisione europea -e, seppur problematicamente, anche dopo, secondo alcuni orientamenti- l’incidente di esecuzione -più quale veicolo procedimentale che come istituto a sé stante- sia stato impiegato per porre rimedio -rectius “tamponare” - l’unfairness della sentenza interna dichiarata dalla Corte EDU contrastante con la Convenzione EDU. Si tratta, quindi, di un impiego pretorio che, almeno per la rescissione del giudicato, avrebbe potuto tranquillamente essere positivizzato.[14]
L’incidente di esecuzione ha peraltro conosciuto una rinnovata fortuna applicativa quale strumento per fronteggiare fenomeni di illegalità della pena,[15] tanto in astratto quanto in concreto.
In generale è illegale una pena avulsa dal sistema, il che può verificarsi tanto nell’ipotesi in cui il giudice irroghi una pena non prevista dall’ordinamento tout court oppure non prevista per quel determinato reato oppure una pena conferente ma in tutto o in parte fondata su norma incostituzionale.
Prettamente teorica la prima ipotesi -che darebbe la stura secondo i più ad una sentenza giuridicamente inesistente e quindi inidonea al passaggio in giudicato- è sulla seconda che si è soffermata di recente la giurisprudenza di legittimità e in relazione alla quale si è fatta applicazione del citato istituto di cui agli artt. 670 e ss. c.p.p.
Più nel dettaglio ove ad essere dichiarata incostituzionale sia la medesima norma incriminatrice, nulla quaestio. In questo caso, infatti, il combinato disposto degli artt. 2, comma 2 c.p. e 673 c.p.p. impone la revoca del giudicato con testuale liberazione del condannato, se ristretto, e cessazione di ogni effetto penale della condanna.
Ben più problematica, invece, l’ipotesi, in cui ad essere colpita dalla declaratoria di illegittimità sia solo una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, inapplicabili essendo i citati art. 2, comma 2, c.p. e 673 c.p.p. Del pari, tuttavia, sarebbe assolutamente intollerabile accettare che il condannato sia privato della libertà personale (anche) sulla base di una norma che giammai avrebbe dovuto essere adottata, ben diverso essendo l’effetto invalidante ex tunc di una pronuncia di incostituzionalità da quello ex nunc di un’abrogazione per via legislativa.
Ed infatti il limite all’operatività del principio di retroazione favorevole rappresentato dal giudicato, ex art. 2, comma 4, c.p., in tanto ha senso in quanto la lex mitiior sopravvenga alla lex severior precedente sulla scorta di un fisiologico fenomeno di successione di norme penali nel tempo; giammai, invece, un consimile sbarramento avrebbe giustificazione ove la lex severior fosse espunta dall’ordinamento giuridico, chiara la patologia normativa sottesa a tale eventualità.
Ebbene, in un consimile caso l’unico limite opponibile all’effetto in bonam partem è rappresentato dall’esaurimento del rapporto governato dalla legge (o anche solo in base alla) legge incostituzionale, dovendo la stessa retroattività delle pronunce accoglitive della quaestio legitimitatis soccombere al principio di certezza del diritto, che impone l’intangibilità delle relazioni giuridiche ormai integralmente appartenenti al passato. Tale, però, non può essere il caso del rapporto esecutivo fintantoché la pena produca qualche effetto giuridico e men che meno finché costituisca titolo per la privazione della libertà personale[16].
Ciò posto sul piano teorico, occorre tuttavia rinvenire lo strumento pratico per consentire ogni intervento manipolativo sul giudicato imposto dalla declaratoria di incostituzionalità e tale strumento è stato ben presto individuato proprio nell’incidente di esecuzione, quale tipo procedimentale applicabile ad ipotesi diversificate. Essendo qui inconferente il prefato art. 673 c.p.p. -appunto relativo alla caducazione della norma incriminatrice e non semplicemente incidente sul trattamento sanzionatorio- la giurisprudenza ha infine valorizzato l’art. 30, comma 4, l. 87/1953, in forza della quale «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».
Si noti come l’impiego della locuzione “in applicazione di” appaia alla giurisprudenza maggioritaria sufficiente per opinare nel senso della riconducibilità nell’alveo di tale art. 30 ipotesi ulteriori a quelle già sussumibili nell’art. 673 c.p.p. ossia per l’appunto relative alla caducazione non già della norma penale incriminatrice bensì di norma meramente incidente sul compendio sanzionatorio. Sennonché, se nel primo caso l’operazione a cui è chiamato il giudice dell’esecuzione si riduce ad una mera attività rescissoria, come tale non implicante alcuna spendita di potere discrezionale, e quindi agevolmente riconducibile al novero dei tradizionali poteri della giurisdizione esecutiva, nel secondo caso la manipolazione della res iudicata può ben tradursi in interventi non vincolati, il che pone l’ulteriore problema di perimetrare l’ambito dei poteri del giudice dell’esecuzione in modo tale che essi non trasmodino in una non consentita invasione della sfera di competenze propria del giudizio di cognizione.
Più nel dettaglio, finché si tratti di scomputare gli effetti di una circostanza aggravante che non poteva essere dichiarata subvalente rispetto ad un’attenuante sulla scorta di previsione incostituzionale,[17] non si incorre in particolari problemi, poiché si tratta, a ben vedere, di diminuire solo la pena della parte riferibile alla predetta circostanza. Più complessa, invece, l’attività esecutiva, onde occorre riallineare la sanzione in riferimento a una cornice edittale ricalibrata verso il basso, si da mantenere il rapporto proporzionale tra la pena irrogata in concreto e i limiti astratti del nuovo range legislativo.[18] Ancor più delicata, infine, quest’ultima operazione se la pena è frutto di applicazione concordata, da cui la necessità di favorire un nuovo accordo tra le parti solo in assenza o in caso di invalidità del quale procedere alla rideterminazione officiosa[19].
Ebbene, queste scelte sono state ritenute compatibili con la funzione della giurisdizione esecutiva quale presidio della legalità della pena in ogni fase della sua espiazione, purché, però, le valutazioni del giudice dell’esecuzione non si pongano mai in contrasto con quelle adottate in sede di cognizione[20].
Queste ultime brevi considerazioni aprono a un’ulteriore prospettiva di riflessione.
Per garantire la piena esplicazione dei principi costituzionali garantistici e del favor libertatis, il giudicato diventa non solo rescindibile, ma anche “malleabile”, ossia riducibile relativamente al quantum di pena irrogata. Tale ultimo intervento è, però, incompatibile con lo schema processuale della revisione, ancora saldamente ancorata -salvo il peculiare caso della revisione europea- all’alternativa secca tra proscioglimento o inammissibilità/rigetto ed è di pertinenza esclusiva del giudice dell’esecuzione, unico organo deputato a presidiare il rispetto della legalità nell’espiazione della pena.
Il che porta a concludere che nell’ampio genus dei rimedi rescissori del giudicato sia possibile operare una bipartizione tra rimedi propriamente volti a sanare l’ingiustizia della condanna (revisione), come tali esperibili dinanzi la giurisdizione cognitiva, e rimedi viceversa tesi a superare l’illegalità della sanzione penale e/o vizi del titolo esecutivo (incidente d’esecuzione) e come tali attribuiti al giudice dell’esecuzione.
Rispetto a tale contrapposizione, però, si situano istituti di difficile collocazione quali la rescissione del giudicato e la revisione europea sfuggenti ad ogni classificazione, ad ulteriore testimonianza -semmai ve ne fosse stato bisogno- della complessità del sistema, che è poi la complessità del diritto[21] e della realtà tutta[22].
Il presente volume non si prefigge allora lo scopo epistemologicamente scorretto -e comunque destinato inevitabilmente a rimanere frustrato- di ridurre una complessità ontologicamente irriducibile[23] ma di fornire al lettore un valido ausilio per orientarsi più agevolmente in tale complessità, sì da rispettarla, senza, però, rimanerne sopraffatto.
[1] V., da ultimo, V. Nardi, Retroattività in mitius e limite del giudicato: stato dell’arte e prospettive di riforma alla luce del quadro nazionale ed europeo, in Dir. pen. cont., 8 marzo 2019. Cfr., anche, G. Romeo, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di pena incostituzionale, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2014; F. Callari, La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Giuffrè, Milano, 2009; E. Mancuso, Il giudicato nel processo penale, in (diretto da) G. Ubertis – G.P. Voena, Trattato di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 8
[2] Ad esempio, per un uso giornalistico di tali espressioni, D. Stasio, Cassazione, cade il tabù del giudicato, in Il Sole 24 ore, 15 ottobre 2014.
[3] Ma anche il ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto almeno ove impiegato come strumento di adattamento alla dictum CEDU.
[4] Ne dà atto, tra l’altro, R.A. Ruggiero, Il ne bis in idem: un principio alla ricerca di un centro di gravità permanente, in Cassazione penale, 2017, n. 10, Giuffrè; e da ultimo A. Galluccio, Non solo proporzione della pena: la Corte Edu ancora sul bis in idem, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019.
[5] In questo senso, F. Caprioli -D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, Torino, 2010, p. 80.
[6] F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1223.
[7] V. ex multis, in termini analoghi, M. Bargis, Impugnazioni, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, (a cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2012, p. 1032. Per approfondimenti si rinvia al relativo capitolo.
[8] A. De Marsico, Diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1966, p. 328.
[9] A. Jannitti Piromallo, La revisione del giudicato penale. Ed. dell’Ateneo, 1947, p. 125.
[10] In argomento, anche, F. Callari, La revisione, Giappichelli, Torino, 2012, p. 265 e ss.
[11] Sul punto, oltre a rinviarsi al relativo capitolo, v., in relazione alla disciplina originaria, G. Ranaldi, La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta, in Processo penale e giustizia, fasc. 1, 2015
[12] In argomento, G. Illuminati, Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all’Europa, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2015
[13] F. Caprioli- D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 261 e ss.
[14] Si rinvia al relativo capitolo
[15] Sul principio di legalità della pena, R. Garofoli, Manuale di diritto penale, Neldiritto Editore, Molfetta, 2016, p. 9 e ss.
[16] Cfr. R. Garofoli, Manuale, cit., p. 205, ss.
[17] È il caso affrontato da Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858, in C.E.D. Cass., n. 260700 a causa della declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 69, comma 4, c.p.
[18] V. Cass., Sez. un., 28 luglio 2015, n. 33040, in C.E.D. Cass., n. 264205.
[19] Cfr. Cass., Sez. un., 15 settembre 2015, n. 37107, in Dir. pen. proc., 2016, 2, p. 177.
[20] Cfr. R. Garofoli, Manuale, cit., p. 206.
[21] V. G. Gembillo, La complessità del diritto, Guida Editori, Napoli, 2009.
[22] Tra le molte, impossibile non ricordare l’opera del “padre” della filosofia della complessità: E. Morin, La sfida della complessità/La défi de la complexité, Le lettere, Firenze, 2011.
[23] V. G. Gembillo, Le polilogiche della complessità. Metamorfosi della Ragione da Aristotele a Morin, Le Lettere, Firenze, 2008.


