I Test proiettivi nel giudizio sull'imputabilità
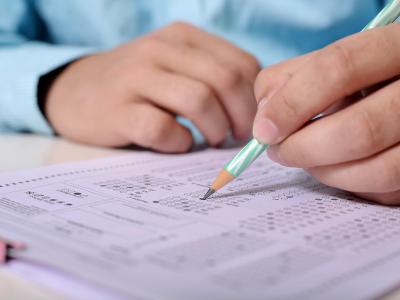
I Test proiettivi nel giudizio sull'imputabilità
Premesse introduttive
In epoca contemporanea, il CTU ed il consulente di parte sono chiamati a svolgere un esame psichiatrico che tenga conto di tutte le variabili analizzabili: quelle biofisiche, quelle intrapsichiche, quelle fenomenologiche, quelle comportamentali e quelle socio-culturali. Ciò che conta è interpretare l'intera personalità dell'infrattore, ivi compreso l'ambiente circostante, che ha una sua specifica centralità in tema di “motivi a delinquere” ex n. 1) comma 2 Art. 133 CP[1]. Ovverosia, l'imputato va osservato nella sua interezza oggettiva e soggettiva, come impone l'Art. 133 CP[2]. A tal proposito, De Cataldo Neuburger (1987)[3] afferma che “la questione tutt'ora aperta, soprattutto in ambito di ricerca psicologica, è che i diversi orientamenti che si occupano dello studio dello sviluppo della personalità tendono ad enfatizzare le loro tradizioni, non tenendo conto del fatto che nessun focus di osservazione è sufficiente per comprendere le componenti multidimensionali che concorrono nel modellare la struttura del carattere e della personalità”.
P.e., l'eventuale infermità/seminfermità potrebbe dipendere, soprattutto nella fattispecie del giovane adulto, da un malfunzionamento delle agenzie di controllo in età adolescenziale. Oppure, bisognerà indagare sul ruolo dell'educazione genitoriale. Oppure ancora, molto potrebbe variare nel caso di un sistema scolastico non idoneo. Ecco, dunque, l'importanza di quelle che De Cataldo Neuburger (ibidem)[4] definisce come “componenti multidimensionali”. Del resto, chi redige reputa profondamente erroneo l'approccio neuroscientifico, che riduce l'imputato ad una serie di secrezioni ormonali del cervello, senza poi indagare tutte le circostanze ambientali, sociali, familiari o pedagogiche che fanno da cornice al reato. Anche Gulota (1983)[5] insiste sulla multi-disciplinarietà dell'”esame della personalità in ambito penale nell'età adulta”; ma il lemma “personalità” comporta necessariamente un'analisi molto ampia dei requisiti soggettivi contemplati nel comma 2 Art. 133 CP.
D'altra parte, non pochi Dottrinari criticano aspramente il comma 2 Art. 200 Cpp in tema di “perizia psicologica” (“Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”). Del pari, Ferracuti (1989)[6] contesta la restrittività del comma 2 Art. 220 Cpp, in tanto in quanto, nella Prassi medico-legale, “ciò che avviene è un aumento delle perizie psicologiche mascherate da perizie psichiatriche, anche negli accertamenti sulla capacità d'intendere e di volere, ovvero sull'imputabilità in relazione all'eventuale presenza di infermità mentale (Artt. 85[7], 88[8] e 89[9] CP)”.
D'altronde, nel Diritto Penale Minorile, la perizia psicologica non afferente a patologie è fondamentale, giacché, nell'infra-18enne, la variabile del “carattere” è fondamentale, a prescindere dal comma 2 Art. 220 Cpp. P.e., De Leo (1991)[10] nota che, alla luce dell'Art. 9 del nuovo Processo penale minorile, “l'esame della personalità vine molte volte addirittura richiesto e specificato nei quesiti posti dal giudice”. Dunque, di fatto, il comma 2 Art. 220 Cpp viene superato da perizie psicologiche e criminologiche che indagano il carattere e la personalità del minore anche a prescindere da patologie mentali. Ciò che conta, pure nella fattispecie del maggiorenne, è addivenire alla comprensione dell'intera specificità dell'indole dell'infrattore, come dimostra, del resto, la notevole ampiezza dei quattro numeri del comma 2 Art. 133 CP. La perizia psicologica, quindi integrale, e, soprattutto, caratteriale è difesa pure da Fornari (1989)[11], specialmente allorquando l'infra-18enne risulta vittima di abusi sessuali o di maltrattamenti in famiglia. Analogamente, Ponti (1987)[12] nega l'applicabilità del comma 2 Art. 220 Cpp, in tanto in quanto necessitano “perizie del tutto particolari, più psicologiche che psichiatriche”. Del resto, chi scrive evidenzia che, anche nel DSM-V, il “carattere” ed i “condizionamenti” socio-ambientali possiedono oggi un rilievo che non sussisteva nei primi decenni del Novecento. P.e, alla luce degli Artt. 85, 88 ed 89 CP, non contano solamente le psicopatologie, ma anche “stati emozionali” che, nel Codice Rocco, erano ininfluenti.
Oppure ancora, in ambito civilistico, l'affidamento del minore in coppie separate richiede una perizia psicologica e non soltanto psichiatrica, quindi legata a patologie psichicamente destabilizzanti. Nuovamente, conta l'analisi della “personalità” della parte processuale in senso caratteriale, sociale, familiare ed ambientale, il che, poi, non toglie la ricerca di eventuali deficienze patologiche nel senso tradizionale. Con attinenza a tale tematica, Abbate & Capri & Ferracuti (1990)[13] contestano anch'essi il comma 2 Art. 220 Cpp ed osservano che “ovviamente, per quanto concerne un ambito, ad esempio, come quello dell'affidamento dei minori in coppie separate, l'esame psicodiagnostico dovrebbe essere orientato, tra gli altri esami, all'utilizzo dei Test di Personalità e Proiettivi integrati da una lettura necessariamente sistematico-relazionale della situazione e, quindi, del contesto familiare”. Anche in tal caso, come si vede, concentrare la perizia sulle sole psicopatologie non aiuta tale “lettura […] sistematico-relazionale della situazione e […] del contesto familiare”. In buona sostanza, torna la centralità del ruolo del “carattere” della parte processuale, anche in ambito civilistico.
Storia dei Test psicodiagnostici
Ellenberger (1986)[14] precisa che “i Test proiettivi-reattivi mentali (da collocare in un contesto di esame psichico comprendente anche l'anamnesi, il colloquio clinico ed i Test di livello e di personalità) appartengono ad un'epoca temporale, culturale, scientifica e di costume che non può essere scissa ed allontanata dalla psicanalisi, dalla sua storia, dalle teorie freudiane e junghiane, dalla scoperta dell'inconscio, che non era più un'astrazione filosofica, ma una fonte di energia ribollente che si manifestava sotto la maschera dei sogni, degli atti mancati e dei moti di spirito”.
Nei primi Anni Novanta del Novecento, nacquero i vari settori della psichiatria, quali la psicodiagnostica, la psicologia clinica, la psicologia dinamica e la psicopatologia. Entra tale contesto, i Test psicodiagnostici si trasformarono da esami psicofisiologici ad indagini strettamente psicologiche. Nel 1880, il biologo inglese Galton iniziò delle ricerche cc.dd. “psicometriche”, creando dei veri e propri censimenti criminologici della popolazione. Come riferito da Bini & Bazzi (1954)[15] “è a Galton che si fa risalire, avendolo lui usato per primo, nel 1883, il termine Mental Test, strumento o mezzo per saggiare la reazione specifica di un soggetto ad un determinato stimolo”. Tuttavia, Vagaggini (1987)[16] attribuisce a Cattell il primo Mental Test nel 1890. Da citare sono pure Binet & Simon (1905)[17], ossia i primi ad utilizzare una “scala metrica per l'intelligenza”, novellata nel 1908 e, successivamente, nel 1911. Va, comunque, precisato che assai più impiegata fu la “scala d'intelligenza” elaborata da Terman nel 1917 e da Terman e Merrill nel 1937. Nello stesso periodo, in Germania, Stern creò Test che si prefiggevano di predire il c.d. “successo scolastico”. Degno di menzione, sempre con afferenza ai Test psicodiagnostici, è il precursore di Thurstone, ossia Spearman (1930)[18], secondo cui “in ogni attività intellettuale si esprimono fattori intellettivi e fattori non intellettivi: tra i primi rientra il fattore G ed i fattori cc.dd. funzionali (abilità, esperienza verbale, pratica, fattori sociali); tra i secondi sono compresi l'interesse, la tenacia ed il desiderio di successo. Il fattore G è, quindi, un'entità che misura la capacità a svolgere un lavoro intellettuale”. Chi commenta non può mancare di rilevare il sottile determinismo lombrosiano che traspare dagli asserti alquanto apodittici di Spearman (ibidem)[19]. In effetti, negli Anni Venti del Novecento, in Europa e negli USA, si stava affermando una visione inadeguatamente algebrica del c.d. “quoziente di intelligenza (QI)”. Provvidenzialmente, meno rigido è Goleman (1995)[20], il quale precisa che il QI non va mai disgiunto dall'”Emotional Quotient -EQ-”, giacché il grado d'intelligenza non dipende da questa o quell'altra secrezione ormonale del cervello. D'altra parte, nei primi decenni del Novecento, Lombroso e Ferri esercitavano ancora il loro sinistro e fuorviante fascino pseudo-scientifico.
Ciononostante, tra la fine degli Anni Venti e l'inizio degli Anni Trenta del Novecento, molti Dottrinari si dissociarono dall'impiego acritico ed eccessivo della psicanalisi di Freud e Jung. Si iniziò, dunque, a parlare, nell'esame del reo di delitti violenti, di rivelazioni trasversali, longitudinali ed estensive. In particolar modo, la Medicina Legale principiò ad elaborare Test psicoattitudinali non basati esclusivamente sulla misurazione del QI (intelligence testing). Si tornò, pertanto, ad un'osservazione personologica integrale dell'infrattore, ove tenere nel debito conto tutte le variabili del carattere, dell'indole e di tutte le circostanze soggettive di cui parla il comma 2 Art. 133 CP. D'altra parte, il QI non fornisce una visione completa della personalità e degli eventuali traumi giovanili dell'imputato. Altrettanto basilare è l'analisi del rapporto tra il giudicando e le agenzie di controllo.
Un'ulteriore svolta giunse negli Anni Trenta e Quaranta del Secolo scorso, soprattutto con attinenza agli USA ed al Regno Unito. In particolar modo, Thurstone, in un Censimento criminologico su Chicago eseguito nel 1931, dimostrò che il QI e, più latamente, la capacità d'intendere e di volere necessitano di una “analisi multifattoriale” non limitata all'inconscio o ad altri dettagli marginali ormai superati dalle nuove conoscenze mediche. Anche nella Criminologia inglese, nel 1939, Thompson ed i suoi allievi condividevano la necessità di una “analisi multifattoriale sui reattivi mentali”. In buona sostanza, tra il 1930 ed il 1940, si stava comprendendo che l'eziologia della devianza non è monolitica e mono-causale. E' necessario prendere seriamente in considerazione tutte le circostanze del passato idonee a spiegare la nascita degli impulsi devianti. Finalmente, si riconosceva la centralità degli errori pedagogici durante l'infanzia e l'adolescenza e non ci si concentrava più sui Test relativi al solo QI, che non determina, in maniera decisiva, quelle che sono le variabili enunziate negli Artt. 85,88 ed 89 CP. Sempre nel periodo qui in esame, Wechsler (1939)[21], presso l'ospedale statunitense di Belleveu, fondò nuovi requisiti nella composizione di una “Scala d'intelligenza” utilizzata, poi, a livello globale per molti decenni. Tale “Wechsler Adult Intelligence Scale” venne novellata nel 1955 ed i suoi criteri sono tutt'oggi impiegati dalla Medicina Legale, in tanto in quanto essi corrispondono, com'è giusto che sia, ad un approccio “multifattoriale” che indaga l'intero sviluppo pedagogico del paziente. Detta “multi-fattorialità” è fondamentale, in particolar modo, nella valutazione dell'imputato infra-18enne e nel giovane adulto infra-25enne. Oppure, si ponga mente all'eziologia della delinquenza del minore di etnia rom, nei confronti del quale non è utilizzabile la scala di valori della psicanalisi dela fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Pure Fornari (ibidem)[22] nota la non idoneità della sola psicanalisi e delle teorie junghiane nella valutazione delle devianze. Ecco, dunque, la nascita dei primi Test Proiettivi.
Nel 1935 venne presentato, presso la Società svizzera di psichiatria, il Test di Rorschach, che, per il vero, era stato utilizzato sin dal 1921. Nel Dopoguerra, tra la fine degli Anni Quaranta e l'inizio degli Anni Cinquanta del XX Secolo, importante fu l'apporto, in tema di “reattivi mentali” degli italiani Rizzo, Gemelli, Metelli e Meschieri. Siffatti Dottrinari, finanziati dal CNR, introdussero, in Italia, i primi Test elaborati negli USA. Da segnalare è pure che, in un convegno della Società romana di Medicina Legale, Ferracuti (1959)[23] giunse ad affermare che “l'impiego dei Test in ambito forense è da collocare allo stesso livello ed alla stessa dignità scientifica delle altre metodologie dell'esame psichico”. Purtroppo, Ferracuti (1959)[24] rimase una voce inascoltata, perché la psicopatologia forense dell'epoca reputava non attendibili i Test psicodinamici, che si diffusero solo in seguito.
In effetti, sotto il profilo storico, Allport (1961)[25] osserva che “gli anni [presenti] sono anni in cui la psicodiagnostica ha avuto una rapida e marcata espansione, ma permane la tendenza negativa ad etichettare in modo semplicistico e superficiale ciò che emerge dai reattivi mentali in senso diagnostico-clinico, trascurando gli aspetti fondamentali della diagnosi psicologica, ovvero la valutazione per tratti di personalità”. Parimenti, Ponti (ibidem)[26] giunge amaramente ad evidenziare che “dall'inizio degli Anni Settanta e per quasi tutto un decennio, i Test subirono negativamente l'influenza culturale del momento, ovvero le tesi dell'anti-psichiatria, legate apparentemente al disconoscimento della malattia mentale e, quindi, alla critica degli inquadramenti nosografici come strumenti per diagnosticare e, dunque, per reprimere e patologizzare un individuo; ciò, oltre che per il particolare momento storico, anche in conseguenza degli abusi fatti con i Test, soprattutto negli anni immediatamente precedenti, a seguito, probabilmente, degli entusiasmi e della facilità con cui si potevano raggiungere delle diagnosi ottenute senza una corretta lettura statistico-interpretativa.
Come si nota, in Ponti (ibidem)[27] torna il problema di inserire i risultati dei Test nell'ambito di una più ampia “analisi multifattoriale”. Il Test è il punto di partenza e non quello d'arrivo. E' indispensabile analizzare tutte le eventuali ferite psichiche infantili ed adolescenziali dell'imputato, il cui QI è insufficiente a fornire una corretta analisi personologica. L'utilizzo dei Test venne rivalutato negli Anni Ottanta del Novecento, grazie soprattutto all'impiego del DSM, che, seppur indirettamente, ha dato man forte alla psicodiagnostica.
I Test proiettivi
Frank (1935)[28] ha coniato il neologismo “tecnica proiettiva”, che indica la possibilità di analizzare il paziente con Test di personalità affondanti le loro radici nella cultura psicanalitica europea e statunitense. Sempre Frank (ibidem)[29] sosteneva che “una tecnica proiettiva [quella dei Test], fondamentalmente, è un metodo di studio della personalità che consiste nel mettere il soggetto di fronte ad una situazione alla quale egli risponderà conformemente al significato che questa situazione ha per lui, alla sua maniera di sentire, in pratica al suo Erlebniss, al suo vissuto [inconscio, ndr]”. Tale è pure il parere di Bini & Bazzi (ibidem)[30], ovverosia “i [Test] reattivi mentali sono definiti proiettivi quando determinano nel soggetto l'espressione inconscia della propria personalità o di alcuni tratti di questa. E' per questo motivo che i Test proiettivi forniscono al soggetto un materiale non strutturato, che consente ampie possibilità di elaborare le risposte”. Utile è pure la posizione anti-psicanalitica di Gulota (1983)[31], il quale precisa che “per quanto riguarda il termine proiezione, utilizzato per individuare alcune prove psicologiche (Test Proiettivi), esso presenta sostanziali differenze con il significato originario attribuitogli dalla psicanalisi. Infatti, quest'ultima definiva, con Freud, la proiezione come meccanismo per l'attribuzione inconscia di propri sentimenti e qualità ad un'altra persona, come difesa dell'Io, in quanto un sentimento proprio, spiacevole, viene meno penosamente risentito se riferito ad altri”.
Del pari, in tema di Test psicodinamici, Cusin (1991)[32] nega il concetto freudiano di “proiezione”, nel senso che “per Jung ed i post-freudiani, invece, il concetto della proiezione si basa sul fatto che [la proiezione] può essere un meccanismo normale o patologico a seconda dei casi e può essere utilizzato dall'Io come difesa dall'ansia. Inoltre, il concetto di proiezione aveva assunto una posizione del tutto particolare, in Freud, tra i meccanismi di difesa dell'Io; in Jung, come processo-base nel passaggio psicodinamico tra coscienza ed inconscio” Pertanto, come si nota, la Dottrina più recente ha affrancato i Test Proiettivi dalla dittatura della psicanalisi freudiana. Oggi, come pocanzi detto, l'approccio è “multifattoriale”, anche se la ratio dell'”inconscio” rimane basilare.
Detto con estrema sintesi, come risulta dall'analisi di Delay & Pichot (1984)[33], “le caratteristiche più significative dei Test Proiettivi possono essere riassunte nei seguenti punti:
a. L'obiettivo dei Test Proiettivi [contrariamente a quanto disposto dal comma 2 Art. 220 Cpp, ndr] è quello di analizzare nell'insieme la personalità del soggetto esaminato, o anche valutare alcuni aspetti particolari, ma sempre inseriti in un contesto globale […]. Per questa ragione, non è prevedibile né possibile una descrizione della personalità per tratti indipendenti fra loro, in quanto il tutto appartiene ad una concezione olistica della personalità.
b. Gli stimoli prodotti dai Test Proiettivi consentono un gran numero possibile di risposte diverse […] [poiché] ogni individuo è unico e risponderà, perciò, in modo diverso da un altro soggetto, in quanto si esprimerà nel suo insieme e modo d'essere nella risposta. Ciò è la caratteristica essenziale delle prove proiettive
- I Test Proiettivi esplorano soprattutto gli aspetti affettivi e volitivi, ma, essendo fondati concettualmente su una percezione totale della personalità, forniscono indici e dati relativi anche all'aspetto cognitivo, in quanto quest'ultimo fa parte integrante della personalità
- I criteri interpretativi derivano, in misura consistente, dalla psicanalisi o, meglio, più correttamente, dalla psicologia dinamica, anche se i risultati dei Test Proiettivi potrebbero essere interpretati secondo i presupposti teorici di altre Scuole di pensiero sulla personalità. La realtà, però, è che la maggioranza degli Autori di tecniche proiettive sono psicanalisti, che l'interpretazione delle prove proiettive prende spunto dalla psicologia dinamica e dalla psicanalisi e che, infine la loro diffusione ha seguito quella della psicanalisi nel tempo e nei contesti culturali dell'Occidente”.
A parere di chi commenta, gli asserti di Delay & Pichot (ibidem)[34] rimarcano l'importanza predominante della perizia psicologica su quella della perizia psichiatrica. Dunque, a differenza di quanto statuito dal comma 2 Art. 220 Cpp, il reo va analizzato nell'interezza della propria personalità, che non dipende solo da condizioni patologiche. Questo è vero soprattutto nella perizia/consulenza di parte afferente all'imputato minorenne, la cui devianza dev'essere sempre valutata dal Magistrato alla luce di tutto il vissuto dell'infrattore adolescente. Non contano solo le deficienze psichiche, ma anche tutto il contesto ambientale e caratteriale enunziato dal comma 2 Art. 133 CP. P.e., gli “stati emotivi o passionali”, nonostante l'apodittico Art. 90 CP[35], escludono o diminuiscono l'imputabilità dell'infra-18enne e del giovane adulto. Oppure ancora, nei Test Proiettivi, hanno piena cittadinanza i disturbi del carattere, perlomeno quando essi sono invalidanti. Il giudice è tenuto a valutare tutta la personalità del giudicando, senza ipostatizzare le sole malattie psichiche cagionanti infermità/seminfermità. P.e., nella fattispecie del giovane straniero borderline, sarà indispensabile calare la devianza etero-lesiva nel contesto personologico e nelle carenze di base cagionate da agenzie di controllo mancanti o malfunzionanti. Da cui, l'errore palese del comma 2 Art. 220 Cpp in tema di “carattere” e di “qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.
Il Test di Rorschach
E' innegabile che il Test di Rorschach affonda le proprie radici nella ratio psicanalitica della riemersione dell'inconscio. Infatti, Bohm (1969)[36] contestualizza questo Test affermando che “l'interpretazione libera di forme ambigue è certamente molto antica: infatti, in tutte le epoche ed in molte culture, ciò ha rappresentato un gioco, un esercizio magico o divinatorio ed i bambini, come gli artisti o i poeti, si sono spesso sfidati a scoprire delle forme in un cielo nuvoloso, in un muro macchiato di umidità o in altre situazioni possibili”. Rorschach ha ispirato il proprio Test ad un gioco, molto diffuso in Svizzera ed in Germania, chiamato “Klecksographie”, consistente nel macchiare un foglio di carta con dell'inchiostro, per poi piegarlo, riaprirlo ed interpretare le macchie.
Anche Costantino & Flanagan & Malgday (1995)[37] mettono in risalto che “l'origine del metodo psicologico delle macchie d'inchiostro si situa in un contesto pre-scientifico”. In realtà, il Test di Rorschach ha dei precursori; ovverosia, la lettura psicanalitica delle macchie d'inchiostro fu utilizzata, per la prima volta, da Binet, nel 1895 e, successivamente, da Dearborn, negli USA, nel 1897. Interessante, nella psicologia dinamica, fu pure l'utilizzo della Klecksographie da parte di Sharp, nel 1899, e di Kirkpatrick nel 1900. Sempre negli USA, Wipple, nel 1910, elaborò un Test composto da 20 macchie, al fine di studiare le capacità immaginative dei pazienti. Da menzionare, nella Russia del 1910, sono pure le 8 immagini dello psicologo moscovita Rybakoff. Nel 1917, a Zurigo, il laureando Hens elaborò la prima tesi di laurea sull'interpretazione delle macchie d'inchiostro nella psicopatologia forense. Tuttavia, il Test “delle macchie” venne migliorato e, finalmente, approfondito solamente da Rorschach, nel 1921, nella sua Opera intitolata “Psychodiagnostik”. Come riferito da Bash (1972)[38], “le origini culturali e scientifiche di Rorschach [e del suo omonimo Test] devono essere fatte risalire necessariamente alla psicanalisi […]. Infatti, in quel periodo a Zurigo, si stava svolgendo una straordinaria rivoluzione culturale, in quanto Freud – allora giovane e senz'altro ancora molto poco accreditato dalle Società Internazionali di Psichiatria, pregne di concezioni materialistiche ed organistiche [e lombrosiane, ndr]- stava proponendo al mondo scientifico le sue nuove idee, che erano state ignorate o respinte per una decina d'anni, ed ora, per la prima volta, venivano introdotte e discusse anche in ambito universitario”.
Il Test di Rorschach venne apprezzato e sostenuto soprattutto da Jung (1904/1984)[39], secondo il quale “con i Test delle associazioni verbali […] si possono indagare e conoscere meglio anche i processi psicotici – non solo, quindi, le nevrosi -, le cui origini psichiche erano prima sconosciute. Pertanto, finalmente, [nel Test di Rorschach] l'inconscio trova una sua collocazione primaria nell'interesse psichiatrico e psicologico, e non va più considerato un concetto astratto esclusivo patrimonio della filosofia”. Dopo anni di sottovalutazione, nel 1911, Rorschach iniziò a sperimentare l'interpretazione delle macchie d'inchiostro presso l'ospedale cantonale di Munsterlingen in Thurgau. In particolar modo, il Test di Rorschach, unito al Test junghiano delle associazioni verbali, recò ad ottimi risultati nella diagnosi dell'isteria e della psicoastenia, reputate, in psicanalisi, le besi, rispettivamente, dell'estroversione e dell'introversione. Interessante è quanto affermato pure da Ellenberger (ibidem)[40], a parere del quale “non è difficile notare, nelle teorie di Rorschach, il richiamo alle concezioni di estroversione ed introversione di origine junghiana, quantomeno come approccio iniziale per lo sviluppo di ciò che viene definito il cuore del Test, ciò che, in pratica, sarebbe alla base di tale costruzione teorica e scientifica, [ovvero] l'Erlebnistypus, o tipo di vita interiore, tipo di risonanza intima, quindi la definizione di una struttura di personalità”. Tuttavia, come osserva Bohm (ibidem)[41], “il Test di Rorschach […] ebbe enormi difficoltà ad essere accettato quando il suo autore era in vita. Infatti, in Europa, urtò contro l'incomprensione e l'opposizione delle stesse Scuole di pensiero che una volta avevano contrastato la strada anche alla psicanalisi. [Il Test di Rorschach] trovò, in Svizzera, indifferenza ed in Germania subì, addirittura, critiche feroci. Per molto tempo, il Test di Rorschach, prima e dopo la morte del suo autore, subì ostracismo e quell'opposizione ostinata ed ottusa riservata anche alla psicanalisi di Freud”. Soltanto nel 1935, in Svizzera, nacque la “Scuola svizzera del Rorschach”. Dopodiché, il predetto Test iniziò ad essere ampiamente impiegato in tutta Europa nell'allestimento delle perizie psichiatriche forensi in tema di infermità/seminfermità mentale dell'imputato.
Tutto ciò premesso, non si può negare che la Medicina Forense abbia sovente abusato dei Test Proiettivi e, specialmente, del Rorschach. P.e., in maniera apodittica ed oltranzista, Silvestein (1996)[42] sostiene, con cieca fiducia, che “tale reattivo [il Test di Rorschach] va riconosciuto come strumento tecnico proiettivo assolutamente valido e significativo al fine di esplorare le dinamiche intrapsichiche individuali”.
Parimenti, Weber & Reid & Giacono (1992)[43] evidenziano anch'essi, in modo supino e restrittivo, che “il Rorschach possiede, se correttamente utilizzato, quei requisiti necessari e fondamentali per poter fornire, in ambito forense, soprattutto dal punto di vista qualitativo, informazioni approfondite sulla personalità, sulla sfera cognitiva, su quella affettiva e sulla struttura dell'Io, sia nella fase di sviluppo dell'età evolutiva, sia nella fase più definita dell'età adulta”. Forse, i summenzionati Autori dimenticano che il Magistrato, nel proprio libero e prudente apprezzamento, non è necessariamente e tassativamente vincolato al Test di Rorschach. Ovverosia, la perizia psichiatrica del CTU non va assolutizzata, nemmeno in ambito civilistico, in tanto in quanto l'osservazione personologica del giudice è e rimane prioritaria nonché indipendente. Pertanto, erra Cameron (1942)[44] nell'asserire, con eccessivo entusiasmo, che il Rorschach sarebbe strutturato “con una precisione tale da essere una radiografia della personalità”. Anche in tal caso,m si propugna l'idea di una psicologia dinamica tracotante che pretende, al pari delle neuroscienze, di sostituire il Diritto. Di nuovo, giova ricordare che il Magistrato può, non deve allinearsi alle conclusioni dello psichiatra/CTU. P.e., Faust & Zikin (1988)[45] parlano di un “abuso della psicologia, che a volte ha strumenti inattendibili […]. Per esempio, alcuni clinici credono che soggetti che disegnano figure umane con occhi accentuati avrebbero tratti della personalità paranoidi […]. I clinici continuano ad usare il disegno di persona nonostante l'evidenza scientifica che smentisce l'associazione tra occhi accentuati e paranoia”. Anzi, nella Criminologia anglofona, più di un Dottrinario ha denunziato che il Rorschach viene interpretato spesso in maniera erronea da medici non adeguatamente muniti della necessaria esperienza. Oppure, si sottovaluta, nella perizia psichiatrica, il ruolo pur sempre fondamentale di colloqui attenti ed approfonditi che debbono sempre precedere il Rorschach. Entro tale ottica, Faust & Zikin (ibidem)[46] mettono in risalto, senza troppe remore, che “per quanto riguarda i Test, riteniamo che contribuiscono a renderli fallibili soprattutto il cattivo utilizzo e la scarsa esperienza e professionalità di chi li effettua”. Ciò vale specialmente quando ad essere sottoposto al Rorschach è l'infrattore in età evolutiva, dunque non totalmente maturato.
[1]n. 1) comma 2 Art. 133 CP: [Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
[2]Art. 133 CP
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'Articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità
dell'azione
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
3) dall'intensità del dolo o dal grado della colpa
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo
[3]De Cataldo Neuburger, Il carattere, i motivi, la condotta e l'ambiente come indizi di personalità, di capacità a delinquere e di pericolosità, in Gulotta, Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1987
[4]De Cataldo Neuburger, op. cit.
[5]Gulota,Psicologia e processo: lineamenti generali, in Gulota, Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1983
[6]Ferracuti, Conclusioni, in Capri, Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il test di Rorschach, Attualità in psicologia, Vol. 4, n. 1, EUR, Roma, 1989
[7]Art. 85 CP
Capacità d'intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile
E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere
[8]Art. 88 CP
Vizio totale di mente
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere
[9]Art. 89 CP
Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita
[10]De Leo, Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile, in Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, Milano, 1991
[11]Fornari, Psicopatologia e Psichiatria forense, UTET, Torino, 1989
[12]Ponti, Perizie sulla parte offesa e sul testimone, in Gulotta, Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1987
[13]Abbate & Capri & Ferracuti, La diagnosi psicologica in Criminologia e Psicologia Forense. I test psicologici, in Ferracuti, Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense, Vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1990
[14]Ellenberger, I movimenti di liberazione mitica, Liguori, Napoli, 1986
[15]Bini & Bazzi, Trattato di psichiatria, Vol. 1, Psicologia medica, Valardi, Milano, 1954
[16]Vagaggini, I Test psicologici nel sistema penale, in Gulotta, Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, in Gulotta, Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1987
[17]Binet & Simon, Méthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux, Année Psychol., Vol. 2, 1905
[18]Spearman, La théorie des facteurs, Arch. de Psychol., Vol. 22, 1930
[19]Spearman, op. cit.
[20]Goleman, Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, 1995
[21]Wechsler, The measurement of adult intelligence, William & Wilkins, Baltimore, 1939
[22]Fornari, op. cit.
[23]Ferracuti, Sulla metodologia psicologica della personalità e fini medico-legali, Zacchia, LXIII, 1959
[24]Ferracuti, op. cit.
[25]Allport, Pattern and growth in personality, Holt Rinehart and Wiston, New York, 1961
[26]Ponti, op. cit.
[27]Ponti, op. cit.
[28] Frank, Projective methods for methods for the study of personality, Journal of Psychology, n. 389/1935
[29]Frank, op. cit.
[30]Bini & Bazzi, op. cit.
[31]Gulota, Separazione, divorzio e affidamento dei figli: presente e futuro, in Cigoli & Gulota & Santi, Separazione, divorzio e affidamento dei figli. Tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Giuffrè, Milano, 1983
[32]Cusin, Il processo di Rorschach. Note sulla teoria e sulla tecnica, in Aguglia & Cusin & De Vanna, L'uso clinico del Rorschach, Franco Angeli, Milano, 1991
[33]Delay & Pichot, Compendio di Psicologia, Giunti Barbera, Firenze, 1984
[34]Delay & Pichot, op. cit.
[35]Art. 90 CP
Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità
[36]Bohm, Manuale di psicodiagnostica di Rorschach, Giunti Barbera, Firenze, 1969
[37]Costantino & Flanagan & Malgday, The History of Rorschach: Overcomind Bias in Multicultural Projective Assessment, Rorschachiana, Vol. 20, Hogrefe & Huber, Gottiungen, 1995
[38]Bash, The soul image: Anima and Animus as projected in the Rorschach Test, Journal of Personality Assessment, Vol. 36, Erlbaum Publisher, New Jersey, 1972
[39]Jung, L'associazione verbale negli adulti normali (1904), Boringhieri, Vol. 2, Tomo I, Torino, 1984
[40]Ellenberger, op. cit.
[41]Bohm, op. cit.
[42]Silvestein, Teaching the Rorschach and Learning Psychodiagnostic Testing: A Commentary on Hilsenroth and Handler (1995), Journal of Personality assessment, Vol. 66, n. 2, Erlbaum Publisher, New Jersey, 1996
[43]Weber & Reid & Giacono, A Rorschach Study of Attachment and Anxiety in Inpatient Conduct – Disordere and Dystynimic Adolescent, Journal of Personality Assessment, Vol. 58, Erlbaum Publisher, New Jersey, 1992
[44]Cameron, The Rorschach experiment: Xray of personality, Dis. Nerv. Sis., n. 3/1942
[45]Faust & Zikin, Expert Witness in Psychology and Psychiatry, Science, n. 241/1988
[46]Faust & Zikin, op. cit.



