La Comunità Designata: il baricentro dimenticato della conservazione digitale
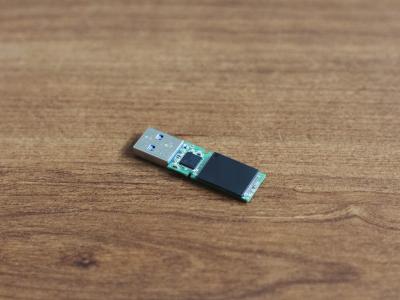
La Comunità Designata: il baricentro dimenticato della conservazione digitale
Introduzione
Parlare di Comunità Designata (Designated Community) significa affrontare uno dei concetti più solidi e strutturali della conservazione digitale affidabile. Eppure, nel panorama italiano dei conservatori, qualificati e non, questo concetto rimane purtroppo (il più delle volte) estraneo.
Chi sono le Comunità Designate di questi soggetti? Nella pratica, i conservatori conservano per conto di clienti pubblici e privati documenti come PEC, fatture elettroniche, documenti fiscali e contabili, libri unici del lavoro (LUL), contratti, progetti. Ma a chi si rivolgono queste informazioni nel lungo periodo? Quali basi di conoscenza vengono prese in considerazione?
Se guardiamo con occhio critico, emerge che la gran parte dei conservatori non definisce alcuna Comunità Designata, né ragiona su chi debba comprendere quei documenti tra venti, cinquanta o cento anni. Si limitano a garantire durata tecnica e integrità giuridica, senza interrogarsi sulla comprensibilità futura.
Questo genera un divario: da un lato la normativa internazionale (OAIS, ISO 16363), che fa della Comunità Designata un perno concettuale e operativo; dall’altro la prassi nazionale, che troppo spesso riduce la conservazione a mera custodia fiscale.
Che cos’è la Comunità Designata
Secondo lo standard OAIS ISO 14721:2025, la Comunità Designata è “un gruppo identificato di potenziali consumatori che dovrebbero essere in grado di comprendere un particolare insieme di informazioni”.
Il punto centrale è che la conservazione digitale non si esaurisce nel mantenere intatti dei bit, ma deve garantire che le informazioni siano ancora comprensibili e utilizzabili da chi ne avrà bisogno in futuro. La definizione della DC spetta al repository stesso e può evolvere nel tempo: si può avere una comunità generalizzata (es. cittadini con istruzione di base e accesso a un browser web) o più comunità distinte con esigenze specialistiche.
La centralità nella ISO 16363:2025
La ISO 16363:2025 Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories ha reso la Comunità Designata una metrica normativa di audit.
In sede di certificazione, un auditor deve poter verificare:
- che la DC sia definita in modo chiaro e documentato,
- che la sua base di conoscenza sia esplicitata,
- che le informazioni siano Independently Understandable da quella comunità, come previsto da OAIS.
Senza questa definizione, un repository non può essere considerato affidabile, perché manca il legame tra ciò che conserva e chi dovrà comprenderlo.
Comunità Designata e Pubblico generale
Uno degli equivoci più comuni è immaginare che la Comunità Designata coincida con il pubblico generale. Ma la realtà è molto diversa.
Gli standard OAIS (ISO 14721) e ISO 16363:2025 sottolineano che il repository non è obbligato a rendere i propri contenuti comprensibili a chiunque, bensì alla comunità (o alle comunità) che ha scelto e dichiarato come riferimento.
Questo significa che:
- Un archivio nazionale può avere come Comunità Designata i cittadini con un determinato livello di istruzione e competenze digitali, ma non i bambini o le persone prive di strumenti tecnologici.
- Un archivio specialistico (es. dati medici, GIS, archeologici) non deve garantire la comprensibilità “indipendente” al cittadino medio, ma ai professionisti del settore.
L’elemento cruciale è che la definizione di Comunità Designata permette di stabilire aspettative realistiche e misurabili.
Rendere la Teoria della Relatività comprensibile a un laureato in fisica è un obiettivo praticabile, renderla comprensibile a un bambino di sei anni non lo è.
Questa distinzione ha implicazioni enormi per:
- le strategie di rappresentazione (quanta metadatazione e documentazione tecnica va prodotta),
- le risorse necessarie (più la comunità è eterogenea, più la documentazione deve essere dettagliata),
- la valutazione in sede di audit: il repository deve dimostrare coerenza tra ciò che dichiara (chi è la DC) e ciò che produce (Representation Information).
In sostanza, senza Comunità Designata rischiamo di cadere in una promessa irrealistica: l’accessibilità universale. Con la DC, invece, la conservazione diventa mirata, verificabile e sostenibile.
Esempi tipici di Comunità Designata
Gli standard offrono esempi paradigmatici che mostrano come la DC possa variare moltissimo in base al dominio e al contenuto. Alcuni sono classici (pubblico istruito con browser web, ricercatori GIS, astronomi FITS, studenti di Middle English con TEI/XML).
Ma possiamo aggiungerne di nuovi e contestualizzati:
Comunità scientifica
- Esempio: ricercatori di biologia molecolare, con accesso a database genomici e conoscenza di linguaggi di markup scientifico (es. XML o JSON strutturato per dati bioinformatici).
- Implicazione: il repository deve garantire che i dati genetici siano accompagnati da metadati standardizzati (es. MIAME per i microarray), e che la Representation Information includa protocolli sperimentali comprensibili per quella comunità.
Storici e archivisti
- Esempio: studiosi di storia medievale con conoscenza del latino tardo e accesso a sistemi di codifica testuale come TEI per i manoscritti.
- Implicazione: il repository deve fornire glossari, trascrizioni normalizzate e strumenti di visualizzazione che rendano leggibili i documenti anche a distanza di secoli, preservandone autenticità e contestualizzazione.
Comunità tecnico-scientifica in ambito spaziale
- Esempio: ingegneri e ricercatori che utilizzano dati di missioni satellitari in formato FITS o HDF5.
- Implicazione: il repository deve includere manuali e software viewer aggiornati che rendano comprensibili i dataset anche quando i sistemi operativi e le librerie originali diventeranno obsoleti.
Studenti e docenti
- Esempio: studenti universitari di archeologia digitale con conoscenza limitata di linguaggi di markup, ma familiarità con strumenti GIS open source.
- Implicazione: le Representation Information devono essere più divulgative rispetto a quelle pensate per una comunità di ricercatori senior, bilanciando rigore e accessibilità.
Ogni esempio mostra come la Comunità Designata non sia definita solo in base a “chi” (l’identità), ma anche a “cosa conosce” (la sua base di conoscenza) e a “cosa ha a disposizione” (strumenti e ambienti tecnologici).
È questa triade che permette di stabilire se un repository stia davvero adempiendo alla sua missione di conservazione.
Impatti su policy e strategie di conservazione
La definizione della Comunità Designata non è un atto formale isolato, ma il fulcro che orienta tutte le policy di conservazione e le strategie operative di un repository.
Un repository che non definisce con chiarezza la propria DC rischia infatti di elaborare politiche generiche, incapaci di guidare in modo efficace le scelte tecniche.
La ISO 16363:2025 stabilisce che il repository deve avere documenti autorizzati dalla direzione – come il Preservation Strategic Plan, la Preservation Policy e il Preservation Implementation Plan – e che questi devono essere coerenti tra loro. Se la Comunità Designata non è chiaramente identificata, tali documenti diventano meri enunciati di principio.
Un esempio pratico: se la DC è costituita da ricercatori scientifici che utilizzano formati complessi come FITS o HDF5, la Preservation Policy deve prevedere azioni specifiche per preservare non solo i file ma anche i software e la documentazione necessari a interpretarli. Al contrario, se la DC è composta da cittadini o studenti, il repository dovrà privilegiare formati di lunga durata e strumenti di consultazione intuitivi.
In altre parole, la Comunità Designata è il criterio di coerenza che trasforma le policy da astratte a operative, e la sua definizione incide su ogni fase: dalla selezione dei formati, alla gestione delle migrazioni, fino alle modalità di accesso e fruizione.
Connessioni con altre normative di settore
La forza concettuale della Comunità Designata è che non rimane confinata al dominio OAIS/ISO 16363, ma dialoga con altri quadri normativi e regolatori.
La ISO 15489 sul records management mette al centro il concetto di utente e delle sue esigenze di accesso e uso: la DC diventa quindi un modo per tradurre queste esigenze nel contesto della conservazione digitale.
Il CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) insiste sulla fruibilità dei documenti informatici nel tempo, un principio che si concretizza proprio nel garantire la comprensibilità indipendente per comunità specifiche.
Il GDPR (Reg. UE 2016/679) introduce il principio della trasparenza e della comprensibilità delle informazioni, soprattutto per i dati personali: un concetto affine all’obbligo, per i repository, di rendere le informazioni “intelligibili” alla loro DC.
nfine, il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) sottolinea che i beni culturali devono essere conservati e resi fruibili per la collettività. Se trasposto in chiave digitale, questo principio corrisponde all’idea di garantire che la memoria digitale non rimanga chiusa in silos tecnologici, ma sia accessibile a chi ne ha titolo e competenza.
Questa convergenza mostra come la Comunità Designata non sia un tecnicismo di settore, ma un concetto che risponde a valori più ampi: diritto all’informazione, responsabilità verso la collettività, trasparenza e accountability.
Audit, trasparenza e fiducia
L’aspetto forse più concreto della Comunità Designata emerge nel contesto dell’audit e della certificazione. La ISO 16363:2025 richiede infatti che un repository non solo dichiari chi è la propria DC, ma che lo dimostri con evidenze verificabili.
Un auditor deve poter chiedere:
- “Come avete definito la vostra Comunità Designata?”
- “Quali sono le basi di conoscenza che avete assunto come riferimento?”
- “Come verificate periodicamente che i vostri contenuti siano ancora comprensibili per questa comunità?”
In questo senso, la DC diventa il banco di prova della trasparenza del repository. Non basta più dire “abbiamo preservato i file”: bisogna mostrare come quei file, arricchiti da Representation Information, restino comprensibili e usabili per la comunità di riferimento.
La trasparenza è anche una questione di fiducia pubblica. Un repository che rende visibile la propria DC e le proprie scelte di conservazione dimostra di avere una visione strategica e responsabile. Ciò accresce la fiducia di finanziatori, stakeholder, comunità scientifiche e utenti finali, consolidando la reputazione del repository come “trustworthy”.
La Comunità Designata non è un artificio teorico, ma il baricentro della conservazione digitale affidabile.
È il parametro che collega missione istituzionale, policy di conservazione, strategie tecniche e trasparenza nei confronti degli utenti e degli auditor.
Definirla con precisione significa tradurre la missione in pratica: garantire che i documenti digitali non solo sopravvivano, ma restino significativi, comprensibili e fruibili per chi ne avrà bisogno in futuro.
Se la conservazione digitale è l’arte di preservare la memoria, la Comunità Designata è la bussola che indica per chi quella memoria deve restare viva. Senza di essa, il rischio è accumulare dati privi di senso, con essa, ogni repository diventa non solo un archivio di bit, ma un ponte tra il presente e il futuro della conoscenza.



