Recensione a E.M. Ruffini, Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi
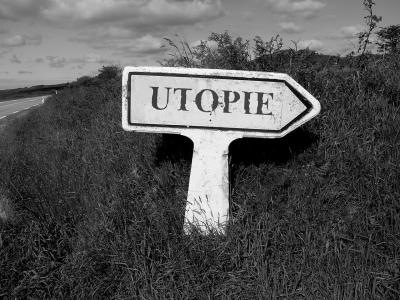
Recensione a E.M. Ruffini, Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi, Feltrinelli, Milano, 2022, pp. 1-384.
Si è atteso un congruo lasso di tempo prima di “metter mano” al volume consegnato all’editoria da Ernesto Maria Ruffini, uno dei dirigenti pubblici più rinomati del panorama italiano. La scelta non è casuale, data la necessità di soffermarsi sulle ragioni che abbiano potuto indurre l’ex dirigente del “colosso” fiscale della nostra Pubblica Amministrazione a richiamare l’attenzione del cittadino medio – aspetto di rilievo – su uguaglianza, diritti, speranze e democrazia, parole-chiave che spingono l’Autore a prendere le distanze dalle politiche austere proprie dell’ambito di appartenenza.
Il titolo del testo “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi” rivela apertamente l’intento perseguito dall’Autore, ossia quello di raccontare la storia di un’utopia, nata dai sogni, dalle speranze e dalle aspettative degli italiani alla fine del tragico periodo bellico, nei giorni della Liberazione e della stagione storica durante la quale furono poste le basi del nostro vivere insieme. Il prestigio dell’opera trova riscontro non solo nella presentazione dello stessa presso i più vari ed accreditati atenei universitari, ma anche nell’autorevole prefazione solennemente concessa dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al quale Ruffini deve l’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In particolare, il Presidente Mattarella sottolinea come l’opera induca a riflettere sulla radice della parola “Parlamento”: “il luogo dove le parole costituiscono, fondano, la nostra identità senza congelarla in un massacro”, ricordando che “le parole scritte nelle raccolte legislative rischiano di rimanere fissate solo sulla carta se non sono anche accompagnate dalla capacità di ognuno di fare il proprio dovere, di sentirsi parte di una comunità”. La figura istituzionale “per eccellenza” riconosce al volume in oggetto il merito di rivolgersi – specialmente – ai più giovani, perché “parla alla loro speranza e, raccontando la fatica, il dolore, l’impegno civile di tanti italiani che hanno scritto con le loro vite la storia della Repubblica, ci dice come sia inestimabile il valore della nostra libertà”.
Tra quelle parole che costruiscono e uniscono – riprendendo sempre la saggia voce del Presidente Mattarella – spicca l’uguaglianza, riconducibile all’art. 3 Cost., ritenuto da Ruffini “la più bella presentazione di un moderno Stato democratico”. L’Autore ricorda che i Costituenti decisero di collocarlo tra i principi fondamentali affinchè avrebbe dovuto trovare costante applicazione nella vita quotidiana, senza mai essere posto in discussione. Tuttavia, egli si mostra ben consapevole delle cospicue difficoltà incontrate dal legislatore ordinario nell’applicazione coerente del principio di fronte alle sfide della società odierna; ciò si è tradotto nel “tradire” il solenne impegno affidatogli dal legislatore costituzionale. È risaputo il ruolo cruciale assunto dalla Consulta – specie nel corso degli ultimi decenni di vita repubblicana – nella difesa e corretta implementazione del principio in discussione: sebbene il suo percorso non si sia rivelato sempre lineare e privo di dietrofront, è soltanto grazie all’interpretazione offertaci dalla Corte costituzionale del principio di eguaglianza che sono state mitigate sostanzialmente le diseguaglianze caratterizzanti il nostro Paese.
In seguito, l’attenzione si sposta sullo stato di attuazione, in sede legislativa, di tale principio nei diversi campi: nella giustizia, nella libertà delle opinioni, nell’informazione, nella libertà di religione, nelle relazioni familiari, nell’istruzione, nella sanità, nel lavoro, nell’immigrazione, nelle carceri, nei partiti e nel fisco. È proprio quest’ultimo a richiedere maggiore considerazione, investendo in prima persona l’Autore. Senza titubanze, Ruffini
ammette che l’art. 53 Cost., incentrato su struttura e funzione del sistema tributario, stride sempre più con la configurazione attuale del fisco italiano, non esitando a denunciare una serie di vili ingiustizie: dalle normative derogatorie e tassazioni separate alla parziale ed asimmetrica applicazione della progressività. In tale ottica, egli condanna talune politiche opportunistiche (ad esempio, la prassi dei condoni/scudi fiscali), in radicale antitesi con l’idea di solidarietà e tese esclusivamente a procurare risorse immediate. Alla luce di ciò,
un primo passo in avanti è dato dalla presa d’atto – da parte tanto delle Istituzioni quanto della società – che soltanto passando dall’azione di contrasto all’evasione fiscale il nostro Paese potrebbe avvicinarsi ad esiti di maggiore giustizia sociale.
L’Autore offre spazio altresì al rapporto tra legislazione e amministrazione, oggetto di antichi dibattiti. Nella costruzione montesquiana, l’amministrazione non è intesa come una dimensione autonoma e distinta, ma come parte integrante del potere esecutivo, che si esprime nelle funzioni statali sia di governo sia, appunto, di amministrazione. Difatti, i primi tratti singolari della sfera amministrativa si palesano con l’affermarsi del principio della “rule of law” e della supremazia del potere legislativo su quello esecutivo. Se da un lato è impensabile configurare la totale subordinazione dell’amministrazione alla politica, dall’altro è parimenti inverosimile prospettare una piena separazione tra esse. Pertanto, è
fortemente sentita la necessità di trovare un equilibrio che consenta la convivenza di due istanze opposte: quella delle forze politiche, che rifacendosi al principio di responsabilità ministeriale considerano l’amministrazione un loro strumento e quella dei burocrati, che
rivendicano un crescente spazio di libertà operativa all’interno della propria sfera.
La peculiarità del volume è quella di “accorciare” le distanze dall’età costituente; ciò trova valida conferma nella prefazione dello stesso Presidente Mattarella: pur essendo abituati a vivere nel presente, siamo tenuti comunque a rimembrare che proprio “su quella straordinaria esperienza abbiamo costruito la nostra casa comune, la nostra democrazia, il nostro Paese”. Difatti, non deve ritenersi una casualità se, sin dalle fasi preliminari dei lavori, si consolida l’idea comune secondo cui la Costituzione dovesse consacrare, oltre al presente, anche norme che andassero ad illuminare la strada del legislatore, nella ferma consapevolezza che la medesima costituisse meramente – richiamando Calamandrei – “il preludio, l’annuncio di una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare […]. La nostra rivoluzione ha fatto una sola tappa, che è quella della Repubblica; ma il resto è tutto da fare, è tutto nell’avvenire”[1]. Tra i Costituenti, dunque, emerge la certezza che la Carta – inno di speranza e di fede – “durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell’esperienza storica”; sul punto, Ruini aggiunge che essa “sarà gradualmente perfezionata, e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi ed i nostri figli rimedieremo alle lacune e ai difetti, che esistono, e sono inevitabili […]”[2].
In diversi punti del volume, l’Autore evidenzia come i Costituenti non temessero il “peso” dei giudizi futuri; al contrario, dai discorsi di Calamandrei si evince la volontà di riconoscere ai “caduti” della fase bellica il grande merito di aver restituito al Paese libertà e dignità, limitandosi invece la Costituente ad un compito più agevole, quello di “tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore”[3]. Al contempo, non mancano parole di notevole apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Costituente; nel messaggio inviato all’Assemblea, il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, le riconosce di avere realizzato “un lavoro di cui gli storici daranno certamente un giudizio sereno […], per la profondità delle indagini compiute, per l’altezza dei dibattiti svoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nella ricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazione rigorosamente tecnica dei principi fondamentali e delle specifiche norme costituzionali […]”[4]. Sulla stessa scia, Vittorio Emanuele Orlando, nel suo ultimo discorso alla Costituente quale “rappresentante estremo delle tre generazioni”, asserisce che “l’Assemblea può essere fiera del lavoro compiuto”, pur in presenza di contrasti tra le personalità più varie; egli ricorda che la bellezza del lavoro parlamentare risiede nella discussione, “il mezzo più razionale e più elevato per raggiungere quella verità relativa, che agli uomini può essere consentita”[5].
Da qui il lettore trae un altro punto centrale. Ancora oggi si pretende di individuare la cultura politica egemone nel processo fondativo della Costituzione del 1948, di rilevare l’impronta più spiccata. In realtà, nel guardare indietro nel tempo – sono trascorsi ormai più di settantacinque anni – si prende atto di un’alchimia perfetta tra le differenti culture e la rinuncia ad una pretesa dominante. È innegabile che tale mosaico, pur testimoniando l’avvio della nuova vita democratica del Paese, andasse a generare talune difficoltà, come ammesso dagli attori coinvolti (“è molto facile fare Costituzioni omogenee, dove non che c’è un partito unico che legifera. È molto più complesso farle nel caso in cui ci troviamo noi, in cui ci sono molti partiti, che hanno cooperato al compito nuovo di ricostruzione della nuova casa italiana”)[6]. In tale senso, una parte della dottrina sottolinea “l’esistenza di intelligenze collettive, che si manifestano in comunanze di contesto, in vettori di forza ideologici che rompono i propri confini mostrandosi capaci della massima apertura senza tuttavia rinnegare o rimuovere la propria essenza”[7]. Quel che prevale è il senso di responsabilità; nello specifico, si avverte la necessità di testimoniare al Paese un valido esempio di concordia tra le diverse “anime” dell’Assemblea, che “alla volontà di potenza, scaturente dall’egoismo sfrenato dei singoli e dei gruppi ottusi al senso della libertà” – ammonisce Saragat – avrebbe dovuto opporre la propria libertà entro “i limiti invalicabili segnati dalla coscienza morale”[8]. In ultima analisi, appare doveroso tenere presente che la Costituzione sorge proprio nel periodo storico più “buio”, richiedente – con urgenza – una completa ricostruzione materiale e morale, a fronte del dilagare della disoccupazione e di un’economia “in crisi”; ciò spiega l’esigenza di “riattivare l’antica onestà politica e riportare gli istituti parlamentari più che mai aperti ed accessibili ad ogni lavoratore e ad ogni cittadino volenteroso e capace, allo splendore e alla trasparenza di un tempo”[9].
Nell’evidenziare più volte l’importanza di avere raggiunto un equilibrio, l’Autore sembra rivolgersi implicitamente alle forze politiche vigenti: a chi è chiamato all’attuazione della Costituzione, ed in particolare, ai suoi aspiranti revisori, affinchè quest’ultimi assumano consapevolezza sull’impossibilità di ammettere un uso circostanziale e strumentale della produzione della norma costituzionale, essendo gravati – al pari dei Costituenti – di una responsabilità morale alta.
In via conclusiva, l’opera di Ernesto Maria Ruffini intende valorizzare – attraverso lo spazio riservato ai dibattiti dell’Assemblea Costituente – i numerosi risultati legati alla dedizione, al coraggio e alla tenacia, nonché al sacrificio di donne e uomini traccianti la strada per tutti noi. Molto spesso si tende a concepire la Costituzione come un semplice “compromesso”. In realtà, si tratta di qualcosa di più: un progetto di emancipazione delle Madri e dei Padri fondato sui princìpi della libertà, della solidarietà, dell’eguale dignità, del lavoro, dell’autonomia come responsabilità per il bene comune. Nel volume in esame si sottolinea la necessità di restituire all’eguaglianza quanto le è dovuto, ossia la veste di principio guida della legislazione. Lo Stato legislativo è lo “Stato dell’uguaglianza”[10]: ciò in quanto la legislazione – evocando Flaubert – deve “tendere a mantenere l’uguaglianza che la forza delle cose tende a distruggere”[11]; affiora così il nesso che lega valorizzazione dell’eguaglianza, lotta alle diseguaglianze e struttura istituzionale.
Il progetto repubblicano si traduce nella completa negazione del totalitarismo; tale circostanza non dovrebbe essere trascurata, tanto più in un contesto storico in cui la classe politica tenta di fare del timore la sola ragion d’essere e di agire della Repubblica, anche tramite le riforme costituzionali. Se è vero che ogni rilettura dell’esperienza costituente è influenzata “dagli sviluppi del quadro politico e della cultura istituzionale, i quali hanno di volta in volta sollecitato i contemporanei ad interrogare il passato per cercare in esso la risposta ad esigenze dell’oggi nuove e diverse”[12], è anche vero che l’accordo raggiunto in quella prestigiosa sede ha forgiato Istituzioni che occorre rispettare e modificare solo attenendosi ad un procedimento condiviso e scrupolosamente discusso.
Infine, una lettura attenta e puntuale del volume permette a chi scrive di “sciogliere” qualsiasi dubbio circa l’interrogativo posto in origine: è chiaro che l’Autore abbia riposto fede nell’insegnamento di Calamandrei, facendo della Costituzione la propria “bussola”, volta a orientare le scelte e le azioni compiute nel corso della vita professionale; l’auspicio è che anche le future generazioni possano muoversi in tale direzione.
[1] On. Calamandrei, seduta del 4 marzo 1947.
[2] On. Ruini, seduta del 22 dicembre 1947.
[3] On. Calamandrei, seduta del 4 marzo 1947.
[4] Messaggio di Enrico De Nicola, resoconto della seduta pomeridiana del 22 dicembre 1947.
[5] Vittorio Emanuele Orlando, seduta del 22 dicembre 1947.
[6] On. Saragat, seduta del 6 marzo 1947.
[7] S. Staiano, Sulle culture politiche alla Costituente, in Rivista AIC, 3, 2024, 1.
[8] On. Saragat, seduta di mercoledì 26 giugno 1946.
[9] On. Rodinò, seduta del 20 marzo 1947.
[10] G. Berti, Immagini e suggestioni del principio di uguaglianza, in Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Napoli, 2004, 178.
[11] G. Flaubert Note su J.J. Rousseau, Milano, 2015, 134.
[12] P. Ridola, L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio, in Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano, 1999, 1402.



