Divieto di censura - Zensurverbot
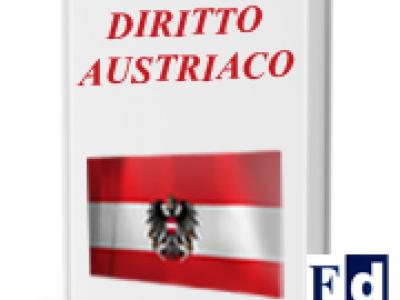
Sommario: I. Retrospettiva storica; II. Grundgesetz del 1949; III. Divieto di censura quale garanzia; IV. Vor- und Nachzensur; V. Legittimità della sola Nachzensur; VI. Normativa austriaca; VII. Triplice tutela; VIII. Interventi della Corte costituzionale; IX. Corte suprema e Vorzensur
I. Retrospettiva storica
Secondo la tesi più accreditata, la parola Zensur (censura) deriva dal latino “censere” e tra il 15.mo ed il 16.mo secolo, la parola Zensur la troviamo nella lingua tedesca per indicare il controllo del Geistesleben. Questo controllo veniva giustificato con l’esigenza di tutelare “schutzlose oder schutzbedürftige Gesellschaftsgruppen”. A tal fine si è fatto ricorso, non soltanto nel M.E., ma anche nella prima metà del 20.mo secolo, a Bücherverbrennungen e a divieti di leggere determinati libri. Altri “metodi” per ottenere la cosiddetta Gleichschaltung erano (e, in parte, lo sono tuttora) il divieto di pubblicazione, del possesso, della vendita, dell’importazione nonché il sequestro di libri e di giornali invisi al despota di turno. Si era arrivati persino al cosiddetto Kautionszwang (obbligo di depositare denaro presso la Zensurbehörde), a divieti di esercitare la professione di tipografo, ad imporre Beschränkungen der Erscheinungshäufigkeit, all’espulsione dal proprio Paese e, anche, alla comminazione di pene non soltanto pecuniarie, ma persino detentive.
Traendo la dovuta lezione dalla storia recente (e meno recente), nella Costituzione federale del 1949 (articolo 5, comma 1, del Grundgesetz (GG)), è stata inserita la seguente frase: ”Eine Zensur findet nicht statt” (non si procede a censura). Questa norma costituzionale fa parte del predetto articolo, intitolato: “Recht der freien Meinungsäußerung, Medienfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit” (diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, libertà dei media, dell’arte e della scienza). Già nella Costituzione del 1849 (§ 143, comma 1,) era stato sancito il diritto di tutti i cittadini di manifestare la propria opinione “durch Wort, Bild, Druck und bildlicher Darstellung”. Il comma 2 prevedeva che la libertà di stampa non poteva, in alcun modo e in nessun caso, essere limitata, sospesa o soppressa con il ricorso a misure preventive, quali la “Censur” (l’ortografia è quella della metà dell’Ottocento), concessioni, cauzioni, limitazioni imposte a tipografie. “Über Pressevergehen”, per le quali si procedeva d’ufficio, “wird durch Schwurgerichte geurtheilt” (l’ortografia, anche qui, è quella della metà dell’Ottocento).
L’articolo 118 della Costituzione di Weimar aveva disposto, al comma 2, che “eine Zensur findet nicht statt” e questa formulazione la troviamo, tale quale, nel 1° comma dell’art. 5 GG del 1949.
II. Grundgesetz del 1949
Quest’ultimo articolo, il cui comma 1, nella parte terminale, sancisce lo Zensurverbot, prevede 7 Grundrechte, i cosiddetti Kommunikationsgrundrechte, che sono: 1) Meinungsfreiheit, 2) Informationsfreiheit, 3) Pressefreiheit, 4) Freiheit der Rundfunkberichterstattung, 5) Freiheit der Filmberichterstattung, 6) Freiheit der Kunst e 7) Freiheit der Wissenschaft und der Lehre.
Soltanto un cittadino che effettivamente è libero nell’informarsi e nell’essere informato, è un “mündiger Bürger”, in grado di prendere le proprie decisioni e di partecipare liberamente alla vita pubblica. È caratteristico per le dittature, di ogni risma ed epoca, limitare o sopprimere la libertà di informazione (e di opinione), sostituendo la stessa con una “gesteuerten Information” e, spesso, ricorrendo ad un censura più o meno accentuata.
È stato detto, a proposito del divieto di censura, che esso costituirebbe una “Proklamation der Freiheit des Geistes” che doveva trovare posto accanto alle garanzie (Gewährleistungen) sancite dal comma 1 dell’articolo 5 GG. In altre parole, lo Zensurverbot “ist ein besonderer Fall des Schutzes gegen Grundrechtsgefährdungen“.
III. Divieto di censura quale garanzia
Secondo la Corte costituzionale federale ( BVerfGE: 83, 130 (155) e 87, 209 (230), lo Zensurverbot è di fondamentale importanza, potendo la Grundrechtssicherung dei diritti di cui al comma 1 dell’articolo 5 GG, essere pienamente attuata soltanto in presenza del Verbot der formellen Vor- und Präventivzensur da parte delle autorità.
Lo Zensurverbot fa sì che contrastano con l’articolo 5, comma 1, GG, Verbote mit Erlaubnisvorbehalt o l’obbligo della Vorlegung alle autorità prima della pubblicazione. Si e’ ritenuto che la sola esistenza di Kontroll- und/oder Genehmigungsverfahren “lähmen das Geistesleben”.
IV. Vor- und Nachzensur
A proposito della Zensur si distingue tra Vorzensur e Nachzensur. Si ha la prima, se le autorità impediscono oppure ostacolano una pubblicazione mediale ovvero subordinano la medesima ad approvazione o a misure preventive analoghe. Di Nachzensur si parla se la stessa avviene, a pubblicazione avvenuta, con misure repressive; la Nachzensur non è compresa nella previsione dell’articolo 5, comma 1, Costituzione federale.
Il divieto di Vorzensur, nella RFT, è stato definito “eine historisch bedingte, ausdrückliche Vorkehrung zum Schutz der sieben Grundrechte“ sopra menzionati, è una strikte Eingriffsschranke che vieta ogni behördliche Vorprüfung und Genehmigung”.
Nachträgliche Sanktionen sono basate su limiti dettati da leggi ordinarie in materia di libertà di manifestazione della propria opinione e di liberta’ dei media (p. es. tutela del diritto all’onore, cosiddetto Ehrenschutz).
I diritti fondamentali vengono classificati dalla dottrina prevalente quali “Abwehrrechte Privater gegenüber dem Staat oder dem Staat zuzurechnender Stellen“, “subjektive Abwehrrechte gegen Maßnahmen des Staates”. I diritti sanciti dall’articolo 5, comma 1, Grundgesetz, possono essere invocati anche da persone giuridiche (riconosciute e non), ma non da juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Il divieto di censura non comprende inoltre i cosiddetti privatrechtlichen Unterlassungsansprüche previsti dalla ZPO (CPC).
Per quanto concerne le Verbreitungsbeschränkungen (limiti alla diffusione); esse, in linea di principio, non sono ammissibili, fatta eccezione però per lo Jugendschutz; anche a tale proposito occorre però che l’intervento delle autorità pubbliche sia caratterizzato da Erforderlichkeit und Geeignetheit, oltre che da Verhältnismäßigkeit. Soltanto sussistendo tutti questi presupposti, l’Eingriff in den Schuztzbereich des Articolo 5, Abs. 1, GG, può ritenersi giustificato e quindi legittimo.
V. Legittimità della sola Nachzensur
Lo Zensurverbot è però inserito – come è ovvio - nella allgemeinen Rechtsordnung. I Costituenti, adottando la formulazione: ”Eine Zensur findet nicht statt”, ritenevano, sia pure implicitamente, la legittimità dalla sola Nachzensur. Secondo la dottrina largamente prevalente, quest’interpretazione trova il proprio fondamento nel disposto del comma 2 dell’articolo 5 GG, secondo il quale, i diritti di cui al comma 1 trovano le proprie limitazioni in: a) norme di legge (leggi ordinarie) in genere nonché b) in quelle poste a tutela dei minori e c) nel diritto all’onore. Si parla in proposito del cosiddetto Schrankentrias che ha dato luogo a non pochi problemi e c’è stato chi ha parlato anche di Schrankenwirrwarr. Altri hanno ritenuto che il disposto del comma 2 dell’articolo 5 GG, legittimerebbe Grenzenlosigkeitsschlüsse.
Una dizione simile a quella di cui all’articolo 5, comma 2, GG, la troviamo già nella Costituzione di Weimar del 1919, il cui articolo 118 limitava la Meinugsäußerungsfreiheit postulando che la stessa venisse esercitata “innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze”. Questa formulazione, già allora, aveva dato luogo a difficoltà e contrasti interpretativi, tant’è vero che lo Smend aveva parlato di “größter, von den vielen Schwierigkeiten, die der gesamte Artikel der Auslegung bot”.
Recentemente lo Schrankentrias previsto dall’articolo 5, comma 2, GG, è stato definito un “jahrzehntealtes Kreuz des Staatsrechtes”.
Che la Nachzensur debba essere legittima, risulta anche dal fatto che altrimenti libertà di manifestazione del pensiero e di stampa non sarebbero soggette ad alcun limite ragionevole e che queste libertà si risolverebbero nell’esatto contrario di quanto i Costituenti avrebbero voluto garantire. Pertanto Repressionsmaßnahmen non contrastano con il Grundgesetz, qualora esse “erst nachder Veröffentlichung eines Geisteswerkes einsetzen” (BVerfGE: 33, 52 (72)).
Il divieto di Vorzensur, da parte di organi statali, è un zwingendes Verbot che non è abwägungsfähig ne’ con riferimento al cosiddetto Gemeinwohl, ne’ con riferimento alla Staatsraison; in altre parole, è abwägungsresistent.
Nella RFT vige il principio della “Staatsfreiheit der Medien” ed è garantito il diritto fondamentale della Pressefreiheit. Queste garanzie fanno sì che non possano trovare applicazione Ausgewogenheitspostulate. Il divieto di Vorzensur va inteso come grundrechtsschützende Vorkehrung.
Il Verbot der Vorzensur è stato definito “Eine Schranke der Beschränkungsmöglichkeiten des Articolo 5, Abs. 2, GG“.
Nella RFT, per i giornali e i periodici, non vi è obbligo di (previa) registrazione (come previsto dall’art. 5 L. n. 47/1948) che, peraltro, è un accertamento di carattere vincolato, non discrezionale e affidato, non alla PA, ma all’autorità giudiziaria.
VI. Normativa austriaca
Per quanto concerne la normativa austriaca in materia di censura, va rilevato che l’articolo 13 dello Staatsgrundgesetz (StGG) del 21.12.1867, dopo aver sancito la libertà di stampa “innerhalb der gesetzlichen Schranken,” aveva disposto testualmente: ”Die Presse darf weder unter Zensur gestellt werden, noch durch das Konzessionssystem beschränkt werden” (La stampa non puo’ essere sottoposta a censura, ne’ subire limitazioni per effetto di un sistema di concessioni). Divieti di trasporto - disposti dalla PA - di prodotti di stampa, potevano trovare applicazione soltanto per prodotti di stampa esteri.
Quest’articolo, come del resto 16 dei 20 articoli da cui, originariamente, era composta la legge “Über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger” del 1867, sono tuttora in vigore e ad essi è riconosciuto Verfassungsrang.
Va osservato, con riferimento alla libertà di stampa - considerata una “spezifische Ausprägung der Meinungsfreiheit”- prevista dall’articolo 13 StGG, che questo articolo aveva statuito che si tratta di un diritto spettante a tutti, cittadini e non (“Jedermann hat das Recht…).
VII. Triplice tutela
Come risulta da una sentenza della Corte costituzionale del 1983 (B534/79), il citato articolo garantisce una “triplice” tutela, inibendo 1) che la stampa possa subire limitazioni subordinando l’esercizio della Meinungsäußerungsfreiheit ad un sistema di concessioni (governative), 2) escludendo la censura preventiva, la Vorzensur e 3) vietando che prodotti di stampa, la cui spedizione non era diretta all’estero, potessero essere esclusi dal trasporto da parte dell’amministrazione postale.
La tutela di cui sopra sub 1) implica che case editrici di quotidiani e di periodici possono iniziare (e continuare), la loro attività di stampa e di diffusione dei loro prodotti, senza dover chiedere autorizzazione alcuna alla PA. Per quanto riguarda la Vorzensur, si ha la stessa, se determinate parti (o tutte) di uno stampato costituenti manifestazione del pensiero, sono soggette a controllo o limitazioni prima dell’avvenuta diffusione degli stessi.
Il divieto di Vorzensur rende illegittima ogni preventiva autorizzazione, come pure ogni controllo anticipato o Vorlagepflicht in ordine a prodotti di stampa destinati alla diffusione, divieto che si estende anche ad Erscheinungsverbote (divieti di pubblicazione e diffusione). La Corte costituzionale, con una decisione del 1978, ha statuito che ogni Vorzensur, anche se diretta alla tutela dei minori, contrasta con la vigente normativa costituzionale.
Lo Zensurverbot, nel senso della Vorzensur (la quale soltanto è inammissibile secondo la Costituzione federale), trova applicazione anche per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche.
Legittime, in linea di principio, sono le sole misure repressive, da considerarsi una forma di Nachzensur (p. es. la comminazione di una pena pecuniaria), a patto che le stesse si appalesino necessarie ai sensi dell’articolo 10, comma 2, CEDU. Questa norma, d’altra parte, ha anche precisato che la funzione di controllo dei media (“public watchdog”) se ed in quanto riportano notizie di pubblico interesse, contribuendo, in tal modo, alla formazione di un’opinione pubblica pluralistica, non ha pero’ mancato di menzionare pure i doveri e le responsabilità della stampa.
Norme molto restrittive sono previste dal Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien del 1981 in materia di sequestro e confisca. Significativo è che nel preambolo al Mediengesetz (MedienG), leggiamo che questa legge ha lo scopo di garantire la “volle Freiheit der Medien” e che limitazioni della libertà dei media sono ammissibili soltanto nei casi e alle condizioni previsti dall’articolo 10, comma 2, CEDU.
VIII. Interventi della Corte costituzionale
Nel 1990 la Corte costituzionale ha emanato un’importante sentenza in materia di Zensurverbot (GZ. G1/90; G70/90), dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma (§ 9, comma 3 dell’Arbeitsmarktförderungsgesetz del 1969) che prevedeva la Bewilligungspflicht für die Veröffentlichung ausländischer Stellenangebote (l`obbligo di autorizzazione della pubblicazione di posti di lavoro all’estero), norma ritenuta in contrasto con la Presse- und Meinugsäußerungsfreiheit e, specificamente, con lo Zensurverbot. Riteneva il Verfassungsgerichtshof che la suddetta disposizione di legge contenesse “eine präventive, behördliche Maßnahme, die bewirkt, dass der Inhalt einer Druckschrift einer vorgängigen, behördlichen Prüfung unterworfen wird”. Già nel 1952 la Corte costituzionale si era pronunziata nel senso dell’Unzulässigkeit di un’autorizzazione che dovesse precedere la stampa e la diffusione einer Druckschrift. Nella decisione del 1952, la Corte costituzionale aveva stabilito che Zensurverbot, quale previsto dallo StGG, significava che il contenuto di uno stampato destinato ad essere pubblicato, non poteva essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dell’autorità pubblica, posto che il Verfassungsgeber aveva statuito il divieto di censura preventiva “ohne Gesetzesvorbehalt”. Peraltro al legislatore ordinario era (ed è) inibito limitare, attraverso la censura preventiva, la Meinungsäußerungsfreiheit. Questo divieto vige indipendentemente dalla materia, per la quale il legislatore ordinario poteva ritenere necessario (o opportuno) limitare la Meinungsäußerungsfreiheit.
Ha osservato, inoltre, il Verfassungsgerichtshof, che la cosiddetta Zensurfreiheit “muss stets im Zusammenhang mit der Meinungsäußerungsfreiheit gesehen werden” e che il concetto di censura - secondo la vigente normativa costituzionale - è comprensivo di tutte le misure di carattere preventivo disposte dalla pubblica autorità intesa (“die darauf abzielt”) a limitare o ad “annullare” la libertà di manifestare il proprio pensiero o di diffonderlo.
La censura è costituzionalmente illegittima non soltanto se il controllo preventivo ha per oggetto opinioni di natura politica, ma anche se riguarda il contenuto qualsiasi di uno stampato (come, nel caso sottoposto all’esame della Corte costituzionale, in cui si trattava di pubblicità commerciale); in altre parole, anche la kommerzielle Werbung rientra nello Schutzbereich della Meinungäußerungsfreiheit.
Nella propria decisione del 1990, il Verfassungsgerichtshof, richiamando anche una propria sentenza del 1986, aveva concluso nel senso che la “vorgängige, behördliche Genehmigungspflicht” contrastava con il suddetto diritto di liberta’, risolvendosi la stessa in una “verfassugsrechtlich verpönten Zensurmaßnahme”.
IX. Corte suprema e Vorzensur
Anche la Corte suprema (OGH), nel 2012, aveva emanato una sentenza di particolare importanza in materia di verbotener Vorzensur.
Aveva sostenuto, il patrocinatore dell’imputato, che in applicazione dell’articolo unico, comma 1, del Beschluss der provisorischen Nationalversammlung dd. 30.10. 1918 - il quale, pacificamente, ha Verfassungsrang (è una norma di rango costituzionale), come pure l’ha lo Staatsgrundgesetz del 21.12.1867, essendo entrambe queste norme state richiamate espressamente nel vigente articolo 149 del B-VG (Bundesverfassungsgesetz) - deve ritenersi venuta meno “jegliche Einschränkung der Pressefreiheit”. La Corte suprema, confermando il proprio orientamento già espresso in alcune proprie sentenze precedenti, aveva osservato che era ben vero che il suddetto Beschluss e l’articolo 13, comma 1, dello Staatsgrundgesetz avevano sancito, in modo assoluto, il divieto di Vorzensur, ma non di misure di natura repressiva che possono essere previste da leggi ordinarie. Inoltre si deve tenere debitamente conto anche della normativa contenuta nella CDEU, in particolare dell’articolo 10 di tale Convenzione. Si sarebbe potuto parlare fondatamente di Vorzensur, se fosse stato disposto che ulteriori edizioni avessero dovuto “einer staatlichen Stelle zur Prüfung vorgelegt werden”; un tale obbligo non era pero’ previsto dalla norma che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata costituzionalmente illegittima, tesi non condivisa dal Verfassungsgerichtshof.
Sommario: I. Retrospettiva storica; II. Grundgesetz del 1949; III. Divieto di censura quale garanzia; IV. Vor- und Nachzensur; V. Legittimità della sola Nachzensur; VI. Normativa austriaca; VII. Triplice tutela; VIII. Interventi della Corte costituzionale; IX. Corte suprema e Vorzensur
I. Retrospettiva storica
Secondo la tesi più accreditata, la parola Zensur (censura) deriva dal latino “censere” e tra il 15.mo ed il 16.mo secolo, la parola Zensur la troviamo nella lingua tedesca per indicare il controllo del Geistesleben. Questo controllo veniva giustificato con l’esigenza di tutelare “schutzlose oder schutzbedürftige Gesellschaftsgruppen”. A tal fine si è fatto ricorso, non soltanto nel M.E., ma anche nella prima metà del 20.mo secolo, a Bücherverbrennungen e a divieti di leggere determinati libri. Altri “metodi” per ottenere la cosiddetta Gleichschaltung erano (e, in parte, lo sono tuttora) il divieto di pubblicazione, del possesso, della vendita, dell’importazione nonché il sequestro di libri e di giornali invisi al despota di turno. Si era arrivati persino al cosiddetto Kautionszwang (obbligo di depositare denaro presso la Zensurbehörde), a divieti di esercitare la professione di tipografo, ad imporre Beschränkungen der Erscheinungshäufigkeit, all’espulsione dal proprio Paese e, anche, alla comminazione di pene non soltanto pecuniarie, ma persino detentive.
Traendo la dovuta lezione dalla storia recente (e meno recente), nella Costituzione federale del 1949 (articolo 5, comma 1, del Grundgesetz (GG)), è stata inserita la seguente frase: ”Eine Zensur findet nicht statt” (non si procede a censura). Questa norma costituzionale fa parte del predetto articolo, intitolato: “Recht der freien Meinungsäußerung, Medienfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit” (diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, libertà dei media, dell’arte e della scienza). Già nella Costituzione del 1849 (§ 143, comma 1,) era stato sancito il diritto di tutti i cittadini di manifestare la propria opinione “durch Wort, Bild, Druck und bildlicher Darstellung”. Il comma 2 prevedeva che la libertà di stampa non poteva, in alcun modo e in nessun caso, essere limitata, sospesa o soppressa con il ricorso a misure preventive, quali la “Censur” (l’ortografia è quella della metà dell’Ottocento), concessioni, cauzioni, limitazioni imposte a tipografie. “Über Pressevergehen”, per le quali si procedeva d’ufficio, “wird durch Schwurgerichte geurtheilt” (l’ortografia, anche qui, è quella della metà dell’Ottocento).
L’articolo 118 della Costituzione di Weimar aveva disposto, al comma 2, che “eine Zensur findet nicht statt” e questa formulazione la troviamo, tale quale, nel 1° comma dell’art. 5 GG del 1949.
II. Grundgesetz del 1949
Quest’ultimo articolo, il cui comma 1, nella parte terminale, sancisce lo Zensurverbot, prevede 7 Grundrechte, i cosiddetti Kommunikationsgrundrechte, che sono: 1) Meinungsfreiheit, 2) Informationsfreiheit, 3) Pressefreiheit, 4) Freiheit der Rundfunkberichterstattung, 5) Freiheit der Filmberichterstattung, 6) Freiheit der Kunst e 7) Freiheit der Wissenschaft und der Lehre.
Soltanto un cittadino che effettivamente è libero nell’informarsi e nell’essere informato, è un “mündiger Bürger”, in grado di prendere le proprie decisioni e di partecipare liberamente alla vita pubblica. È caratteristico per le dittature, di ogni risma ed epoca, limitare o sopprimere la libertà di informazione (e di opinione), sostituendo la stessa con una “gesteuerten Information” e, spesso, ricorrendo ad un censura più o meno accentuata.
È stato detto, a proposito del divieto di censura, che esso costituirebbe una “Proklamation der Freiheit des Geistes” che doveva trovare posto accanto alle garanzie (Gewährleistungen) sancite dal comma 1 dell’articolo 5 GG. In altre parole, lo Zensurverbot “ist ein besonderer Fall des Schutzes gegen Grundrechtsgefährdungen“.
III. Divieto di censura quale garanzia
Secondo la Corte costituzionale federale ( BVerfGE: 83, 130 (155) e 87, 209 (230), lo Zensurverbot è di fondamentale importanza, potendo la Grundrechtssicherung dei diritti di cui al comma 1 dell’articolo 5 GG, essere pienamente attuata soltanto in presenza del Verbot der formellen Vor- und Präventivzensur da parte delle autorità.
Lo Zensurverbot fa sì che contrastano con l’articolo 5, comma 1, GG, Verbote mit Erlaubnisvorbehalt o l’obbligo della Vorlegung alle autorità prima della pubblicazione. Si e’ ritenuto che la sola esistenza di Kontroll- und/oder Genehmigungsverfahren “lähmen das Geistesleben”.
IV. Vor- und Nachzensur
A proposito della Zensur si distingue tra Vorzensur e Nachzensur. Si ha la prima, se le autorità impediscono oppure ostacolano una pubblicazione mediale ovvero subordinano la medesima ad approvazione o a misure preventive analoghe. Di Nachzensur si parla se la stessa avviene, a pubblicazione avvenuta, con misure repressive; la Nachzensur non è compresa nella previsione dell’articolo 5, comma 1, Costituzione federale.
Il divieto di Vorzensur, nella RFT, è stato definito “eine historisch bedingte, ausdrückliche Vorkehrung zum Schutz der sieben Grundrechte“ sopra menzionati, è una strikte Eingriffsschranke che vieta ogni behördliche Vorprüfung und Genehmigung”.
Nachträgliche Sanktionen sono basate su limiti dettati da leggi ordinarie in materia di libertà di manifestazione della propria opinione e di liberta’ dei media (p. es. tutela del diritto all’onore, cosiddetto Ehrenschutz).
I diritti fondamentali vengono classificati dalla dottrina prevalente quali “Abwehrrechte Privater gegenüber dem Staat oder dem Staat zuzurechnender Stellen“, “subjektive Abwehrrechte gegen Maßnahmen des Staates”. I diritti sanciti dall’articolo 5, comma 1, Grundgesetz, possono essere invocati anche da persone giuridiche (riconosciute e non), ma non da juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Il divieto di censura non comprende inoltre i cosiddetti privatrechtlichen Unterlassungsansprüche previsti dalla ZPO (CPC).
Per quanto concerne le Verbreitungsbeschränkungen (limiti alla diffusione); esse, in linea di principio, non sono ammissibili, fatta eccezione però per lo Jugendschutz; anche a tale proposito occorre però che l’intervento delle autorità pubbliche sia caratterizzato da Erforderlichkeit und Geeignetheit, oltre che da Verhältnismäßigkeit. Soltanto sussistendo tutti questi presupposti, l’Eingriff in den Schuztzbereich des Articolo 5, Abs. 1, GG, può ritenersi giustificato e quindi legittimo.
V. Legittimità della sola Nachzensur
Lo Zensurverbot è però inserito – come è ovvio - nella allgemeinen Rechtsordnung. I Costituenti, adottando la formulazione: ”Eine Zensur findet nicht statt”, ritenevano, sia pure implicitamente, la legittimità dalla sola Nachzensur. Secondo la dottrina largamente prevalente, quest’interpretazione trova il proprio fondamento nel disposto del comma 2 dell’articolo 5 GG, secondo il quale, i diritti di cui al comma 1 trovano le proprie limitazioni in: a) norme di legge (leggi ordinarie) in genere nonché b) in quelle poste a tutela dei minori e c) nel diritto all’onore. Si parla in proposito del cosiddetto Schrankentrias che ha dato luogo a non pochi problemi e c’è stato chi ha parlato anche di Schrankenwirrwarr. Altri hanno ritenuto che il disposto del comma 2 dell’articolo 5 GG, legittimerebbe Grenzenlosigkeitsschlüsse.
Una dizione simile a quella di cui all’articolo 5, comma 2, GG, la troviamo già nella Costituzione di Weimar del 1919, il cui articolo 118 limitava la Meinugsäußerungsfreiheit postulando che la stessa venisse esercitata “innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze”. Questa formulazione, già allora, aveva dato luogo a difficoltà e contrasti interpretativi, tant’è vero che lo Smend aveva parlato di “größter, von den vielen Schwierigkeiten, die der gesamte Artikel der Auslegung bot”.
Recentemente lo Schrankentrias previsto dall’articolo 5, comma 2, GG, è stato definito un “jahrzehntealtes Kreuz des Staatsrechtes”.
Che la Nachzensur debba essere legittima, risulta anche dal fatto che altrimenti libertà di manifestazione del pensiero e di stampa non sarebbero soggette ad alcun limite ragionevole e che queste libertà si risolverebbero nell’esatto contrario di quanto i Costituenti avrebbero voluto garantire. Pertanto Repressionsmaßnahmen non contrastano con il Grundgesetz, qualora esse “erst nachder Veröffentlichung eines Geisteswerkes einsetzen” (BVerfGE: 33, 52 (72)).
Il divieto di Vorzensur, da parte di organi statali, è un zwingendes Verbot che non è abwägungsfähig ne’ con riferimento al cosiddetto Gemeinwohl, ne’ con riferimento alla Staatsraison; in altre parole, è abwägungsresistent.
Nella RFT vige il principio della “Staatsfreiheit der Medien” ed è garantito il diritto fondamentale della Pressefreiheit. Queste garanzie fanno sì che non possano trovare applicazione Ausgewogenheitspostulate. Il divieto di Vorzensur va inteso come grundrechtsschützende Vorkehrung.
Il Verbot der Vorzensur è stato definito “Eine Schranke der Beschränkungsmöglichkeiten des Articolo 5, Abs. 2, GG“.
Nella RFT, per i giornali e i periodici, non vi è obbligo di (previa) registrazione (come previsto dall’art. 5 L. n. 47/1948) che, peraltro, è un accertamento di carattere vincolato, non discrezionale e affidato, non alla PA, ma all’autorità giudiziaria.
VI. Normativa austriaca
Per quanto concerne la normativa austriaca in materia di censura, va rilevato che l’articolo 13 dello Staatsgrundgesetz (StGG) del 21.12.1867, dopo aver sancito la libertà di stampa “innerhalb der gesetzlichen Schranken,” aveva disposto testualmente: ”Die Presse darf weder unter Zensur gestellt werden, noch durch das Konzessionssystem beschränkt werden” (La stampa non puo’ essere sottoposta a censura, ne’ subire limitazioni per effetto di un sistema di concessioni). Divieti di trasporto - disposti dalla PA - di prodotti di stampa, potevano trovare applicazione soltanto per prodotti di stampa esteri.
Quest’articolo, come del resto 16 dei 20 articoli da cui, originariamente, era composta la legge “Über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger” del 1867, sono tuttora in vigore e ad essi è riconosciuto Verfassungsrang.
Va osservato, con riferimento alla libertà di stampa - considerata una “spezifische Ausprägung der Meinungsfreiheit”- prevista dall’articolo 13 StGG, che questo articolo aveva statuito che si tratta di un diritto spettante a tutti, cittadini e non (“Jedermann hat das Recht…).
VII. Triplice tutela
Come risulta da una sentenza della Corte costituzionale del 1983 (B534/79), il citato articolo garantisce una “triplice” tutela, inibendo 1) che la stampa possa subire limitazioni subordinando l’esercizio della Meinungsäußerungsfreiheit ad un sistema di concessioni (governative), 2) escludendo la censura preventiva, la Vorzensur e 3) vietando che prodotti di stampa, la cui spedizione non era diretta all’estero, potessero essere esclusi dal trasporto da parte dell’amministrazione postale.
La tutela di cui sopra sub 1) implica che case editrici di quotidiani e di periodici possono iniziare (e continuare), la loro attività di stampa e di diffusione dei loro prodotti, senza dover chiedere autorizzazione alcuna alla PA. Per quanto riguarda la Vorzensur, si ha la stessa, se determinate parti (o tutte) di uno stampato costituenti manifestazione del pensiero, sono soggette a controllo o limitazioni prima dell’avvenuta diffusione degli stessi.
Il divieto di Vorzensur rende illegittima ogni preventiva autorizzazione, come pure ogni controllo anticipato o Vorlagepflicht in ordine a prodotti di stampa destinati alla diffusione, divieto che si estende anche ad Erscheinungsverbote (divieti di pubblicazione e diffusione). La Corte costituzionale, con una decisione del 1978, ha statuito che ogni Vorzensur, anche se diretta alla tutela dei minori, contrasta con la vigente normativa costituzionale.
Lo Zensurverbot, nel senso della Vorzensur (la quale soltanto è inammissibile secondo la Costituzione federale), trova applicazione anche per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche.
Legittime, in linea di principio, sono le sole misure repressive, da considerarsi una forma di Nachzensur (p. es. la comminazione di una pena pecuniaria), a patto che le stesse si appalesino necessarie ai sensi dell’articolo 10, comma 2, CEDU. Questa norma, d’altra parte, ha anche precisato che la funzione di controllo dei media (“public watchdog”) se ed in quanto riportano notizie di pubblico interesse, contribuendo, in tal modo, alla formazione di un’opinione pubblica pluralistica, non ha pero’ mancato di menzionare pure i doveri e le responsabilità della stampa.
Norme molto restrittive sono previste dal Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien del 1981 in materia di sequestro e confisca. Significativo è che nel preambolo al Mediengesetz (MedienG), leggiamo che questa legge ha lo scopo di garantire la “volle Freiheit der Medien” e che limitazioni della libertà dei media sono ammissibili soltanto nei casi e alle condizioni previsti dall’articolo 10, comma 2, CEDU.
VIII. Interventi della Corte costituzionale
Nel 1990 la Corte costituzionale ha emanato un’importante sentenza in materia di Zensurverbot (GZ. G1/90; G70/90), dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma (§ 9, comma 3 dell’Arbeitsmarktförderungsgesetz del 1969) che prevedeva la Bewilligungspflicht für die Veröffentlichung ausländischer Stellenangebote (l`obbligo di autorizzazione della pubblicazione di posti di lavoro all’estero), norma ritenuta in contrasto con la Presse- und Meinugsäußerungsfreiheit e, specificamente, con lo Zensurverbot. Riteneva il Verfassungsgerichtshof che la suddetta disposizione di legge contenesse “eine präventive, behördliche Maßnahme, die bewirkt, dass der Inhalt einer Druckschrift einer vorgängigen, behördlichen Prüfung unterworfen wird”. Già nel 1952 la Corte costituzionale si era pronunziata nel senso dell’Unzulässigkeit di un’autorizzazione che dovesse precedere la stampa e la diffusione einer Druckschrift. Nella decisione del 1952, la Corte costituzionale aveva stabilito che Zensurverbot, quale previsto dallo StGG, significava che il contenuto di uno stampato destinato ad essere pubblicato, non poteva essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dell’autorità pubblica, posto che il Verfassungsgeber aveva statuito il divieto di censura preventiva “ohne Gesetzesvorbehalt”. Peraltro al legislatore ordinario era (ed è) inibito limitare, attraverso la censura preventiva, la Meinungsäußerungsfreiheit. Questo divieto vige indipendentemente dalla materia, per la quale il legislatore ordinario poteva ritenere necessario (o opportuno) limitare la Meinungsäußerungsfreiheit.
Ha osservato, inoltre, il Verfassungsgerichtshof, che la cosiddetta Zensurfreiheit “muss stets im Zusammenhang mit der Meinungsäußerungsfreiheit gesehen werden” e che il concetto di censura - secondo la vigente normativa costituzionale - è comprensivo di tutte le misure di carattere preventivo disposte dalla pubblica autorità intesa (“die darauf abzielt”) a limitare o ad “annullare” la libertà di manifestare il proprio pensiero o di diffonderlo.
La censura è costituzionalmente illegittima non soltanto se il controllo preventivo ha per oggetto opinioni di natura politica, ma anche se riguarda il contenuto qualsiasi di uno stampato (come, nel caso sottoposto all’esame della Corte costituzionale, in cui si trattava di pubblicità commerciale); in altre parole, anche la kommerzielle Werbung rientra nello Schutzbereich della Meinungäußerungsfreiheit.
Nella propria decisione del 1990, il Verfassungsgerichtshof, richiamando anche una propria sentenza del 1986, aveva concluso nel senso che la “vorgängige, behördliche Genehmigungspflicht” contrastava con il suddetto diritto di liberta’, risolvendosi la stessa in una “verfassugsrechtlich verpönten Zensurmaßnahme”.
IX. Corte suprema e Vorzensur
Anche la Corte suprema (OGH), nel 2012, aveva emanato una sentenza di particolare importanza in materia di verbotener Vorzensur.
Aveva sostenuto, il patrocinatore dell’imputato, che in applicazione dell’articolo unico, comma 1, del Beschluss der provisorischen Nationalversammlung dd. 30.10. 1918 - il quale, pacificamente, ha Verfassungsrang (è una norma di rango costituzionale), come pure l’ha lo Staatsgrundgesetz del 21.12.1867, essendo entrambe queste norme state richiamate espressamente nel vigente articolo 149 del B-VG (Bundesverfassungsgesetz) - deve ritenersi venuta meno “jegliche Einschränkung der Pressefreiheit”. La Corte suprema, confermando il proprio orientamento già espresso in alcune proprie sentenze precedenti, aveva osservato che era ben vero che il suddetto Beschluss e l’articolo 13, comma 1, dello Staatsgrundgesetz avevano sancito, in modo assoluto, il divieto di Vorzensur, ma non di misure di natura repressiva che possono essere previste da leggi ordinarie. Inoltre si deve tenere debitamente conto anche della normativa contenuta nella CDEU, in particolare dell’articolo 10 di tale Convenzione. Si sarebbe potuto parlare fondatamente di Vorzensur, se fosse stato disposto che ulteriori edizioni avessero dovuto “einer staatlichen Stelle zur Prüfung vorgelegt werden”; un tale obbligo non era pero’ previsto dalla norma che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata costituzionalmente illegittima, tesi non condivisa dal Verfassungsgerichtshof.



