La nostra storia industriale e la formazione
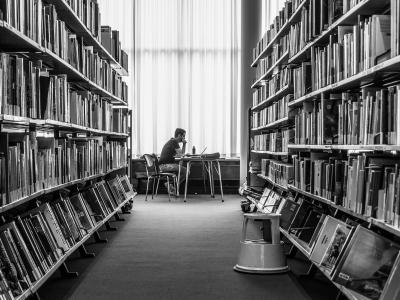
Siamo lontani da quando con il Contratto Collettivo Nazionale si istituirono le 150 ore nell’Italia dei lavoratori-studenti. Si può considerare persino ribaltata la situazione, nel tempo, a tal punto che sono cambiate le proporzioni tra le cose, ed è servito (nel 2015) introdurre 150 ore di «alternanza scuola lavoro» per gli studenti degli istituti tecnici (in numero inferiore anche 90 ore per i Licei). Cosa resta dei tantissimi, troppi, indirizzi di studio, nei serali? Non vorrei fossero mai più considerati come un calderone, dove va chi non ce l’ha fatta in quella scuola tradizionale che chiamiamo solo scuola. C’è la scuola e c’è il serale, dove quest’ultimo fa saltare, in un colpo solo, i principali riti stanchi caratterizzati dal suono della campanella poco dopo le 8. Si tratta a tutti gli effetti di formazione degli adulti, infatti spesse volte gli studenti hanno la maggiore età. Probabilmente più scuole serali potrebbero attirare studenti quando maturano una nuova consapevolezza. Molti studenti non riescono ad andare a scuola durante il giorno per vari motivi, come carichi e impegni familiari. È necessario un miglior confronto con questo mondo che porta maggior interesse verso l’educazione e la cultura in Italia. Il serale rappresenta una grande opportunità per la formazione degli adulti, e dovrebbe essere previsto su tutti gli indirizzi scolastici, secondo uno degli studenti dell’ISS Santa Caterina Siena-Amendola. Ad esempio, le lezioni online possono essere una soluzione per quegli studenti che non possono frequentare, ma il mondo fisico non deve sembrare rinunciatario, dietro ragioni economiche, e, per inerzia, rispetto alle domande che anche il sindacato fa. Non è vero che è arroccato su posizioni arretrate di difesa, anzi è cosciente che non si debba delegare tutto, a una vita online: rapporti, conoscenza, accesso.
Conosciamoli meglio gli studenti e resteremo sorpresi. La visione del legislatore e se vogliamo della classe dirigente che cozza coi tempi di fast food delle scelte pubbliche, i gusti personali, le scommesse dell'elettorato, i tempi del raccolto, i sondaggi e i follower, la permanenza nella stessa azienda, la durata «sul mercato», la tenuta allegra dei conti pubblici e della spesa corrente.
In questo sicuramente abbiamo bisogno di un buon giornalismo: «Solution journalism is accountability journalism».
La dimensione del tempo libero e il tempo di lavoro si assottiglia, si intreccia, si inverte. La settimana di quattro giorni e lo smart working, il salario minimo, il congedo parentale allungato ed equiparato a standard che garantiscono maggior parità di genere, la dimensione etica del lavoro, il paradosso della disoccupazione e del mismatch. Le realtà come la regione veneta da cui negli anni '50 partirono - e che oggi avrebbe ancora più bisogno arrivassero - per altre regioni, col ritmo di quella stessa emigrazione interna che ha conosciuto in uscita. Ma non ci sono i villaggi degli operai, non siamo nella Torino o nella Milano ai tempi delle fabbriche. Servirebbe organizzare un'offerta di servizi capace di competere con le Smart city che fanno da richiamo di competenze. Le barriere architettoniche e culturali, la solidarietà, le chance, le comunità, sono nuove sfide intergenerazionali. Oltre ovviamente ai fattori ESG. Il si è sempre fatto così non basta. Un'azienda emblematica, pur essendo stata un modello industriale per alcuni aspetti virtuoso, tagliata fuori dall'innovazione tecnologica, la Mivar trovo sia il miglior studio di caso. Fondata da Carlo Vichi crebbe gradualmente fino a raggiungere 400 dipendenti, producendo 500.000 apparecchi all'anno. Il trasferimento al Lorenteggio coincise con l'introduzione di nuovi modelli. Negli anni '60 ci fu un passo importante con il trasferimento ad Abbiategrasso e iniziò la produzione di televisori con il raggiungimento di un fatturato annuo di un miliardo di lire. Il successo di Mivar era basato sull'affidabilità, prezzi competitivi e il passaparola, ridotta necessità di investimenti pubblicitari. L'azienda affronta la concorrenza delle marche giapponesi, con l'introduzione della TV a colori negli anni '70. Divenne il secondo produttore nazionale, raggiungendo il 12% di quota di mercato nel 1988, superando persino Philips negli anni '90 con la costruzione di un nuovo stabilimento ad Abbiategrasso. Nel 1999, Mivar raggiunse un record di produzione di 950.000 apparecchi, con una quota di mercato del 35%. Negli anni 2000 il declino iniziò a causa dell'avvento delle nuove tecnologie come lo schermo piatto a cui non si erano preparati e con la riduzione dei costi di produzione da parte dei concorrenti più attrezzati alla novità. Nel 2001 si verificò la prima cassa integrazione e nei successivi anni l'azienda iniziò ad acquistare componenti dall'estero. Nonostante un tentativo di adeguamento tecnologico, la crisi divenne irreversibile e il fondatore Vichi, ormai 90enne, non riuscì a riportare in alto l'azienda, che amò fino alla fine. Nonostante tutto lo stabilimento modello costruito negli anni 2000 rimase testimonianza di quel modello d'azienda italiana, anche se non fu mai operativo. In quel luogo. Vichi aveva condiviso i pasti con sua moglie nella mensa dell'impianto. L'offerta ad uso gratuito degli spazi, fatta dalla famiglia, per progetti di ricerca e universitari e a vantaggio del territorio, non fu raccolta da nessuno, segnando così la fine di una storia. Staccò assegni per i suoi dipendenti, anche quando non c'era più alcuna produzione. Grande umanità, radicamento, ma mancò qualcosa, non solo il passaggio di testimone. Cosa si sarebbe potuto fare di più per salvare quel segmento? Per tante aziende pubbliche e private c'è stato un accanimento terapeutico, per altre è mancata la ricerca. E così il Paese ha continuato a domandare profili medio bassi e a formare poco. Accontentandosi dei momenti di boom non ha immaginato che sarebbe toccato ad altri quella magia.
E quante cose sono state fatte male sotto la spinta di quegli anni, dal punto di vista dell'impatto ambientale soprattutto. Molte cose sono diventate rapidamente vecchie in un Paese pieno zeppo di meraviglie antiche.
Le scuole sono l'esempio più brutto, le infrastrutture del patrimonio pubblico di quegli anni cominciano a venire giù, o restano un vero e proprio «pugno in un occhio», in particolare le costruzioni abitative degli anni 70 o i sottopassaggi, (niente a che vedere con gli acquedotti romani). Dobbiamo dire che la classe dirigente ha taciuto su quegli orrori. Certo siamo debitori ai tanti che hanno lottato e vinto battaglie sociali, hanno perso la vita, hanno immaginato l'Italia. L'Italia di Adriano Olivetti e Mario Tchou, dei Ragazzi di Barbiana, di Mario Pannunzio, o addirittura di Amadeo Peter Giannini che aprì la Bank of Italy in America. Ma non era ancora la Repubblica italiana, la maggior parte delle cose che amiamo nel nostro Paese c'erano prima. La Juve è del 1897, il Milan è del 1899, del 1908 l'Inter, del 1926 il Napoli, 1927 la Roma, è del 1876 il Corriere della sera, l'Europeo che ci manca tantissimo era del 1945 e non è arrivato ai giorni nostri, per intenderci. Ci sono i sindacati, la Cgil è del 1944, sei anni dopo la Cisl, con un divorzio burrascoso, e la Uil. La Rai è del 1954, vuol dire che noi conosciamo persone nate prima della Repubblica, prima del servizio pubblico, prima delle organizzazioni di rappresentanza, prima dei partiti. (Gioco forza la loro vita esile dopo la caduta del muro di Berlino e delle faccende giudiziarie di Tangentopoli). I presidenti della Repubblica sono sempre stati ovviamente più vecchi della propria nazione e non sarà per sempre così, non è così in altri Paesi con cui ci confrontiamo, per esempio la Francia. Ma è un dettaglio su cui raramente ci si sofferma. Sono lì da prima del cristianesimo, prima dei latini, prima dei greci, e abbiamo istituzioni che non raggiungono gli anni di un qualsiasi derby. Il tema di ricostruire, in chiave sostenibile è la nostra chance, di essere migliori, di ri-sognare il Paese per i nostri nipoti e per i loro figli. Uno sguardo così lontano che sembra un lusso. La lezione su come trattare i temi dell'inclusività, delle barriere architettoniche, ci è arrivata forte e chiara. Le sensibilità pedagogiche e le conoscenze dei manager del terzo settore per fare «bene il bene», abbattere i muri tra conoscenze che sembrano molto più alte oggi di allora, quando in quegli anni del dopoguerra un operaio diventò ingegnere (honoris causa) all'Olivetti.
Quindi, il potere di fare innovazione è il potere di far accadere le cose.



