L'eziologia criminologica delle devianze antinormative
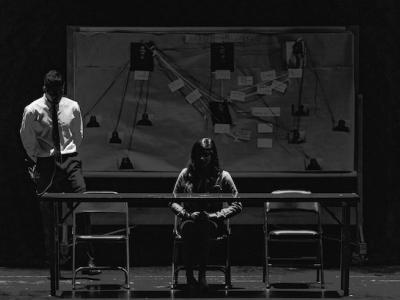
L'eziologia criminologica delle devianze antinormative
La ratio economica della criminalità
Come osservato da Bandini & Gatti & Marugo & Verde (1991)[1], la Criminologia statunitense è quella ove si è maggiormente approfondita la tematica dell'eziologia economica delle devianze antigiuridiche. Più nel dettaglio. Negli USA, il c.d. “ciclo economico” è stato affiancato alle tre variabili dei tipi di reato, delle diseguaglianze patrimoniali tra i consociati e delle statistiche penali. Ora, secondo un primo filone interpretativo, l'abbassamento del reddito medio e l'aumento della disoccupazione favorirebbero la nascita di tendenze criminogene nel tessuto sociali. Viceversa, altri Autori reputano che la devianza antigiuridica sia una variabile metatemporale non incrementata da periodi di depressione finanziaria nazionale. E' interessante, a tal proposito, la tesi dell'anglofono Gurr (1976)[2], a parere del quale “dalle evidenze empiriche emerge come, nel XIX Secolo, i reati comuni, a carattere patrimoniale e personale, aumentino durante i periodi di crisi economica e diminuiscano quando le condizioni economiche migliorino; nel XX Secolo, invece, un peggioramento delle condizioni economiche è associato a lievi aumenti delle percentuali criminose, sia patrimoniali sia personali, mentre, quando cresce la ricchezza generale, aumentano anche i reati di questo tipo”.
A parere di chi redige, associare la povertà economica alla criminalità antinormativa risulta assai pericoloso, in tanto in quanto il rischio antidemocratico ed antiegalitario è quello di emarginare sine juxta causa le fasce meno abbienti della popolazione. P.e., è un dato oggetivo che lo white collar crime s'innesta in qualunque scenario macroeconomico. All'opposto, il pericolo è quello di creare la nascita del falso mito del disagiato perennemente ed ontologicamente proteso alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona. Entro tale ottica si colloca pure Giannini (1987)[3], la quale si dichiara assai scettica con afferenza alle statistiche criminologiche che predicano una presunta correlazione tra l'aumento della penuria economica e quello della commissione di reati. Di nuovo, anche Giannini (ibidem)[4] si smarca dall'immagine stereotipata dell'emarginato delinquente ed aggressivo a causa del proprio scarso reddito. Diverso, invece, è il parere di Brenner (1976)[5], che ha censito il rapporto tra devianze criminali e povertà, tra il 1900 ed il 1973, negli USA, in Canada, in Inghilterra, nel Galles ed in Scozia. Più precisamente, il Dottrinario testé menzionato ha distinto tra denunzie della PG, arresti, rinvii a giudizio, condanne e detenzioni. Inoltre, nella statistica qui in parola, la delittuosità antisociale è stata studiata in relazione a precise “variabili economiche”, ossia il livello nazionale di disoccupazione, il PNL, il reddito medio pro capite ed il tasso di inflazione. Brenner (ibidem)[6] non è stato accolto con entusiatico favore, ma, in ogni caso, egli conclude che i bisogni economici possono spingere alla devianza, ovverosia “gli indici economici risultano fortemente correlati in senso positivo con tutti gli indici relativi alla criminalità. La relazione tra disoccupazione e criminalità conferma la teoria tradizionale per cui le difficoltà economiche aumentano la necessità – per le classi sociali più basse – di ricorrere a mezzi di sussistenza illegali. Per quanto riguarda, invece, la relazione tra gli indici di criminalità ed il PIL pro capite (considerato come indice di sviluppo economico), la crescita economica conduce, paradossalmente, a diseguaglianze di reddito, tra i differenti strati sociali, molto maggiori rispetto a quanto accade nelle fasi di recessione; in questo senso, quindi, lo sviluppo economico è collegato alla deprivazione relativa”.
Di nuovo, che scrive si dissocia da una consimile interpretazione socio-giuridica del disagio economico. Infatti, associare la povertà del reddito alla criminogenesi significa predicare la non eguaglianza tra le varie classi sociali; in particolar modo, una consimile ottica criminologica rischia di penalizzare specialmente i cittadini non autoctoni e genera il mito lombrosiano dello straniero delinquente e disturbante. Brenner (ibidem)[7], seppur inconsapevolmente, ha alimentato un classismo ed una xenofobia non accettabile all'interno degli odierni sistemi democratico-sociali- P.e., del resto, la criminalità dei colletti bianchi dimostra, senza ombra di dubbio, che la devianza antisociale colpisce anche i gruppi della borghesia medio-alta.
Per quanto attiene alla Criminologia italiofona, da segnalare è l'Opera di Marselli & Vannini (1996)[8], secondo cui il comportamento criminale è da considerare –come ogni altro comportamento – il risultato di un calcolo razionale dei costi e dei benefici”. La statistica di Marselli & Vannini (ibidem)[9] ha censito il rapporto tra ricchezza/povertà e tasso di delinquenza nelle varie regioni italiane, con riferimento ai quattro delitti del furto, dell'omicidio volontario, della rapina e della truffa. Le variabili economiche valutate dai due predetti Autori sono il livello dei consumi pro capite, il tasso di occupazione/disoccupazione e la percentuale dei “colletti bianchi” analizzati; da precisare è che la criminalità dei liberi professionisti e dei pubblici ufficiali necessita di un'analisi autonoma che non infici la bontà delle statistiche generali. Nelle loro conclusioni, ognimmodo, Marselli & Vannini (ibidem)[10] sintetizzano che “il ciclo economico esercita tre distinti effetti di segno contrastante sulle frequenze dei delitti contro il patrimonio: durante una fase di espansione economica, il consumo cresce, ed insieme con il volume ed il valore delle merci scambiate, aumentano anche le opportunità per i potenziali criminali (effetto opportunità); la crescita dei comportamenti induce dei cambiamenti nelle abitudini di vita, sollecitando comportamenti che rendono le persone e le loro proprietà più esposte alle mire dei criminali (effetto stile di vita); infine, quanto il reddito ed i consumi crescono, aumentano anche le possibilità di acquisire, per vie legali, i bei che si desiderano (effetto motivazione)”.
Più nel dettaglio, sempre in Marselli & Vannini (ibidem)[11], nelle regioni italiane, la truffa si espande quando aumentano i consumi; in secondo luogo, la crescita della disoccupazione provoca un innalzamento dell'omicidio volontario e della rapina, mentre il furto diminuisce; in terzo ed ultimo luogo, all'aumentare dello white collar crime, dilagano pure l'omicidio volontario e la rapina. I Dottrinari qui in esame precisano pure che la disoccupazione, il basso reddito regionale ed il “dominio” dei colletti bianchi “tendono ad incrementare i reati di tipo violento, che possiamo associare stati individuali di frustrazione ed a stati sociali di anomia e di disorganizzazione collettiva”. Dunque, a ragion veduta, Marselli & Vannini (ibidem)[12] giungono alla conclusione secondo cui la povertà economica non è automaticamente criminogena, in tanto in quanto molto dipende dal “tipo qualitativo” del disagio economico analizzato. P.e., la variabile del reddito è disgiunta da quella dei consumi effettivi. Pertanto, i due summenzionati Dottrinari ripudiano, in maniera lodevole, un'accezione classista ed antidemocratica della criminogenesi economico-patrimoniale. Il soggetto povero non è lombrosianamente e deterministicamente incline alla devianza. E' ripristinata, quindi, pure la parità assiologica tra autoctoni benestanti e stranieri tendenzialmente meno agiati sotto il profilo reddituale.
Diseguaglianza economica e criminalità
Nella Criminologia occidentale è pacifico, soprattutto sotto il profilo statistico, che la povertà economica cagiona un ricorso frequente alle devianze connotate dalla violenza fisica. P.e., Giannini (ibidem)[13] rileva che “sei studi compiuti a livello internazionale dimostrano come le nazioni con maggiori diseguaglianze economiche presentino presentino percentuali più alte di omicidi”. Similmente, Messner (1982)[14] sostiene che, sempre negli Ordinamenti macroeconomicamente disagiati, “anche utilizzando indici di diseguaglianza tra di loro differenti, emerge una relazione diretta e positiva tra diseguaglianze economiche e reati violenti”. Pertanto, consta che la non idoneità dei redditi reca all'uso della violenza, la quale si pone come una sorta di valvola di sfogo collettiva grazie alla quale sarebbe possibile ripristinare una convivenza sociale maggiormente democratica. In buona sostanza, la precarietà finanziaria trova una compensazione emotiva nell'omicidio volontario, nella rapina e nello stupro. Parimenti, nelle statistiche common lawyers, Loftin & Hill (1974)[15] hanno censito che “[sussiste] una correlazione positiva tra i tassi medi di omicidio per ogni singolo Stato degli USA, nel triennio 1959-1961, ed un indice di povertà strutturale composto da una misura di povertà (percentuale di popolazione, nello Stato, con un reddito inferiore ai 1.000 dollari annui) e da una serie di indicatori relativi alla struttura familiare, al livello educativo ed alle condizioni sanitarie”.
A parere di chi commenta, tuttavia, non si deve commettere l'errore di interpretare in sendo deterministicov tale legame criminogeno tra il disagio reddituale ed il compimento di delitti violenti; le assolutizzazioni, infatti, non tengono conto della pur libera autodeterminazione di ciascun consociato. Dal canto suo, in ogni caso, anche l'inglese McDonald (1976)[16] ribadisce che “in generale, la maggior parte delle ricerche concorda nel rilevare l'esistenza di un'associazione significativa tra la criminalità e la diseguaglianza economica”. Da citare, sempre nella Criminologia anglofona, è pure Braithwaite (1979)[17], secondo cui “[la diseguaglianza economica], se propriamente concattualizzata e misurata, costituisce un importante fattore nella spiegazione dell'andamento dei reati”. Di nuovo, chi redige segnala, tuttavia, la pericolosità di una correlazione automatica e falsante tra la povertà familiare e la criminogenesi; l'essere economicamente disagiati non reca, in modo ineludibile, al compimento necessario di delitti violenti. D'altra parte, la xenofobia razzista nasce spesso dal postulare un legame algebrico tra diseguaglianze patrimoniali e delinquenza. P.e., a parere di chi scrive, Giannini (ibidem)[18] commette un grave errore nel sostenere che “elevate percentuali criminose sono associate alle classi inferiori, quando gli altri soggetti sono benestanti”. Infatti, in maniera provvidenziale, Merton (1968/2000)[19] contesta consimili approcci classisti e lombrosiani ed afferma che “nel rapporto tra delitto e povertà, l'avere uno status economico basso ha un diverso ruolo dinamico a seconda delle strutture sociali e culturali. Pertanto, non ci dobbiamo aspettare che, tra criminalità e povertà, vi sia una correlazione lineare […]. La povertà non è una variabile isolata, che opera sempre allo stesso modo e dovunque; essa è soltanto una in un complesso di variabili interdipendenti sociali e culturali che debbono essere identificate”.
Come si nota, quindi, Merton (ibidem)[20] esorta il Criminologo a non assolutizzare il concetto di “povertà”, in tanto in quanto le scarse disponibilità pecuniarie non possiedono, sempre e comunque, un ruolo inevitabilmente criminogeno. E' necessario contesualizzare ciascuna fattispecie di comportamento antisociale e/o antigiuridico. Di nuovo, il pensiero corre allo white collar crime, che non s'innesta mai in un ambiente degradato e precario, pur manifestando una pericolosità acuta e destabilizzante nel lungo periodo. Oppure, si ponga mente all'uso di cocaina e alcol presso la media e l'alta borghesia. Analoghe osservazioni valgono pure con attinenza alle devianze sessuali antinormative presso i gruppi sociali redditualmente benestanti. Gli immigrati e le famiglie economicamente povere non manifestano livelli di criminogenesi maggiori rispetto a soggetti o gruppi di soggetti più abbienti. Ciò premesso, dunque, Merton (ibidem)[21] risulta pienamente condivisibile allorquando obbliga l'Operatore a contestualizzare ciascun reato e a “prendere in considerazione l'intero quadro [nel quale s'innesta] il basso status socio-economico”. P.e., l'abuso di stupefacenti e di bevende alcoliche potrebbe esercitare una spinta alla devianza di gran lunga preponderante in raffronto alla sola variabile della povertà. Oppure ancora, si pensi a fattori predisponenti quali il disagio scolastico o la non idoneità delle agenzie di controllo.
Malaugurevolmente, nella Criminologia italiofona. Mancano studi accurati con attinenza al presunto legame diretto tra povertà e delinquenza. Fa eccezione Melossi (1985)[22] e Melossi (1997)[23], il quale ha analizzato il ruolo potenzialmente eziologico del reddito nei confronti dei responsabili di crimini perseguiti in Italia dall'AG tra il 1896 ed il 1975. A tal proposito, Melossi (1985)[24] ha osservato che “non esiste una relazione tra condizioni economiche e numero di condanne. Le variazioni dell'economia sembrano essere, quindi, non direttamente influenti sulla criminalità reale”. Soltanto nel secondo studio (Melossi – 1997 -)[25], il citato Dottrinario riconosce un legame causale tra l'omicidio volontario ed il reddito nazionale pro capite, in Italia, tra il 1863 ed il 1994. Siffatta connessione tra assassinii e precarietà economica, per l'Autore qui in parola, sarebbe stata provocata “dall'aumento nei livelli di conflitto e di frustrazione [sociale]”. Tuttavia, Melossi (1997)[26] invita anon tradire mai un “approccio costruzionista allo studio dei fenomeni legati alla criminalità”, ovverosia, tra il 1863 ed il 1994, è pur vero che non sono mancati “allarmi sociali” che hanno sicuramente amplificato le emergenze reali connesse alla devianza violenta. Dunque, queste “ondate di omicidi” vanno lette nel contesto di indebite demagogie che, purtroppo, hanno influenzato il lavoro della PG e dell'AG.
Il contesto sociale e territoriale della criminalità
All'interno delle statistiche criminologiche, è indispensabile connettere le varie manifestazioni delinquenziali con le specificità delle zone territoriali. Tale “ecologia” dei reati, nel senso etimologico del lemma, è stata approfondita dai Criminologi francofoni dell'Ottocento, ma, per il vero, molti Dottrinari commettono l'errore di non analizzare meticolosamente le singole porzioni geografiche di estrinsecazione del crimine. Provvidenzialmente, negli USA, esistono censimenti attinenti al problema della c.d. “geografia” dell'antigiuridicità.
Nelle analisi di Schuessler (1962)[27], è stato riscontrato che, nel Nordamerica, le aggressioni e gli omicidi volontari, perlomeno negli Anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, si verificavano con maggiore frequenza nei quartieri statunitensi ove dominavano le minoranze afroamericane, il sovraffollamento abitativo e la povertà economica. Secondo tale Auore, la delittuosità più marcata di queste aree urbane è connessa “ad una dinamica di frustrazione-aggressione indotta dalla discrepanza tra mete e mezzi legittimi”. Due anni dopo, Schuessler & Slatin (1964)[28] hanno ripetuto il censimento. Ne è emerso che, nelle medesime città, i delitti contro il patrimonio sono incrementati dal “fattore anomico” (abbondanza di suicidi e di divorzi); invece, i delitti contro la persona risultano eziologicamente influenzati dal “fattore di minoranza” (presenza di afroamericani e sovraffollamento abitativo); all'opposto, nella statistica qui in esame, sono risultati ininfluenti i fattori familiari, di conformità e, specialmente, economici. Dunque, Schuessler & Slatin (ibidem)[29] hanno negato anch'essi una correlazione automatica tra criminalità e scarso reddito e, inoltre, hanno dimostrato che è sempre e comunque indispensabile contestualizzare accuratamente ciascun fattore criminogenetico, compresi i fattori di tipo economico, poiché non esistono eziologie deterministicamente preordinate.
Un censimento assai simile, sempre negli USA, è stato allestito da Harries (1976)[30], che ha mappato 726 città statunitensi sulla base di ben 25 fattori criminogeni. Il risultato è stato che rapine, furti ed aggressioni sono correlati alla presenza di afroamericani, famiglie monoparentali e sovraffollamento abitativo; in secondo luogo, i furti in case private sembrano collegati ad una “elevata mobilità residenziale della popolazione”; in terzo luogo, le aggressioni abbondano nei quartieri prevalentemente abitati da poveri di pelle bianca.
Di nuovo, anche Harries (ibidem)[31] conferma l'inaccettabilità del presunto legame causale tra scarso reddito e devianze antinormative. Pertanto, i Dottrinari statunitensi ribadiscono l'indispensabilità di una costante, precisa, meticolosa contestualizzazione, affrancata da stereotipi deterministici scientificamente scorretti. Detto in altri tremini, non è veritiero il mito popululistico della delinquenza eziologicamente provocata dallo “sporco negro drogato”. P.e., Harries (1974)[32], due anni prima della statistica or ora esaminata, ha avuto modo di riscontrare che la criminalità è spesso dipendente dalle dimensioni territoriali del quartiere e non solo, come si reputa di solito, dalle variabili soggettive di matrice socio-demografica.
Degno di menzione, sempre negli USA, è pure Rosenfeld (1986)[33], che ha mappato una decina di “aggregati metropolitani”. In primo luogo, detto Autore ha messo in luce che la “discordanza tra mete culturali e mezzi istituzionali” non è onnipresente nella criminogenesi, bensì essa influisce solamente sui reati di omicidio, violenza sessuale, aggressione, furto, furto in abitazione e furto di veicoli a motore. In secondo luogo, egli ha concluso che “le politiche di welfare hanno scarsi effetti sulla [diminuzione della] criminalità”; ovverosia, un assistenzialismo marcato e premuroso non protegge da una carriera criminale coloro che sono affidati ai servizi sociali. Anzi, in taluni casi, la presenza ipertrofica dell'assistenza pubblica può aggravare gli ordinari equilibri delle famiglie e dei singoli all'interno del mercato del lavoro.
Nella Criminologia statunitense, è molto diffuso il metodo di mappatura della “social area analysis”, fondato da Shevky & Bell (1955)[34]. questi Dottrinari analizzano, per ogni quartiere o area geografica, tre condizioni: lo “status familiare”, che contempla la percentuale, in ciascuna zona, di donne lavoratrici, numero medio di figli per donna e famiglie stabilmente residenti; lo “status etnico”, che sta ad indicare la cifra delle minoranze etniche per ciascuna area considerata; lo “status economico”, che rileva il reddito pro capite ed il livello di scolarizzazione degli individui abitanti la zona. P.e., la social area analysis è stata impiegata, con afferenza alla città di Seattle, da Schmid (1960)[35]. Tale Dottrinario ha osservato che lo status familiare è quello che incide maggiormente sulla criminogenesi; ovverosia, l'aumento delle donne lavoratrici, la scarsità di figli per donna ed il basso numero di famiglie stabilmente residenti recano ad un aumento della delittuosità. Dunque, questo censimento conferma la centralità della famiglia tradizionale quale primaria ed insostituibile agenzia di controllo. Il metodo della social area analysis è stato applicato anche da Quinney (1964)[36] nell'analisi delle devianze antinormative nella cittadina di Lexington (Kentucky). Dalla testé citata mappatura è emerso, per gli infrattori maggiorenni, che lo status economico e criminogeneticamente irrilevante; lo status etnico, invece, risulta fondamentale; infine, lo status familiare non è decisivo nell'eziologia della carriera criminale degli adulti. Viceversa, per gli infrattori minorenni, solamente lo status familiare incide sulla devianza, mentre sono non determinanti lo status economico e quello etnico, il che consente, di nuovo, di ribadire il ruolo protettivo ed educativo della famiglia non disfunzionale.
Notevole è anche il “routine activity approach”, fondato da Cohen & Felson (1979)[37]. Idue citati Dottrinari, anziché analizzare decine e decine di fattori criminogeni, sintetizzano affermando che la Criminologia deve “focalizzarsi sull'osservazione delle attività di routine e delle opportunità criminali […]. Dagli Anni '50 in poi, si è verificato un incremento considerevole della criminalità, dovuto, essenzialmente, alle aumentate opportunità criminali: il minor numero di membri delle famiglie, laumento degli alloggi abitati da individui singoli, il frequente allontanamento della donne dall'abitazione per motivi di lavoro, la mobilità sociale, la sempre maggiore facilità e velocità negli spostamenti sono solo alcuni dei fenomeni legati alle profonde trasformazioni della società contemporanea che producono un allentamento dei legami comunitari e di controllo sociale e, parallelamente, un aumento oggettivo delle situazioni potenzialmente criminogene”. Come si può notare, il routine activity approach mette in secondo piano lo status familiare, quello etnico e quello economico e sottolinea il ruolo primario di certune “abitudini” favorenti il crimine comune.
Oppure ancora, Baldwin & Bottoms (1976)[38] hanno effettuato una mappatura criminologica sulla città inglese di Sheffield sulla base di nuovi “dati socio-demografici”, quali la classe sociale, il tipo di titolo all'abitazione (proprietà/affitto privato/concessione della PA) e densità e disorganizzazione sociale. Da questa ricerca è emerso che, nelle zone ove prevalgono gli affitti da privati, la delinquenza viene causata da una forte disorganizzazione sociale; invece, nelle zone ove dominano le concessioni della PA, le devianze sono connesse all'appartenenza dei residenti a “classi sociali basse”. Come sempre, che scrive reputa non deterministicamente validi i summenzionati asserti, ammessa e non concessa, tra l'altro, la pertinenza tecnica dei lemmi “classe sociale bassa”.
Nella fattispecie dell'Italia, va ricordato che l'ISTAT, nel 1982, ha suddiviso il territorio nazionale in 5 macro-regioni e tale ripartizione viene seguita tutt'oggi. P.e., Corrado (1986)[39] rileva, in modo incontestabile sotto il profilo fattuale, che “l'Italia centrale presenta il più alto tasso di criminalità (4.107 delitti denunciati su 100.000 abitanti), seguita dall'Italia nord-occidentale (3.800) e dall'Italia meridionale (3.672). L'Italia nord-orientale (3.074) e l'Italia insulare (3.023) si collocano, invece, sotto la media nazionale, che è di 3.604 delitti denunziati ogni 100.000 abitanti. Le regioni che presentano tassi superiori alla media nazionale sono soltanto Lazio, Puglia, Liguria, Campania e Lombardia”. Come intuibile e come puntualizzato da Corrado (ibidem)[40], “i maggiori quozienti di criminalità si riscontrano nelle regioni (tranne la Puglia) ove si trovano i più grandi agglomerati urbani (con l'eccezione del Piemonte) e/o tra le più industrializzate. D'altra parte, i minori livelli di criminalità si possono notare in regioni con i più bassi livelli di urbanizzazione e di industrializzazione (quali il Molise, la Basilicata, la Calabria e la Sardegna), indipendentemente da locali fenomeni di grave delinquenza (quali sequestri di persona e/o delitti di stampo mafioso in senso lato)”.
Probabilmente, è pur vero che la cività rurale pre-novecentesca arginava la criminogenesie consentiva un “social control” meno complesso. Del resto, come pertinentemente rimarcato da Park & Burgess & McKenzie (1925/1979)[41], “la delinquenza è, in un certo senso, la misura del mancato funzionamento delle organizzazioni della nostra comunità […] Con lo sviluppo delle grandi città, con l'estesa divisione del lavoro sopraggiunta con l'industria meccanizzata, con il movimento ed il mutamento derivanti dalla moltiplicazione dei mezzi di trasporto e di comunicazione, le vecchie forme di controllo sociale rappresentate dalla famiglia, dal vicinato e dalla comunità locale sono state indebolite e la loro influenza è molto diminuita. Noi stamo vivendo un periodo di individualizzazione e di disorganizzazione sociale. Tutto si trova in uno stato di agitazione, tutto sembra subire un mutamento”. Anche Christie, in svariate sue Opere, rimpiangeva la Norvegia contadina dei secoli passati, con i suoi molteplici luoghi di genuina aggregazione umana e sociale. Oggi, ormai, le agenzie di controllo tradizionali sono state sostituite dall'indsutrializzazione e dalla concentrazione demografica urbana. Del resto, i mezzi di trasporto consentono buna liquidità sociale che prima era impensabile. La conseguenza è stata una radicale trasformazione del controllo sociale. Il mondo del lavoro segue regole industriali. La famiglia ha cessato di svolgere i propri compiti tradizionali di sorveglianza e di educazione degli adolescenti. La scuola veicola nozioni culturali maggiori, ma non è più un'agenzia di controllo. In tale contesto domina l'anomia più totale, al punto che è cambiata persino l'eziologia della devianza antisociale e/o antigiuridica. In buona sostanza, oggi prevale una criminogenesi multifattoriale o, meglio, anarchica e, soprattutto, priva di qualsivoglia istanza morale e moralizzante.
[1]Bandini & Gatti & Marugo & Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Giuffrè, Milano, 1991
[2]Gurr, Rogues, Rebels and Reformers, Sage, Beverly Hills, 1976
[3]Giannini, Aspetti economici della criminalità, in Ferracuti (a cura di), Criminologia e società, in Ferracuti (a cura di), trattato di Criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Giuffrè, Milano, 1987
[4]Giannini, op. cit.
[5]Brenner, Effects on Economy on Criminal Behavior and the Administration of Criminal justice in the United States, Canada, England and Wales and Scotland, in UNSDRI, Economic Crises and Crime, Publication n. 151, United Nations Social Defence Research Institute, Rome, 1976
[6]Brenner, op. cit.
[7]Brenner, op. cit.
[8]Marselli & Vannini, La criminalità nelle regioni italiane: il ruolo del sistema sanzionatorio, delle motivazioni economiche e del contesto sociale, Crenos, Cagliari, 1996
[9]Marselli & Vannini, op. cit.
[10]Marselli & Vannini, op. cit.
[11]Marselli & Vannini, op. cit.
[12]Marselli & Vannini, op. cit.
[13]Giannini, op. cit.
[14]Messner, Societal Development, Social Equality and Homicide, Social Forces, 61/1982
[15]Loftin & Hill, Regional Subculture and Homicide: An Examination of the Gastil-Hackney Thesis, in American Sociological Review, 39/1974
[16]McDonald, Sociology of Law and Order, Faber and Faber, London, 1976
[17]Braithwaite, Inequality, Crime and Public Policy, Routledge and Kegan, London, 1979
[18]Giannini, op. cit.
[19]Merton, Social theory and social structure, New York, 1968. Traduzione italiana: Teoria e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 2000
[20]Merton, op. cit.
[21]Merton, op. cit.
[22]Melossi, Punishment and Social Action: Changing Vocabularies of Punitive Motive within a Political Business Cycle, in Current Perspectives in Social Theory, VI, 1985
[23]Melossi, Andamento economico, incarcerazione, omicidi e allarme sociale in Italia: 1863-1994, in Violante (a cura di), La criminalità, Storia d'Italia, Annali, Einaudi, Torino, 1997
[24]Melossi, op. cit.
[25]Melossi, op. cit.
[26]Melossi, op. cit.
[27]Schuessler, Component of Variation in City Crime Rates, Social Problems, 9/1962
[28]Schuessler & Slatin, Sources of Variation in US City Crime, 1950 and 1960, in Journal of Research in Crime and Delinquency, 1/1964
[29]Schuessler & Slatin, op. cit.
[30]Harries, Cities and Crime: A Geographic Model, Criminology, 14/1976
[31]Harries, op. cit.
[32]Harries,The Geography of Crime and Justice; McGraw-Hill, New York, 1974
[33]Rosenfeld, Urban Crime Rates: Effects of Inequality, Welfare, Dependency, Region and Race, in Byrne & Sampson (Eds.), The Social Ecology of Crime, Springer-Verlag, New York, 1986
[34]Shevky & Bell, Social Area Analysis: Theory, Illustrative Application and Computational Procedures, Stanford University Press, Stanford, 1955
[35]Schmid, Urban Crime Areas: Part II, American Sociological Review, 25/1960
[36]Quinney, Crime, Delinquency and Social Areas, Journal of Research in Crime and Delinquency, 1/1964
[37]Cohen & Felson, On estimating the Social Costs of National Economic Policy, A Critical Examination of the Brenner Study, Social Indicator Research, 6/1979
[38]Baldwin & Bottoms, The Urban Criminal. A Study in Sheffield, Tavistock, London, 1976
[39]Corrado, Statistica giudiziaria, Maggioli, Rimini, 1986
[40]Corrado, op. cit.
[41]Park & Burgess & McKenzie, The City, University Chicago Press, Chicago, 1925. traduzione italiana: La città, Edizioni di Comunità, Milano, 1979



