Antonio e la lucertola: una benefica rotazione prospettica

L’ultimo libro di Silvia Cecchi si intitola Antonio e la lucertola. Dal paradigma imputatocentrico al paradigma offesocentrico. L’Autrice, sostituto procuratore presso la Procura di Pesaro, offre in queste pagine al lettore una profonda riflessione sulla necessità di superare la logica che informa tuttora tanto l’impianto sanzionatorio quanto l’interpretazione e l’applicazione delle norme penali. Perché, come sottolinea nella Premessa, «un sistema penale che vacilla sotto l’attacco di critiche e perplessità, dal suo interno come dal suo esterno, e di cui nessuno è contento, ci interroga sui fondamenti primi su cui esso si regge.» Quale potrebbe essere allora la soluzione possibile?
Sostituire il paradigma imputatocentrico, un diritto penale del fatto e dell’offesa come quello previsto dalla Costituzione, con il paradigma offesocentrico: una rotazione prospettica che apporterebbe importanti benefici, utili a chiarire le ragioni della penalità, a interpretare e applicare in concreto le norme penali e a individuare le sanzioni più appropriate.
L’occasione di imbastire questa riflessione è data dall’incontro con un detenuto di lungo corso di nome Antonio, avvenuto durante un permesso premio di tre giorni che l’ergastolano trascorre nella canonica del cappellano del carcere di sicurezza in cui è recluso. Durante il colloquio, ascoltando la sua storia e i suoi trascorsi delittuosi, gli suggerisce la lettura di un significativo libro-memoriale scritto da un altro detenuto, ripromettendosi di raccontargli, al prossimo incontro, il mito di Narciso ed Eco: infatti, solo quando riconoscerà se stesso in entrambi (l’io-narciso crudele e il dolore di Eco che diventa il suo dolore) potrà comprendere la propria carriera criminale e arrivare alla coscienza di sé.
La Cecchi propone con questo scritto un’ottica interpretativa differente per la trattazione dei problemi più delicati della penalità contemporanea, con l’intento di richiamare l’attenzione su temi usciti già da qualche anno al di fuori della ristretta cerchia di studiosi e magistrati, ed entrati nella coscienza di tutti i cittadini. Occorre quindi, al momento della scelta e dell’applicazione ed esecuzione della sanzione, valutare la complessità della persona, la sua storia, la sua indole.
Chiudono le riflessioni due lettere di un altro Antonio, Antonio Gramsci, che dal carcere di Turi nel 1929 scrive al figlio Delio: “Ed io ti darò notizie di una rosa che ho piantato e di una lucertola che voglio educare”.
Il volume è arricchito da una Postfazione di Rosario Salamone, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Roma.
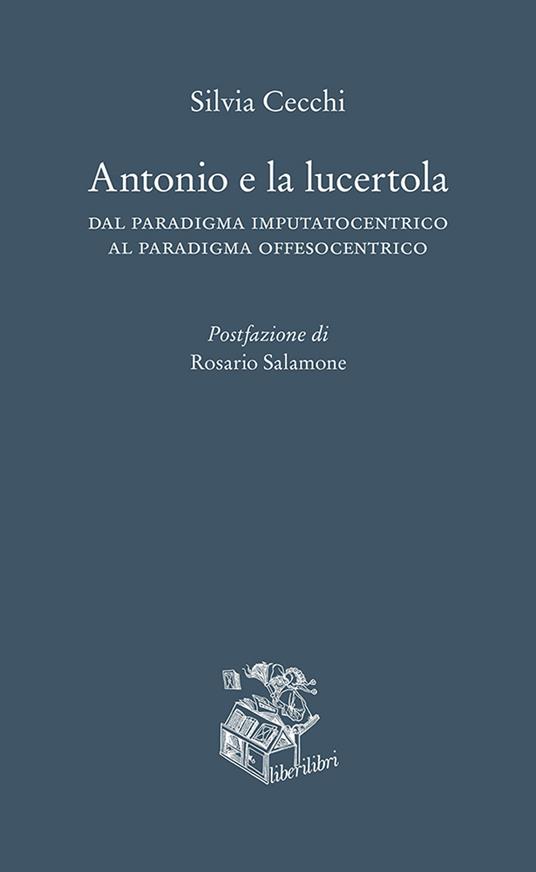
Silvia Cecchi ha già pubblicato per Liberilibri Giustizia relativa e pena assoluta. Argomenti contro la giuridicità della pena carceraria (2011) con Postfazione di V. Mathieu; Sulla pena. Al di là del carcere, insieme a G. Fiandaca, G. Di Rosa, P. Bonetti, M. Della Dora (2013); Partire dalla pena. Il tramonto del carcere, insieme a G. Di Rosa, T. E. Epidendio, con Prefazione di L. Eusebi (2015).
Qui di seguito un estratto dal capitolo finale, che riassume il senso del libro:
«Ed ecco che ciò che non trova soluzione in una lettura “a partire dall’autore”, trova o può trovare soluzione in una lettura “a partire dal bene offeso”. A scostamenti interpretativi apparentemente minimi possono seguire effetti di vasta portata. Più ampio riconoscimento troveranno fatti storici concreti nel corpo delle norme penali, pur sempre sul filo rigoroso della tipicità e tassatività.
Si potrà allora verificare che la critica alla pena carceraria indifferenziata e la critica a un carcere disumano non conducono affatto a una maggior tolleranza verso la trasgressione penale dietro il paravento di un umanitarismo facile, sfocato e di scarso pregio; né conducono a una sottovalutazione del “male del reato”, come viene contestato dai sostenitori di altre visioni della penalità.
La prospettiva qui proposta conduce bensì all’esito opposto, a una più rigorosa e severa applicazione delle norme penali, interpretate nella massima latitudine che la loro formulazione consente e che il bene giuridico reclama per l’effettività della propria tutela.
L’esperienza giudiziaria mi convince che una giusta sanzione è, o sarebbe, in grado di rimuovere l’ostacolo maggiore all’effettività ed efficacia della tutela penale, giacché anche fattispecie di reato meditate e ben formulate saranno destinate a disapplicazione se non associate a una pena giusta.
Se dunque il paradigma imputatocentrico si dimostra con sempre maggiore evidenza un limite teorico fortemente condizionante rispetto ai fini del sistema penale nel suo insieme, sotto plurimi profili (effettivo presidio dei beni; corretta e utile esegesi dei precetti; accertamento delle responsabilità), tuttavia l’anello di rottura del sistema si lascia individuare a tutt’oggi proprio nella sanzione carceraria applicata in assenza del necessario coefficiente di pericolosità e dispensata in modo indiscriminato, livellatore, retribuzionisticamente e moralisticamente afflittivo.
Il sistema non troverà le forze necessarie per evolvere se non dopo avere indovinato la risposta liberatoria che ci chiede la Sfinge insediata alle porte della cittadella della penalità.
I due baluardi stanno e cadono insieme: quale sanzione più appropriata di una pena retribuzionistica carceraria, di stampo afflittivo-espiativo, in un sistema penale incentrato sulla persona dell’imputato-reo? E d’altra parte, simmetricamente: come potrebbe una sanzione siffatta non porre al centro della nostra attenzione l’imputato e la tutela garantistica integrale della sua persona? Detto in altre parole: come potrebbe una sanzione retribuzionistica carceraria non associarsi a un sistema penale imputatocentrico?
Non vi è magistrato avveduto che non sappia, se pure con sapere generico, al momento di infliggere la pena della reclusione, che cosa la reclusione comporti, e che non avverta in coscienza una sorda remora nell’irrogarla: ciò basta a instillargli una sorta di pavor puniendi.
E tuttavia, tra sapere generico e sapere specifico la distanza rimane grande.
È infatti il sapere specifico a porre le domande che più ci sgomentano: perché imporre ad ogni “nuovo giunto” l’umiliazione della perquisizione corporale e la somministrazione del test antisuicidio? Perché togliergli l’orologio, la penna, il libro che ha desiderato portare con sé (per poi ridarglielo dopo giorni di attesa burocratica e dietro “domandina”)? Perché non dotare la cella di prima accoglienza di qualche riproduzione illustrata appesa al muro e di un calendario su cui poter segnare il succedersi dei giorni? Perché negargli ogni informazione per diversi giorni consecutivi? Perché togliere al detenuto la fisicità del suo corpo trasformandolo di giorno in giorno in un’ombra? Perché non conservagli pur minime occasioni di relazione (prevedere per esempio che il detenuto possa da subito prendersi cura di una piccola pianta o di un animale domestico, nei debiti tempi e modi)? Perché costringerlo entro celle sovraffollate? Perché la cella “liscia”, la cella di rigore, la cella arroventata d’estate e gelida d’inverno?
È vero che tutto ciò non sempre accade, ma accadeva fino a pochi anni o mesi or sono, e tuttora sovente accade, a esprimere la vera filosofia dell’istituzione carceraria.
Sono tutti aspetti particolari, dettagli materiali che stanno al di là dell’immaginazione e delle buone intenzioni anche di quei magistrati che applicano la legge con scrupolo e professionalità, dalla quale ultima dipenderà semmai la differenza fra una sanzione carceraria inflitta con ragionevole misura (sotto il profilo quantitativo), grazie a una razionale dosimetria della pena, e una sanzione carceraria inflitta sulla base di prassi tariffarie più o meno omologate.
Pur dopo le importanti riforme (lasciate in grande misura sulla carta) il carcere resta infatti il medesimo: un’istituzione totale, che esprime ragioni e finalità disfunzionali rispetto ai fini perseguiti, ad eccezione, come detto, della funzione di necessario contenimento di tutti gli autori di reati di accertata pericolosità – onde si dovrebbe pensare al carcere come cautela e non come pena: ciò che presuppone una competenza inedita quanto decisiva nel riconoscere e valutare, dell’autore di condotte offensive, la sua pericolosità-rispetto-al-bene; l’adozione di misure restrittive “subito”, scelte nella loro maggiore efficacia contenitiva; il loro mantenimento per tutto il tempo in cui la pericolosità permane. Per inciso tale momento delicatissimo dell’attività giurisdizionale rinvia alla importanza dell’esame il più possibile diretto e ripetuto della persona offesa, spesso più eloquente, insegna l’esperienza, dell’esame dell’aggressore (la vittima odora di terrore, di paralisi, di preda inseguita e annichilita).
Per il resto, il carcere resta un’istituzione che, come si è visto, punisce troppo o troppo poco, quasi mai giustamente, mancando quasi sempre il bersaglio; istituzione congenitamente incapace sia di rispondere ai bisogni di tutela dei singoli e ai bisogni di sicurezza della collettività, sia di modellarsi sulle specifiche tipologie dei reati e sulle peculiarità dei loro autori.»



