Capitalism in America di Alan Greenspan, Adrian Wooldridge

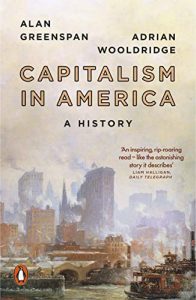
Perché leggere questo libro
In questa affascinante storia del capitalismo americano, Alan Greenspan, celebre ex presidente della Federal Reserve, e il giornalista Adrian Wooldridge ricostruiscono la storia dell’economia statunitense dalle origini fino ai nostri giorni. Il libro narra una storia di imprese titaniche, di figure imprenditoriali leggendarie, di progressi stupefacenti e di trionfanti scoperte. Il genio dell’America, affermano gli autori, è stato il suo entusiasmo per la “distruzione creativa”, l’incessante scomparsa del vecchio che cede il passo al nuovo. Per quanto disordinato e doloroso, questo processo ha portato la stragrande maggioranza degli americani a livelli di vita inimmaginabili anche solo poche generazioni fa. In un momento in cui la produttività è di nuovo in stallo, e la preminenza americana nel mondo sembra incerta, Capitalism in America afferma che il gigantesco motore della crescita economica americana può essere nuovamente rimesso in moto.
Riassunto
Il successo dell’America
Immaginiamoci che nel 1620 si fosse tenuta una riunione analoga a quella del Forum Economico Mondiale di Davos, e che il tema dell’incontro fosse: quale Paese dominerà il mondo nei prossimi secoli? La maggioranza avrebbe indicato la Cina, altri l’impero ottomano, altri ancora l’India dei Mogol o l’impero spagnolo; pochi avrebbero puntato sull’Inghilterra, ma nessuno avrebbe menzionato l’America, dato che a quel tempo ci vivevano pochissimi europei, in condizioni durissime, nel New England e in Virginia. L’intero continente nordamericano produceva meno ricchezza del più piccolo principato tedesco.
Oggi invece gli Usa costituiscono la maggiore economia mondiale e, pur contando solo il 5 per cento della popolazione mondiale, producono un quarto del Pil mondiale. L’America domina tutte le nuove tecnologie del futuro, ed eccelle in un’ampia gamma di industrie. L’America è il luogo di nascita del capitalismo popolare e della produzione di massa: mentre in molti paesi il capitalismo viene associato alle élite plutocratiche, in America è sempre stato associato all’apertura e all’opportunità. Nell’immaginario americano, la libera iniziativa permette anche a una persona di oscure origini di scalare i vertici della società e godere quel tenore di vita un tempo riservato solo alle classi elevate.
L’America non ha solo reso prosperi i propri cittadini, ma ha esportato la prosperità sotto forma di innovazioni e idee. Senza il suo intervento nella seconda guerra mondiale, Hitler avrebbe probabilmente soggiogato l’intera Europa. Senza il suo impegno incrollabile nella guerra fredda, gli eredi di Stalin sarebbero ancora al potere nell’Europa orientale e in parte dell’Asia. Lo Zio Sam ha salvato il ventesimo secolo dalla rovina fornendo l’arsenale alla democrazia.
Questo libro racconta la straordinaria storia dell’economia americana degli ultimi quattrocento anni: come tredici piccole colonie sorte in mezzo al nulla diventarono la più potente economia che il mondo avesse mai visto. Questo libro cercherà anche di utilizzare le lezioni della storia per capire se gli Stati Uniti riusciranno a preservare la loro preminenza o se dovranno cedere la loro leadership a qualche altra potenza, quasi certamente meno liberale.
Una repubblica commerciale: 1776-1860
Il termine “colonie” evoca immagini di sfruttamento, ma in realtà l’America coloniale alla vigilia dell’indipendenza era uno dei luoghi più liberi e ricchi della terra. Dal 1600 al 1776 la crescita economica delle colonie americane era stata la più alta del mondo, mediamente il doppio di quella inglese. Gli americani erano anche più prolifici, con una media di sette figli per donna paragonati ai 0quattro o cinque delle donne inglesi. La Dichiarazione d’Indipendenza venne firmata nel 1776, lo stesso anno della pubblicazione della Ricchezza delle nazioni di Adam Smith, e nessun altro paese abbracciò con più entusiasmo i principi della libertà economica contenuti in questo libro. La cosiddetta Rivoluzione americana fu però una rivoluzione a metà, perché conservò tutte le migliori tradizioni della madrepatria inglese, come il governo limitato, la common law e il riconoscimento dei diritti individuali.
La Costituzione americana, ratificata nel 1788, pose dei limiti stringenti al potere della maggioranza, e stabilì che l’intero paese fosse un mercato comune senza barriere e tariffe interne. La solida protezione costituzionale della proprietà e della libertà di scambio fu il fattore principale della futura prosperità americana, molto più dei convenzionali vantaggi materiali come l’abbondanza di terra o di materie prime. Grazie alla libertà d’iniziativa e alla possibilità di conservare interamente i frutti del proprio lavoro, gli americani si dedicarono con passione alle attività produttive.
I visitatori europei erano sempre affascinati dalla frenesia, dal movimento continuo e dall’operosità degli americani. Quando Tocqueville arrivò in Ohio, esclamò che “l’intera società americana è una fabbrica” e che “gli americani mettevano qualcosa di eroico nel loro modo di commerciare”. I viaggiatori europei erano anche impressionati dalla natura integralmente borghese della società americana, tutta concentrata sugli affari e sul denaro. Questa mentalità si esprimeva nell’alta stima cui godevano gli uomini d’affari (businessmen) e in un vero e proprio culto dell’imprenditore. Gli americani credevano che i reali motori del cambiamento storico fossero gli imprenditori innovativi, e che la “distruzione creativa” dei nuovi metodi di produzione che soppiantano i vecchi fosse la molla del progresso sociale.
In molti paesi gli effetti benefici della distruzione creatrice vengono bloccati per via politica dagli interessi costituiti che se ne sentono minacciati. Per gran parte della sua storia, invece, gli Stati Uniti d’America furono immuni da queste pressioni politiche di breve termine. I Padri Fondatori fecero un ottimo lavoro nel proteggere l’economia dalle interferenze politiche, dotando i propri cittadini di diritti inalienabili e vincolando in diversi modi il potere statale. Il gold standard offrì un sistema monetario estremamente stabile, che permise agli Stati Uniti d’America di fare a meno di una banca centrale per 77 anni, dal 1836 al 1913. Inoltre, fino al 1913, non esisteva l’imposta sul reddito. In un ambiente così favorevole, l’iniziativa poteva avere libero sfogo.
Le due Americhe
Diverse culture confluirono nella formazione della nazione americana delle origini: quella dei puritani del New England, dei quaccheri della Pennsylvania e del Delaware, degli anglicani e dei cattolici della Virginia e del Maryland, degli scoto-irlandesi della frontiera. Ma la vera polarizzazione che determinò il corso della storia americana fu quella tra i modernizzatori industriali del nord e gli agrari del sud. La disputa cominciò con un grande dibattito intellettuale, che debordò in rivalità personale, tra Alexander Hamilton, il primo segretario del tesoro americano, e Thomas Jefferson, primo segretario di Stato e terzo presidente. Hamilton voleva che l’America diventasse una potente repubblica industriale; Jefferson preferiva che l’America rimanesse una repubblica agraria decentralizzata formata da numerosi agricoltori indipendenti.
Hamilton intendeva realizzare il suo programma istituendo una banca centrale sul modello di quella inglese, un energico potere esecutivo capace di far applicare le regole del commercio tra gli Stati, e un sistema di tariffe doganali come fonte d’entrata per il governo. Jefferson contestava il tentativo di accumulare il potere nelle mani del governo federale. Gli americani, diceva, non avevano combattuto una guerra contro gli inglesi proprio per prevenire la centralizzazione del potere?
Colui che riconciliò la visione agraria e quella industriale dell’America fu Andrew Jackson, presidente dal 1828 al 1836. Egli non proveniva né dal mondo urbano e borghese di Hamilton, né dal mondo agrario e aristocratico di Jefferson, ma era un figlio della cultura scoto-irlandese della frontiera, e godeva di un’immensa popolarità tra i pionieri, gli artigiani, i commercianti. Nella sua ostilità democratica ai privilegi, Jackson combinò il populismo con un elemento ad esso raramente associato: il conservatorismo fiscale. Egli infatti ridusse il debito federale a zero per tre anni consecutivi (fu la prima e ultima volta nella storia americana), abolì la banca centrale, sostenne il gold standard. Jackson introdusse quindi un nuovo e potente elemento nel dibattito economico americano: il populismo liberista (laissez-faire populism).
L’America rimase però divisa in due sistemi economici differenti: l’economia capitalista del nord e l’economia agraria e schiavistica del sud. La guerra civile che scoppiò tra questi due mondi fu il primo conflitto dell’era industriale, e costò un numero elevatissimo di vittime, tra le 650mila e le 850mila. Il Sud pagò il prezzo maggiore, con la morte del 13 per cento dei suoi uomini in età militare. La vittoria dei nordisti era scontata, dato che possedevano il 70 per cento delle ricchezze del paese e potevano mettere in campo un numero doppio di potenziali soldati. Con la vittoria del nord nella guerra civile, un paese diviso in due diventò un’unica grande repubblica commerciale.
Il trionfo del capitalismo: 1865-1914
Nei decenni compresi tra la fine della guerra civile e lo scoppio della prima guerra mondiale gli Stati Uniti divennero la prima potenza economica del pianeta, con un enorme predominio non solo nelle nuove industrie dell’acciaio, delle automobili, dell’elettricità e del petrolio, ma anche nelle tradizionali attività dell’agricoltura e dell’allevamento: negli anni 70 del XIX secolo proveniva dagli Stati Uniti il 30-50 per cento del grano e il 70-80 per cento della carne commerciata a livello mondiale. In quest’epoca l’America divenne una società consumista, con il maggior numero di milionari (4000 nel 1914). Anche gli operai godevano dei salari più elevati del mondo: nel 1914 il reddito pro-capite degli americani era di 346 dollari, paragonato ai 244 dollari della Gran Bretagna, ai 184 dollari della Germania, ai 153 della Francia e ai 108 dell’Italia.
Nello stesso tempo la popolazione degli Stati Uniti ebbe una crescita fenomenale, passando dai 40 milioni del 1870 ai 99 milioni del 1914. Due terzi di questa crescita demografica era dovuta dall’elevata natalità, che rifletteva l’ottimismo della popolazione riguardo il futuro, mentre un terzo era dovuta all’immigrazione, attirata dalla convinzione diffusa che l’America fosse la terra delle opportunità. Tra il 1870 e il 1900 arrivarono negli Stati Uniti quasi 12 milioni di immigrati.
L’Homestead Act del 1862, che offriva a ogni agricoltore 160 acri di terra a un prezzo simbolico purché l’avesse coltivata per almeno 5 anni, accelerò il movimento verso ovest della popolazione e innescò la grande epopea della Frontiera del West. Nei decenni successivi il governo “privatizzò” più di 270 milioni di acri, circa il 10 per cento di tutta la terra degli Stati Uniti, cedendola a 2,5 milioni di coloni. Mentre nel Brasile neofeudale il governo concedeva enormi appezzamenti di terreno ai latifondisti, nella capitalista America il governo vendette la terra alle persone comuni, a patto che mischiassero il loro lavoro con il suolo. I pionieri e i cow-boy resero più ricca la dieta degli americani, immettendo sul mercato enormi quantità di cereali e di carne. Il pane bianco e la carne a basso prezzo trasformarono questi beni, che in Europa erano ancora generi di lusso riservati ai ricchi, in beni di consumo per le masse.
Ma il settore che più innalzò la prosperità degli americani fu quello delle ferrovie. Dal 1870 in poi le compagnie ferroviarie private aggiunsero più di 13 miglia di binari ogni giorno, tanto che nel 1917 gli Stati Uniti arrivarono ad avere il 35 per cento delle ferrovie esistenti al mondo. Le strade ferrate ridussero enormemente il costo del trasporto delle merci, fino al 96 per cento rispetto al trasporto su carri. Le ferrovie fecero di più che collegare le località isolate e accelerare il trasporto delle merci: spostarono la direzione del traffico dall’asse fluviale nord-sud e viceversa all’asse est-ovest e viceversa. Le persone ora affluivano da est verso ovest, e le merci da ovest verso e est e poi, su nave, verso il resto del mondo. Era come se un gigante avesse applicato una leva a un intero Paese girandolo sul suo asse.
L’epoca dei titani
Negli anni fra il 1865 e il 1914 gli americani misero a punto una serie di innovazioni fondamentali, come l’acciaio, il petrolio, l’elettricità, l’automobile, l’aeroplano, il telefono. I protagonisti furono dei veri e propri giganti di energia e ambizione: John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, J. P. Morgan, Collis Huntington, James Fisk, Jay Gould, Henry Ford. A molti di questi uomini d’affari è rimasta attaccata la definizione di “baroni ladri” (robber barons), ma in realtà non furono né baroni né ladri.
Da un lato furono quasi tutti uomini che si erano fatti da sé partendo da umili origini (self-made men), dall’altro con le loro innovazioni organizzative beneficiarono immensamente i consumatori, sotto forma di colossali riduzioni dei prezzi dei beni: grazie a Carnegie il prezzo dell’acciaio scese da 166 dollari alla tonnellata nel 1867 a 46 dollari un decennio dopo; grazie a Rockefeller il prezzo del petrolio scese da 16 dollari al barile nel 1859 a un dollaro al barile nel 1879.
La rivolta contro il laissez-faire
L’America dell’800 rimase fedele alla libera iniziativa e al governo limitato sia nei fatti sia negli ideali. Nel 1871 il governo federale impiegava solo 51mila persone, delle quali 37000 lavoravano per le poste. Quindi, se escludiamo gli uffici postali, gli americani potevano passare tutta la vita senza alcun contatto con il governo federale. Non esistevano l’imposta sui redditi, la Federale Reserve e i ministeri dell’istruzione, del commercio, ecc. La Casa Bianca aveva ben poco a che fare, tanto che Grover Cleveland (presidente dal 1885 al 1889 e dal 1893 al 1897), fedele ai principi dello Stato minimo, rispondeva direttamente alle telefonate e apriva la porta agli ospiti.
Se escludiamo gli anni della guerra civile, la spesa complessiva del governo a tutti i livelli (federale, statale e locale) tra il 1800 e il 1917 rimase sempre inferiore all’8 per cento del Pil. In altre parole, il settore pubblico estraeva dall’economia solo 8 centesimi per ogni dollaro prodotto, 6 dei quali venivano spesi dal governo locale. La straordinaria crescita dell’economia americana dopo la guerra civile, senza precedenti nella storia umana, ebbe quindi luogo praticamente senza alcuna interferenza da parte di Washington. Alla maggior parte degli americani tutto questo piaceva: secondo l’opinione comune del tempo, tutto quello che occorreva per avere una buona società era una moneta sana e una Dichiarazione dei diritti; il libero mercato avrebbe fatto il resto.
Il generale consenso per il laissez-faire mostrò le prime incrinature a cavallo del nuovo secolo, con l’attacco del populista William Jennings Bryan al gold standard e alle grandi imprese e con l’emergere degli intellettuali progressisti favorevoli a un maggior intervento del governo. In pochi decenni i progressisti cambiarono l’atteggiamento verso il governo: se prima gli americani erano ottimisti verso il business e cinici verso il governo, i progressisti riuscirono a rovesciare l’opinione di molti. Woodrow Wilson, presidente durante la prima guerra mondiale e filosofo-re dei progressisti, affermò che fino a quel momento gli americani si erano impegnati troppo a limitare il governo, e poco a renderlo più efficace: ora bisognava fare l’opposto.
Queste tendenze stataliste coincisero con la chiusura della Frontiera, annunciata con rammarico dallo storico Frederick Jackson Turner nella sua celebre conferenza del 1893. La Frontiera era sempre stata una fonte di energia e ottimismo per gli americani, perché schiudeva un mondo di opportunità illimitate. L’immagine americana per eccellenza era quella delle carovane di pionieri che si spingevano verso l’Ovest in cerca di fortuna. Se l’esistenza della Frontiera aveva alimentato il rude individualismo degli americani, la fine della colonizzazione faceva dell’America una civiltà stanziale, più simile all’Europa.
I ruggenti anni venti
L’America del 1918, alla fine della prima guerra mondiale, era molto differente dall’America dell’800. Aveva acquisito infatti molte caratteristiche delle società moderne dominate dallo Stato: l’imposta sul reddito, la banca centrale, una burocrazia in continua espansione, e un significativo gruppo di persone convinte che lo Stato avrebbe dovuto ulteriormente espandersi. Negli anni Venti, tuttavia, due presidenti repubblicani rimasti fedeli agli ideali della Vecchia America, Warren Harding e Calvin Coolidge, riuscirono ad abolire molte misure prese durante l’era progressista abbracciando un atteggiamento favorevole alla libera impresa.
Degna di nota fu la rapidità con cui gli Stati Uniti uscirono dalla grave depressione del 1920, anno in cui la disoccupazione salì da 2 all’11 per cento. Il governo non intervenne, e l’economia si riprese da sola. Dal 1921 al 1929 il pil americano aumentò del 5 per cento all’anno, una delle più grandi performance storiche di un paese avanzato. Gli Stati Uniti divennero una società opulenta di massa, e migliaia di innovazioni tecnologiche cambiarono la vita delle persone: elettrodomestici, radio, cinema, automobili, ecc. In questo paradiso si annidavano però due serpenti: i debiti eccessivi alimentati dal sistema bancario; e il crescente nazionalismo, che portò a leggi restrittive verso l’immigrazione.
La grande depressione
Nell’ottobre del 1929 improvvisamente la borsa crollò. Ne seguì una lunga e acuta depressione che durò 12 anni. Al suo picco, un quarto della forza lavoro si trovò disoccupata. Il Segretario del Tesoro Andrew Mellon, che aveva lavorato anche sotto le precedenti amministrazioni Harding e Coolidge, suggerì al presidente in carica Herbert Hoover che una politica di non intervento avrebbe permesso un rapido ritorno dell’economia alla normalità, proprio come era successo con la depressione del 1920.
Purtroppo il nuovo presidente credeva fermamente che le moderne economie capitaliste necessitassero della guida attiva del governo. Effetti particolarmente disastrosi sull’economia ebbe l’approvazione della legge Smoot-Hawley nel 1930, che aumentava notevolmente i dazi su centinaia di prodotti agricoli e industriali. A seguito delle rappresaglie degli altri paesi, si verificò un crollo del commercio internazionale: il volume globale degli affari si ridusse da 36 miliardi di dollari nel 1929 a 12 miliardi bel 1932. La legge tariffaria del 1930 divenne un simbolo dell’idiozia economica.
Nel 1932 vinse le elezioni il democratico Franklin Delano Roosevelt, che con il suo fiuto politico si rese conto che fare qualcosa, anche se sbagliato, sarebbe stato meglio che non fare nulla. Il suo massiccio programma di intervento, chiamato New Deal, cambiò per sempre la relazione tra il governo e la società statunitense. Prima del New Deal, l’America aveva una flessibile economia di mercato dove il potere politico era largamente decentralizzato; dopo le riforme di Roosevelt, il governo federale di Washington occupò il centro della scena.
Dal punto di vista economico il New Deal diede risultati molto negativi. Nel lungo periodo le politiche interventiste basate sulla spesa e la creazione di posti di lavoro nel settore pubblico si rivelarono controproducenti. Dopo una lieve ripresa, nell’agosto 1937 il Paese precipitò in una seconda crisi. La “recessione di Roosevelt” fece sì che negli Stati Uniti la Grande Depressione durasse più a lungo che in ogni altro Paese. La prova più evidente del fallimento del New Deal è data dai tassi di disoccupazione, che rimasero elevatissimi per tutti gli anni Trenta: se nell’ultimo anno della presidenza Hoover il 16,3 per cento degli americani erano senza lavoro, nel 1939 questo numero era salito al 17,2 per cento.
Alla disoccupazione si pose rimedio solo con l’entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, quando l’America si trasformò in un immenso arsenale. I consumi del governo, sotto forma di armi, munizioni, carri armati e navi da guerra, si sostituirono a quelli dei cittadini privati, e le grandi fabbriche come la Ford si riconvertirono con grande efficienza alla produzione bellica. La guerra dimostrò la straordinaria potenza produttiva del big business che si era sviluppato dalla fine della guerra civile in poi. Secondo una stima, la produttività oraria del lavoratore americano era due volte quella del lavoratore tedesco e cinque volte quella del lavoratore giapponese. Non sorprende quindi l’esito vittorioso della guerra.
L’età d’oro della crescita: 1945-1970
Alla fine della guerra gli economisti keynesiani come Alvin Hansen avvertivano che, con il taglio delle spese militari, gli Stati Uniti sarebbero entrati in un’era di “stagnazione secolare”. La smobilitazione dell’esercito dopo la vittoria diede invece il via a 25 anni di crescita ininterrotta: dal 1946 al 1973 l’economia crebbe mediamente del 3.8 per cento all’anno e il reddito familiare aumentò del 74 per cento. Il grande ottimismo dell’epoca si manifestò anche nel baby-boom: tra il 1954 e il 1964 nacquero più 4 milioni di bambini ogni anno.
L’America inoltre ricostruì l’ordine internazionale rinunciando alla tentazione di punire gli avversari sconfitti in guerra come era stato fatto a Versailles al termine della prima guerra mondiale. Gli Stati Uniti si resero conto che il proprio interesse a lungo termine consisteva nella rifondazione del capitalismo su scala globale, nel libero scambio, e nell’aiutare la ricostruzione delle economie non solo dei propri esausti alleati, ma anche dei propri nemici.
Stagflazione
Gli anni settanta, all’opposto del periodo precedente, furono un periodo lugubre per gli Stati Uniti. La sconfitta nella guerra del Vietnam scosse la fiducia dell’America; i sovietici avanzavano minacciosamente nel mondo; la Nuova Sinistra portava nichilismo e violenza; i ghetti delle città americane erano sconvolti dalla delinquenza, tanto che alla fine degli anni ’70 il tasso di omicidi raggiunse il record storico.
I semi della crisi erano stati gettati alla metà degli anni ’60 dal presidente democratico Lyndon Johnson, che in quegli anni di euforia aveva aumentato enormemente la spesa pubblica sia per la guerra in Vietnam, sia per nuovi programmi assistenziali di “guerra” interna alla povertà, con risultati fallimentari in entrambi i casi. Il suo successore, il repubblicano Richard Nixon, era stato eletto nel 1968 con un programma conservatore ma, una volta eletto, la sua politica economica fu ancor più interventista di quella di Johnson: dichiarò di essere keynesiano, aumentò ulteriormente la spesa pubblica, nel 1971 uscì dal gold standard facendo lievitare l’inflazione, stabilì un disastroso controllo sui prezzi che provocò scarsità di beni e lunghe file alle pompe di benzina.
Il risultato fu la stagflazione, una combinazione tossica di elevata inflazione e disoccupazione non prevista dai modelli keynesiani. La situazione non migliorò sotto la presidenza del democratico Jimmy Carter, eletto nel 1976. Il triste e pessimista Carter non era l’uomo adatto per rinnovare la società e l’economia americana. Occorreva qualcuno che riaccendesse la fede nella capacità degli imprenditori di far rinascere il capitalismo americano, e quest’uomo era Ronald Reagan.
L’era dell’ottimismo
Reagan fu uno dei più popolari presidenti degli Stati Uniti. Nel 1984 venne rieletto staccando il suo rivale democratico Walter Mondale di quasi venti milioni di voti. Alla fine dei suoi otto anni di presidenza il suo tasso di approvazione era altissimo, tanto che i repubblicani trascorreranno i decenni successivi alla ricerca di un nuovo Reagan. Egli credeva fermamente nella necessità di liberare gli imprenditori dai vincoli del governo. Se negli anni ’30 gli americani si erano rivolti allo Stato perché li salvasse dall’instabilità del mercato, negli anni ’80 si rivolsero agli imprenditori perché li salvasse dal soffocamento statale.
Reagan colse numerosi successi nella sua lotta ai sindacati, all’inflazione, alle tasse elevate e al comunismo internazionale, vincendo di fatto la guerra fredda. La sua politica economica (Reaganomics), basata sulla riduzione delle imposte per le imprese e sulla deregolamentazione, diede risultati notevoli: durante la sua presidenza il pil crebbe di quasi un terzo, l’inflazione scese dal 12 al 5 per cento, la disoccupazione dal 7 al 5 per cento. La deregulation favorì straordinarie innovazioni nel campo tecnologico, finanziario e dei trasporti, soprattutto nel settore aereo. Il suo unico insuccesso fu nel contenimento della spesa e del debito pubblico, che tra il 1980 e il1990 triplicò.
Il suo successore George Bush cercò di ridurre il debito pubblico aumentando le tasse, sconfessando una sua promessa elettorale. Il risultato fu una recessione che gli alienò l’elettorato a favore del democratico Bill Clinton, il quale ebbe molto più successo. Clinton riportò il bilancio in pareggio e abbracciò con entusiasmo la globalizzazione innescata dalla caduta dei regimi comunisti, generando un duraturo boom economico. Negli anni ’80 e ’90 lo spirito imprenditoriale era tornato al centro della vita economica americana, e gli Stati Uniti divennero una fucina d’innovazioni nel campo della finanza, dell’informatica, delle comunicazioni e dell’energia, grazie anche alla rivoluzione del fracking, una nuova tecnica di estrazione petrolifera messa a punto dall’imprenditore George Mitchell. Nel suo discorso di commiato dopo il suo secondo mandato, Bill Clinton usò toni trionfalistici: “Siamo fortunati a vivere in questo momento della storia. Mai prima d’ora la nostra nazione ha goduto, nello stesso tempo, di tanta prosperità e progresso sociale, con così poche crisi interne e minacce esterne”.
La recessione e il tramonto del dinamismo americano
George W. Bush ereditò un paese dall’economia florida e con un surplus di bilancio, ma la sua presidenza si caratterizzò per una serie continua di crisi: il collasso della Enron, l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 con il seguito delle guerre in Afghanistan e Iraq, e la crisi finanziaria globale del 2008. Malgrado il governo fosse riuscito a contenere la crisi meglio che nel 1929, la ripresa successiva sotto Barack Obama si è rivelò debole e incerta. L’America da allora appare sempre meno come una nazione eccezionale, e sempre più come una tipica economia matura sovraccaricata dall’eccesso di governo, con una crescita debole e timorosa del futuro.
Gli Stati Uniti sembrano aver perso il ruggente spirito pionieristico che li ha da sempre contraddistinti. Nel 1850 Herman Melville scriveva: “Noi siamo i pionieri del mondo, l’avanguardia inviata nei territori selvagge a fare le cose mai tentate prima, per aprire un nuovo sentiero nel Nuovo Mondo”. Oggi molti dei discendenti di questi pionieri sono terrorizzati solo a posare il piede su un nuovo sentiero. Il problema comincia nelle scuole, alcune delle quali hanno vietato, per ragioni di sicurezza, di spingere i bambini sull’altalena o di portare la merenda da casa. E continua nei college, dove i professori hanno creato degli “spazi sicuri” per evitare che gli studenti entrino in contatto con idee che potrebbero risultare per loro “offensive”.
La riduzione dei tassi di crescita rispetto al passato è dovuta soprattutto a due cause: l’eccesso di assistenzialismo, dato che il numero delle persone che vivono di sussidi o di pensioni non fa che crescere; e l’eccesso di regolamentazione, che agisce come una tassa sulle due maggiori risorse dell’imprenditore: il suo tempo e la sua abilità nel fare cose nuove. Il maggior costo della regolamentazione è quello di portare alla burocratizzazione del capitalismo, uccidendo così lo spirito d’innovazione imprenditoriale.
La storia del capitalismo americano raccontata in questo libro è essenzialmente una storia di successi. Malgrado tutti i problemi recenti, la maggioranza degli americani non ha mai vissuto così bene come oggi. L’America è sempre riuscita a riprendersi, anche dopo le gravi crisi degli anni ’30 e ’70, e non c’è ragione di pensare che non possa farlo ancora. Tutto ciò che gli serve è di rimettere in moto il processo di distruzione creatrice recuperando il suo tradizionale spirito imprenditoriale.
Citazioni rilevanti
In difesa dei grandi capitalisti
«La principale difesa di questi uomini dal pubblico obbrobrio, comunque, non è che si fecero strada nella vita partendo da zero, o che fondarono opere caritatevoli. Il loro merito fu quello di generare un enorme miglioramento degli standard di vita per tutti. Questi uomini erano geni imprenditoriali che riuscirono con successo a fare degli Stati Uniti uno dei più puri laboratori di distruzione creativa che il mondo avesse mai visto: uomini che compresero che nell’aria aleggiava qualcosa di grande ma ancora informe, e che gli diedero una forma e una direzione, uomini che spremettero il petrolio dalle rocce e che crearono delle macchine industriali dove prima c’era il caos ... Questi titani capirono che la base materiale della civiltà stava cambiando. Carnegie comprese che l’America stava entrando nell’era dell’acciaio, e che l’uomo che avesse fornito il miglior acciaio al minor prezzo sarebbe diventato un Re Mida. Rockefeller comprese che stava cominciando l’era del petrolio. Henry Ford capì che stava iniziando l’epoca della mobilità di massa». (p. 126)
La rivoluzione statalista del New Deal
«Più di ogni altra cosa, Franklin Delano Roosevelt raggiunse l’obiettivo maggiormente ambito dai progressisti: cambiare la relazione tra il governo e il popolo. Prima del New Deal, l’America era stata eccezionale nel suo sospetto verso il big government in generale e il governo federale in particolare: il governo era molto più limitato che nella maggior parte dei Paesi europei e il potere era ampiamente disperso fra tanti livelli sussidiari di governo. Dopo il New Deal, il governo federale divenne il cuore della società americana. In breve: Roosevelt ereditò una politica economica decentralizzata fondata su mercati flessibili e la trasformò in una politica economica dominata da Washington fondata sulla gestione della domanda, su programmi nazionali di welfare, e su negoziazioni collettive e obbligatorie». (p. 251)
L’ascesa del conservatorismo americano del dopoguerra
«L’America venne spostata a destra da un movimento conservatore che odiava lo statalismo. Milioni di americani lessero La via della schiavitù di Friedrich A. von Hayek, almeno nella versione condensata curata dal Reader’s Digest. Gli uomini d’affari sostennero l’American Enterprise Institute, che si trasferì da New York a Washington. L’individualismo celebrato nei romanzi La fonte meravigliosa (1943) e La rivolta di Atlante (1957) della scrittrice Ayn Rand ricevette una grande accoglienza dal pubblico. Perfino a guerra appena conclusa, pur avendo le truppe americane e quelle sovietiche combattuto dalla stessa parte, l’anticomunismo era largamente condiviso dall’opinione pubblica: nel 1946 un sondaggio rivelò che il 67 per cento degli americani era contrario alla presenza di comunisti negli impieghi statali, mentre in un sondaggio del 1947 il 61 per cento degli americani si dichiarò favorevole alla messa fuori legge del Partito Comunista». (p. 277, 278)
Punti da ricordare
- In America il capitalismo è sempre stato associato all’apertura e all’opportunità
- La solida protezione costituzionale della proprietà privata e della libertà di scambio è stato il fattore principale della prosperità americana
- Gli americani credevano che i motori del cambiamento storico fossero gli imprenditori innovativi, e che la “distruzione creativa” fosse la molla del progresso sociale
- Con la vittoria dei nordisti nella guerra civile, l’America industriale del nord prevalse sull’America agraria del sud
- Tra il 1865 e il 1914 gli Stati Uniti divennero la prima potenza economica mondiale
- Le innovazioni dei grandi imprenditori come Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Morgan, Huntington, Fisk, Gould, Ford resero gli americani molto più prosperi
- Per tutto il XIX secolo l’America rimase fedele alla libera iniziativa e al governo limitato, sia nei fatti sia negli ideali
- All’inizio del XX secolo emersero le idee stataliste dei populisti e dei progressisti
- Nei ruggenti anni ’20 il pil americano aumentò del 5 per cento all’anno, una delle più grandi performance storiche di un paese avanzato
- La crisi del 1929 sfociò in una grande depressione a causa delle politiche interventiste di Hoover e Roosevelt
- Nel secondo dopoguerra ci furono quasi 25 anni di crescita ininterrotta
- Lo statalismo di Nixon portò alla stagflazione e alla sfiducia degli anni ‘70
- La politica economica di Reagan ridiede slancio e ottimismo all’America
- Grazie alla globalizzazione, la crescita proseguì anche begli anni ’90 di Clinton
- Dopo la crisi del 2008 il dinamismo dell’economia americano è rallentato
- Per risollevarsi l’America deve rimettere in moto il processo di distruzione creatrice recuperando il suo tradizionale spirito imprenditoriale
Gli Autori
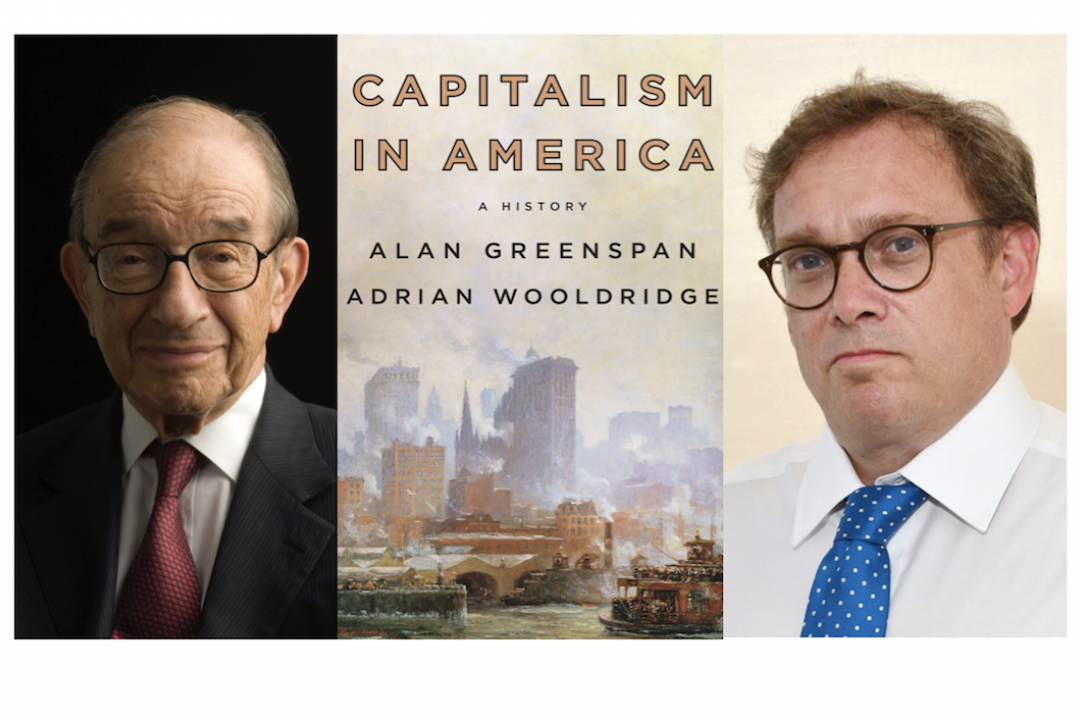
Alan Greenspan è nato nel 1926 nel quartiere di Washington Heights a New York da una famiglia di origine ebraica. Nel 1945 ha frequentato la New York University, dove ha conseguito la laurea in Economia con lode nel 1948, il master nel 1950 e il dottorato nel 1977. Nel 1954 è stato co-fondatore della società di consulenza economica Townsend-Greenspan & Co. Dal 1974 al 1977 è stato consulente economico del presidente Gerald Ford. Nel 1987 il Presidente Ronald Reagan lo ha nominato governatore della Federal Reserve, carica che ha mantenuto fino al suo pensionamento nel 2006. È autore di altri due best-seller: L’età della turbolenza e The Map and the Territory 2.0.
Adrian Wooldridge è nato l’11 novembre 1959 nel Regno Unito. Ha studiato storia moderna al Balliol College di Oxford, dove nel 1985 ha conseguito il dottorato in filosofia. Attualmente è direttore editoriale ed editorialista di The Economist. È co-autore, insieme a John Micklethwait, dei seguenti libri: The Witch Doctors: Making Sense of the Management Gurus (1996), A Future Perfect: The Challenge and Promise of Globalization (2000), The Company: A Short History of a Revolutionary Idea (2003), The Right Nation: Conservative Power in America (2004, trad. italiana: La destra giusta, 2005), God is Back: How the Global Revival of Faith Is Changing the World (2009), The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State (2014). Insieme ad Alan Greenspan ha pubblicato Capitalism in America. A History (2018).
Indice del libro
1 Introduction
29 1. A Commercial Republic: 1776-1860
60 2. The Two Americas
91 3. The Triumph of Capitalism: 1865-1914
123 4. The Age of Giants
150 5. The Revolt Against Laissez-Faire
189 6. The Business of America Is Business
220 7. The Great Depression
273 8. The Golden Age Of Growth: 1945-1970
299 9. Stagflation
326 10. The Age of Optimism
368 11. The Great Recession
389 12. America’s Fading Dynamism
418 Conclusion
451 Appendix: Data and Methodology
457 Acknowledgment
459 Image Credits
461 Notes
475 Index
Vuoi leggere centinaia di riassunti come questo riguardanti i più importanti libri di saggistica? Abbonati a Tramedoro. I grandi libri delle scienze sociali in pillole!



